“Beviamo compagni, mangiamo, godiamocela!
Vi garantisco che di tutte le cose al mondo niente meglio di questa va incontro alle esigenze umane. Tutto il resto infatti ci sfugge, ma sappia ognuno che questo è proprio nostro, che davvero ci appartiene”.
La Catinia, Sicco Rizzi, 1419.
Con questo invito godereccio, apriamo questo affaccio, necessariamente incompleto, sul vino nella vita e nell’arte del Rinascimento e prima Età Moderna.
Sicuramente era ancora consumato quotidianamente, come sempre nel passato. Un vino leggero o allungato con acqua faceva parte dell’alimentazione quotidiana per tutti, bevanda più sicura dell’acqua contaminata di allora. Quello un po’ più concentrato era per il piacere, passando da quelli appena bevibili delle classi più basse fino a quelli raffinati di nobili e signori.
In questa epoca iniziò a costruirsi però una sorta di cerimoniale intorno al vino: si iniziava a studiarlo, a cercare i migliori abbinamenti col cibo, come servirlo, … Tutto questo, che per noi è normale, nacque nelle splendide corti rinascimentali italiane. Verrà imitato dalle altre classi sociali, oltre che esportato in tutta Europa.
Il vino e la vita di corte
Il vino di un certo pregio, da sempre appannaggio delle classi sociali più alte, fece un importante salto di qualità nei fastosi banchetti dei signori italiani del tempo: i Gonzaga a Mantova, gli Sforza a Milano, i Medici a Firenze, gli Estensi a Ferrara, la corte pontificia e il ducato di Urbino, … Abbiamo numerose testimonianze letterarie ed artistiche dei loro fastosi banchetti. La magnificenza di quelli dei Medici era leggendaria.
Il banchetto rappresentava un momento importante della vite di corte e della diplomazia. Ogni elemento era parte di una rappresentazione scenografica accuratamente studiata, tesa a mostrare agli illustri ospiti la potenza e la magnificenza del Signore, espressa con raffinatezza e gusto. Qui si svolgevano conversazioni colte, si doveva saper sfoggiare le buone maniere con grazia e disinvoltura. Tutti conoscono a questo proposito il famoso trattato “Il Galateo”, scritto da Giovanni della Casa (1552), che ebbe un successo strepitoso in tutta Europa. A proposito del vino, l’autore consiglia un consumo moderato, perché al cortigiano poco si addice l’ubriachezza, deve mantenere tutto il suo controllo. Depreca invece la moda del brindisi, che arrivava allora dall’estero, che l’autore ritiene poco elegante:
“Lo invitare a bere (…) cioè far brindisi, è verso di sé biasimevole, e nelle nostre contrade non è ancora venuto in uso, siché egli non si dee fare. E se altri inviterà te, potrai agevolmente non accettar lo ’nvito, e dire che tu ti arrendi per vinto, ringraziandolo, o pure assaggiando il vino per cortesia, senza altramente bere”.
I banchetti resero la ricerca ed il servizio del vino di pregio una sorta di cerimonia, con servitori e dignitari dedicati esclusivamente ad essa. Nel ‘500, ad esempio, alla corte dei Savoia si introdusse il sommelier de corps, in altre corti detto bottigliere, che si occupava solo della selezione dei vini da acquistare, del loro approvvigionamento, della scelta per le diverse occasioni e negli abbinamenti ai cibi. Il coppiere era invece responsabile del servizio del vino, allungava con acqua, vigilava che nessuno aggiungesse veleni alla coppa. Ci sono trattati che ne descrivono le capacità, l’aspetto, il vestiario, la gestualità, il lato da cui doveva avvenire il servizio, ecc. Nacque una figura che si è trasformata nel tempo, fino ai moderni sommelier.

I fastosi banchetti non esaltavano solo il vino ma anche il cibo, l’abbinamento fra di essi, oltre che la scelta dei bicchieri più adatti ad ogni tipologia. In questa epoca furono posti i capisaldi della grande cucina classica. Su questi argomenti, ricordiamo l’opera di Domenico Romoli, la “Singolar dottrina” (1560) e tante altre.
Non c’era solo il piacere. La vita di chi lavorava dietro a tali banchetti non era di certo facile, compresa quella dei cortigiani che formavano il seguito dei Signori. Enea Silvio Piccolomini, che poi diventerà papa Pio II, ma che allora era un semplice cortigiano, racconta in una famosa lettera (De curialium miseriis, 1571) la vita precaria e difficile di chi svolgeva questo ruolo, compresa la noia dei lunghi cerimoniali e della rigida etichetta del tempo. Descrive in particolare la sofferenza di dover assistere per ore ai lunghi banchetti dei signori, patendo la fame, sentendo i profumi dei cibi sopraffini e dei grandi vini che questi consumavano in stoviglie raffinate. Lamenta il confronto impietoso con i pasti dei cortigiani, che potevano consumare solo alla fine di queste lunghissime giornate, in locali luridi, con cibi di scarsa qualità, accompagnati da vini annacquati e cattivi, serviti in vecchi calici di legno, troppo caldi o troppo gelati …
I grandi libri di enogastronomia
L’attenzione per vino e cibo fece crescere sempre più il numero dei testi di enogastronomia. La prima testimonianza di questo genere in Europa risaliva al 1230-1250, col napoletano “Liber de Coquina”. Fra il Trecento e il Quattrocento furono scritti molti Theatra o Tacuina, cioè trattati che nascevano dagli erbari monacali e dalle norme igienico-sanitarie, ma che poi si dedicavano anche a parlare di cibo e vino, quest’ultimo proposto anche per un consumo terapeutico e corroborante.
Nel Rinascimento continuò in parte il gusto medievale per i cibi molto speziati e piatti agrodolci, con portate che alternavano arrosti e cacciagione con cialde e marzapane, pasticci di carne e verdure alternati con zuppe, torte e panna … I gusti però iniziavano a cambiare. Il testo che segnò il passaggio ad una gastronomia più vicina alla nostra fu il “Libro de arte coquinaria” (1456) del Maestro Martino de Rossi da Como, cuoco del signore di Aquileia, Lodovico Trevisani. Ebbe un enorme successo in tutta Europa e fu fra i più copiati. Iniziava a separare un po’ i sapori nei piatti, oltre che proporre l’importanza di usare materie prime genuine. Rinnovò le ricette classiche del tempo, iniziò ad usare termini che sono arrivati fino a noi, come biancomangiare e salsa verde. Un aspetto per noi curioso è che indicava il tempo di cottura dei cibi col tempo necessario a recitare un certo numero di preghiere. Un altro celebre autore dell’epoca è Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, col suo testo di enogastronomia De honesta voluptade et valetudine (1474). Soprattutto è molto moderno nello scrivere che una buona alimentazione è utile anche per mantenersi in buona salute, insieme alla necessità di fare esercizio fisico e un buon sonno. Il vino, oltre che nelle ricette, compare in un capitolo dedicato, nel quale l’autore di fatto riprende gli scritti di autori romani.

Dedicato solo al vino è il testo di Sante Lancerio, bottigliere del papa Paolo III Farnese, che ci ha lasciato delle vere e proprie recensioni dei vini dell’epoca. Nella sua opera racconta e giudica 53 vini, descrivendone le caratteristiche sensoriali dei prodotti assaggiati, la provenienza geografica, le quantità prodotte, le modalità migliori di consumo, gli abbinamenti col cibo, … Descrive quella che diventerà la progressione classica del servizio dei vini, con quelli bianchi leggeri ad inizio pasto, i rossi più robusti per gli arrosti, fino a quelli dolci ed intensi per il dessert. Chiudeva il pranzo una sorta di amaro, un vino aromatizzato con erbe e spezie, detto Ippocrasso. Oggi ci sembrano aspetti scontati, ma allora erano novità.
Ecco alcuni esempi delle sue descrizioni:
Trebbiano: Il trebbiano viene a Roma dallo Stato fiorentino di Valdarno di sopra e da molti altri luoghi, ma li migliori sono quelli di S. Giovanni et Figghine. La maggior parte si porta in fiaschi con le ceste, et ne vengono anche alcuni caratelli. Questa tale sorta di vino è un delicato bere, ma non a tutto pasto per essere vino sottile. Non di colore acceso, ma dorato, di odore non troppo acuto, amabile, non dolce, non agrestino, anzi habbi del cotognino. Erano molto grati a S.S. (Sua Signoria, cioè il papa) ma non a tutto pasto; volentieri li bevea nello autunno, fra nuova et vecchia stagione.
Greco di S. Gemigniano: È una perfetta bevanda da Signori; et è un gran peccato che questo luogo non ne faccia assai. S. Gemigniano è una terra grandissima nello stato fiorentino. Di questo vino ogni anno, nell’autunno, ne facevano portare in Roma, a some con grandissime fiasche, i Reverenti Santiquattro di casa Pucci e li donavano a S.S. Il vino ha in sé perfettione; in esso colore, odore, sapore, ma, volendo conoscere il buono non vuole essere agrestino, anzi avere del cotogno, come il Trebbiano, et sia maturo, pastoso et odorifero. In questo luogo ci sono anche di buonissime vernacciuole e di questa bevanda gustava molto S.S. et faceva honore al luogo.
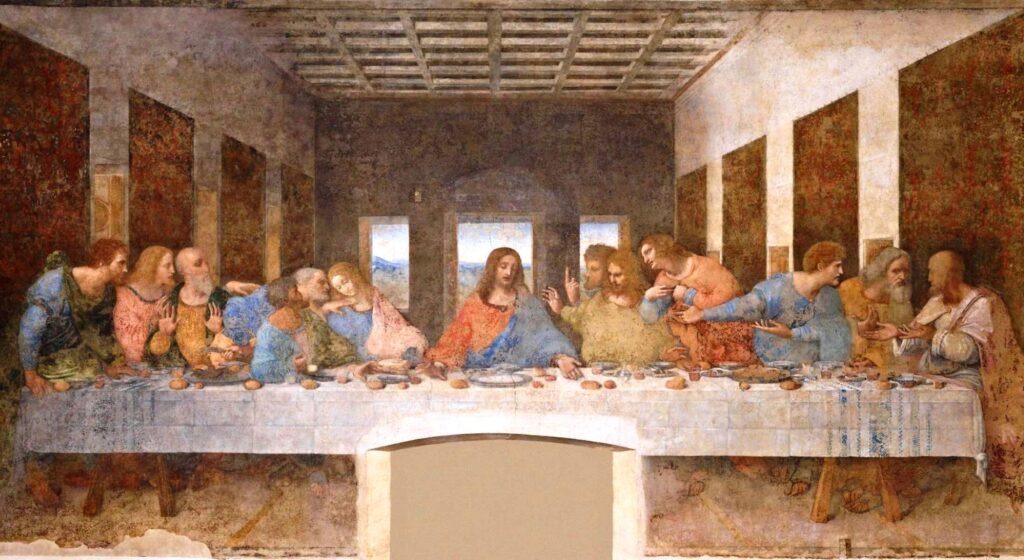
Un altro autore che ci ha lasciato una ricca descrizione di vini dell’epoca è Andrea Bacci, medico del papa Sisto V e naturalista, che scrisse nel 1596 il De naturali vinorum historia. Questo è un trattato molto più ricco del precedente, con descrizioni dei vini nell’antichità, le modalità di produzione e la descrizione dei vini della sua epoca. Il suo percorso enologico in Italia è molto critico: tolti alcuni vini di qualità, ci dice che la larga maggioranza era mediocre. La maggioranza dei vini facevano fatica ad arrivare alla fine dell’estate. Spesso faticavano a sostenere il trasporto fino a Roma.
Tuttavia, l’elemento considerato più dirompente dell’opera di Bacci, anche se oggi non è per nulla ricordato, è che fu il primo autore dopo l’epoca Romana ad esprimere in modo compiuto il concetto di vino di territorio, cioè che esso trova la sua identità nel suo ambiente di provenienza, non solo in senso geografico ma anche antropico, in rapporto alla cultura, alla storia e alla tradizione del territorio. Questo concetto, che è da sempre il caposaldo della produzione del vino in Italia (e in tutta Europa), nato con i Romani, sarà approfondito ed esplicitato solo nella seconda metà del Novecento, quando verrà posto alla base delle Denominazioni moderne, identificato col termine terroir (o genius loci).
Il vino nella letteratura, dallo stoicismo degli Umanisti ai grandi maccheronici.
Il Medioevo è ricordato soprattutto per i canti e le opere goderecce, mentre gli Umanisti rinascimentali non dedicarono molto spazio al vino. L’Umanesimo puntò a toni molto elevati, con la ricerca di valori morali e civili, esaltando le virtù cristiane e la poca dipendenza dai piaceri terreni. Riscoprirono la grande cultura classica ed i loro riferimenti romani preferiti erano quelli colti di Cicerone o dei grandi filosofi stoici come Seneca. Un esempio è rappresentato da Francesco Petrarca che, in una celebre lettera indirizzata al medico ed amico Giovanni da Padova, condanna in modo molto fermo il consumo del vino ed i suoi eccessi (Res Seniles, XII, 1), decantando invece la superiorità di bere acqua. Cito questa lettera perchè, come vedrete di seguito, sarà anche presa in giro da autori più gogliardici e meno raffinati.
Come detto, il Rinascimento fu il momento in cui fu riscoperta ed esaltata la cultura classica. Bacco ispirò moltissimi artisti, come Michelangelo Buonarroti con la sua famosa statua marmorea di cui vedete qui sotto un particolare (1496-1497). Non sono però opere goderecce. Il vino spesso rimane solo sullo sfondo o nella coppa che il dio solleva, attributo necessario per riconoscerlo.

Nel celebre canto carnevalesco di Lorenzo il Magnifico, “Bacco e Arianna” (1490), al centro c’è il tema del “carpe diem” classico, con la celebrazione della bellezza e della giovinezza che fuggono. L’ebrezza è solo quella buffa di Sileno:
Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Quest’è Bacco e Arïanna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ’l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza. …Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Ciò c’ha a esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Eppure, in buon latino, alcuni illustri umanisti scrissero anche storielle umoristiche, come il toscano Francesco Poggio Bracciolini. Pur essendo segretario apostolico, si divertì a scrivere le Facezie (1438-1452), motti arguti e sboccati in linea col suo conterraneo Boccaccio. Ne il De potatore (“Di un Bevitore”), ad esempio, racconta di un famoso bevitore di vino che, colto dalla febbre e preso dall’arsura, chiede ai medici di curargli il male ma non la sete, alla quale ci avrebbe pensato da sé. Tradotto dal latino:
“Un famoso bevitore di vino fu preso dalla febbre, per la quale gli si aumentò la sete; vennero i medici e discutevan sul modo di toglier la febbre e la straordinaria sete: “Solo della febbre, disse il malato, voglio che voi vi occupiate, chè quanto a curar la sete, quello è affar mio.”
Battista Spagnoli, detto il Mantovano, (1447-1516), nell’Egloga IX della sua maggiore opera (Bucolica seu adolescentia in decem aeglogas divisa) scritta in latino intorno al 1480, descrive il vino come un modo per curare i mali dell’anima, che rinforza il corpo così come le amicizie. Riprende un tema caro ai carmina medievali, dove si elenca ogni bevuta, col settimo bicchiere che trionfa sul bevitore. Oggi è poco conosciuto ma all’epoca ebbe grande fama. Fu proclamato da Erasmo di Rotterdam il Virgilio cristiano.
Non mancano comunque le opere ancora più “basse” e goderecce, come la citazione che ho messo all’inizio, dalla commedia “La Catinia” (1419) di Sicco Rizzi, detto Polenton. Cambiano decisamente i toni, ma ha in comune con Lorenzo il Magnifico il tema malinconico della fragilità umana, con l’imperativo di godersi il presente. Nell’opera si narra di un venditore di contenitori che finisce in un’osteria piena di allegri bevitori, dove si apre una disputa su cosa abbia senso nella vita. Domina il tema del vino e della vita gaudente. L’acqua è nemica dell’uomo, fa male allo stomaco e rende stupidi, mentre il vino dona eloquio e rende l’uomo combattivo ed audace. Qui il latino è volutamente mescolato col volgare, in un linguaggio spiritoso usato nelle opere satiriche e parodistiche fin dal Medioevo, che prese poi il nome di maccheronico.
“Bibamus, comedamus, gaudeamus …”
“Beviamo compagni, mangiamo, godiamocela! Vi garantisco che di tutte le cose al mondo niente meglio di questa va incontro alle esigenze umane. Tutto il resto infatti ci sfugge, ma sappia ognuno che questo è proprio nostro, che davvero ci appartiene”.

Il capolavoro della letteratura detta “carnevalesca” e del linguaggio maccheronico è il Baldus (1552) del padovano Merlin Cocai, pseudonimo di Teofilo Folengo, che influenzerà moltissimo la letteratura europea, come il più famoso autore François Rebelais (“Gargantua”).
Pur raccontando una sorta di poema epico-cavalleresco, ne rappresenta la parodia. Sembra sempre iniziare ogni discorso con insegnamenti morali e costruttivi, che poi vengono deformati e presi in giro in modo spiritoso. Ad esempio, sembra che esalti la sobrietà degli uomini dell’Età dell’Oro e dei monaci del deserto, per poi descrive orge di cibo e vino. Descrive il banchetto del re di Francia, preparato dal cuoco Gambone, maestro dell’arte “pappatoria”, con un elenco infinito di selvaggina, salse, salsicce, lasagne, ostriche, torte, pasticcini e fiumi di vino, che servono a “spegnere la fiamma con la fiamma”. Qui usa le stesse parole del Petrarca nella famosa lettera in cui fa le lodi dell’acqua. Si permette però di prenderlo un po’ in giro, girandole al contrario, per esaltare il piacere del vino.
Nel proemio (l’introduzione) non chiede aiuto alle classiche Muse per l’ispirazione, come era d’uso, ma alle “dee grasse”, Muse inventate da lui, che lo devono aiutare ingozzandolo di cibo e vino. Ecco entrare in ballo i maccheroni, dai quali è nato il termine di linguaggio “maccheronico”.
Phantasia mihi plus quam phantastica venit
historiam Baldi grassis cantare Camoenis.
Altisonam cuius phamam, nomenque gaiardum
terra tremat, baratrumque metu sibi cagat adossum…….
Mi è venuta l’ispirazione più che bizzarra di cantare la storia di Baldo, con l’aiuto delle grasse Camene. La sua fama e il suo nome gagliardo fan tremare la terra, e al sentirlo l’inferno se la fa addosso dalla paura.
Ma prima mi occorre invocare il vostro aiuto, o Muse che effondete l’arte maccheronica. Potrebbe forse la mia barchetta superare gli scogli del mare, se non sarà raccomandata dal vostro aiuto?
Mi dettino i versi non Melpomene, non quella minchiona di Talia, non Febo che strimpella la chitarrina; infatti, quando penso alle budella della mia pancia, le chiacchiere del Parnaso non sono adatte alla nostra zampogna. Solo le Muse pancifiche, le dotte sorelle (Gosa, Comina, Striace, Mafelina, Togna, Pedrala) vengano ad imboccare di maccheroni il poeta, e gli diano cinque o otto catini di polenta. Queste sono quelle dee grasse, quelle ninfe sgocciolanti, la cui dimora, la cui regione e territorio son racchiusi in un angolo remoto del mondo, che le caravelle spagnole non hanno ancora scoperto.
…

Ci sarebbe un numero infinito di citazioni ma non possiamo metterle tutte. Il grande poema seicentesco italiano del vino è senza dubbio quello dell’aretino Francesco Redi “Bacco in Toscana” (1685). Qui il linguaggio è il toscano, cioè quello che diventerà l’italiano, per cui lo possiamo leggere direttamente, anche se usa termini e prosa per noi arcaici. Questo poema giocoso, al di là del valore letterario, è interessante perché elenca i vini prodotti in Toscana all’epoca, oltre che citare altri vini italiani, come alcuni campani (il Falerno, la Tolfa, la Verdea, la Lacrima di Vesuvio, ecc.). Nel poema descrive 57 tipologie di vini, arrivando a definire come re di tutti il Montepulciano (il Redi era di Arezzo).
Ricordo che in Toscana questa forte connotazione territoriale per i vini era già presente dal Medioevo. Questa sensibilità porterà infatti, ad inizio Settecento, alla nascita in Toscana delle prime indicazioni territoriali al mondo: Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno.

È divertente leggere come depreca le nuove bevande che arrivavano dal nord o dell’Oriente, come la birra (cervogia), il sidro, la cioccolata (cioccolatte), il tè ed il caffè:
Chi la squallida Cervogia
alle labbra sue congiunge
presto muore, o rado giunge
all’età vecchia e barbogia:
beva il Sidro d’Inghilterra
chi vuol gir presto sotterra;
chi vuol gir presto alla morte
le bevande usi del Norte
…
non fia già, che il cioccolatte
v’adoprassi, ovvero il tè,
medicine così fatte
non saran giammai per me:
beverei prima il veleno,
che un bicchier che fosse pieno
dell’amaro e reo caffè
Per il vino spende ben altre parole, ricordandoci che ci rinfranca nella vita e ci fa dimenticare i problemi. Riprende anche un celebre verso di Dante, nel quale il vino è indicato come figlio del sole:
Se dell’uve il sangue amabile
non rinfranca ogn’or le vene,
questa vita è troppo labile,
troppo breve, e sempre in pene.
Sì bel sangue è un raggio acceso
di quel Sol, che in ciel vedete;
e rimase avvinto e preso
di più grappoli alla rete.
…
La vigna che ci dona tali piaceri è benedetta. L’autore invoca che non sia colpita dalle intemperie, che la natura la culli dolcemente, così che il suo proprietario in vecchiaia potrà godere in abbondanza del vino prodotto:
Manna dal ciel sulle tue trecce piova,
vigna gentil, che questa ambrosia infondi;
ogni tua vite in ogni tempo muova
nuovi fior, nuovi frutti e nuove frondi;
un rio di latte in dolce foggia, e nuova
i sassi tuoi placidamente innondi:
né pigro giel, né tempestosa piova
ti perturbi giammai, né mai ti sfrondi:
e ‘l tuo Signor nell’età sua più vecchia
possa del vino tuo ber colla secchia.

Bibliografia:
Piero Stara, Il vino
SIMONA GAVINELLI Gli umanisti e il vino
Luca Tosin, dalla vite al vino attraverso l’iconografia dei libri a stampa del cinque-seicento