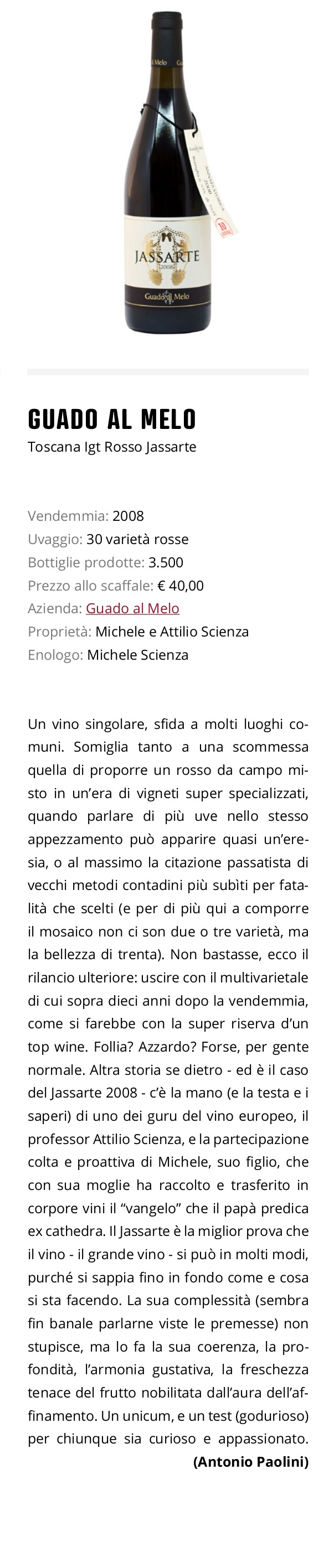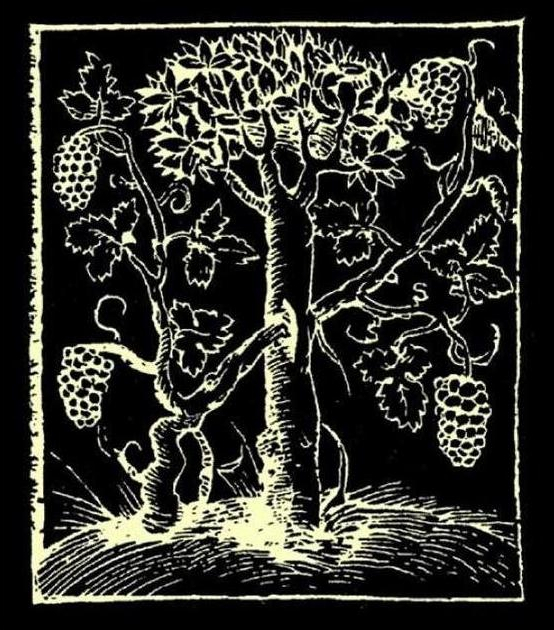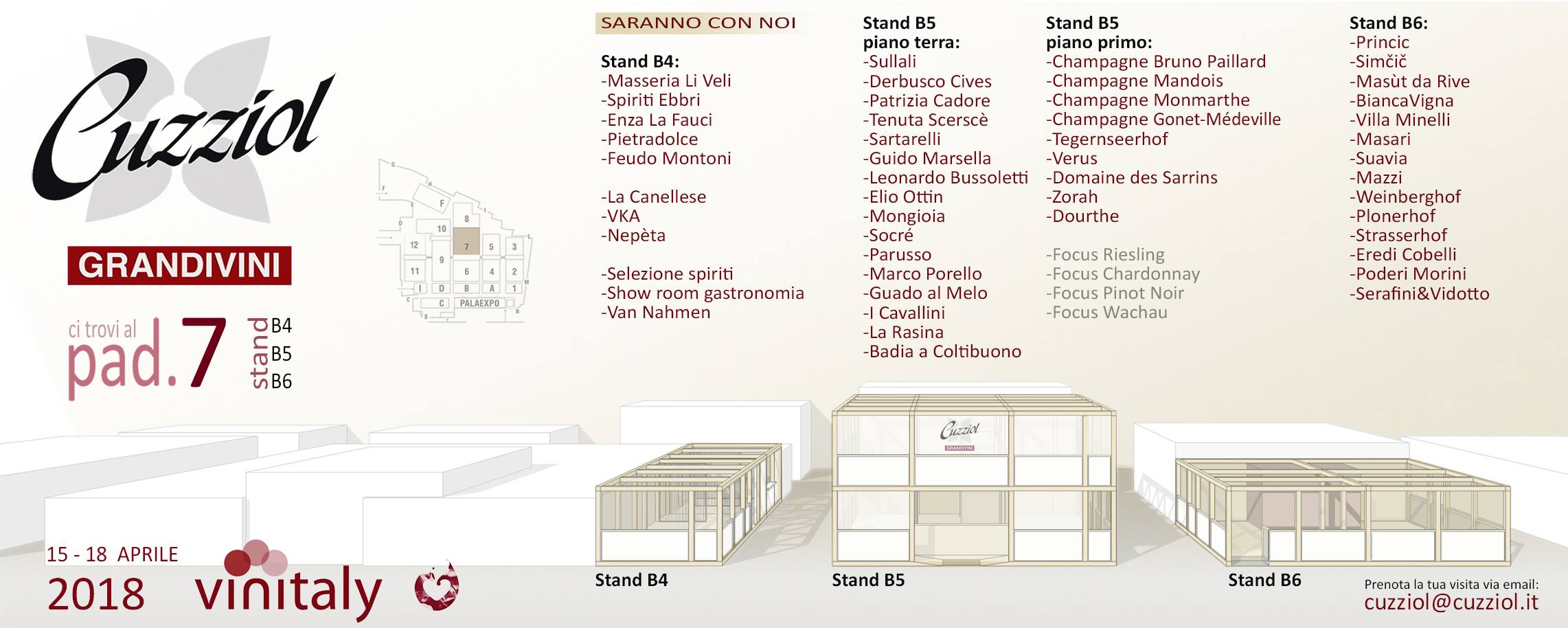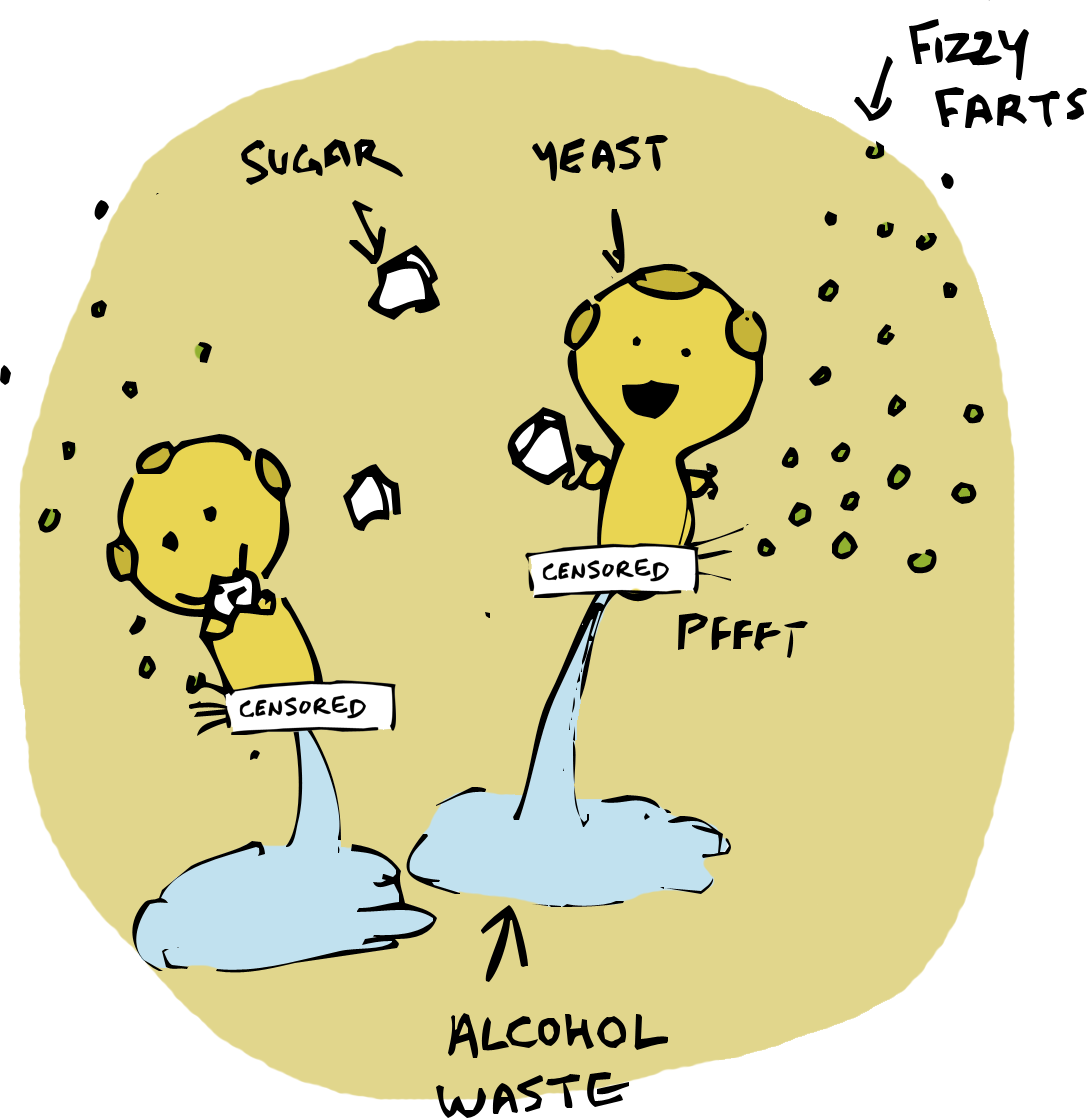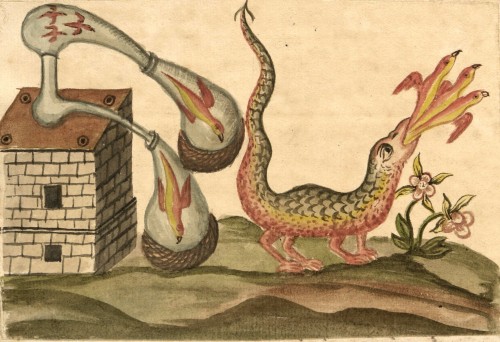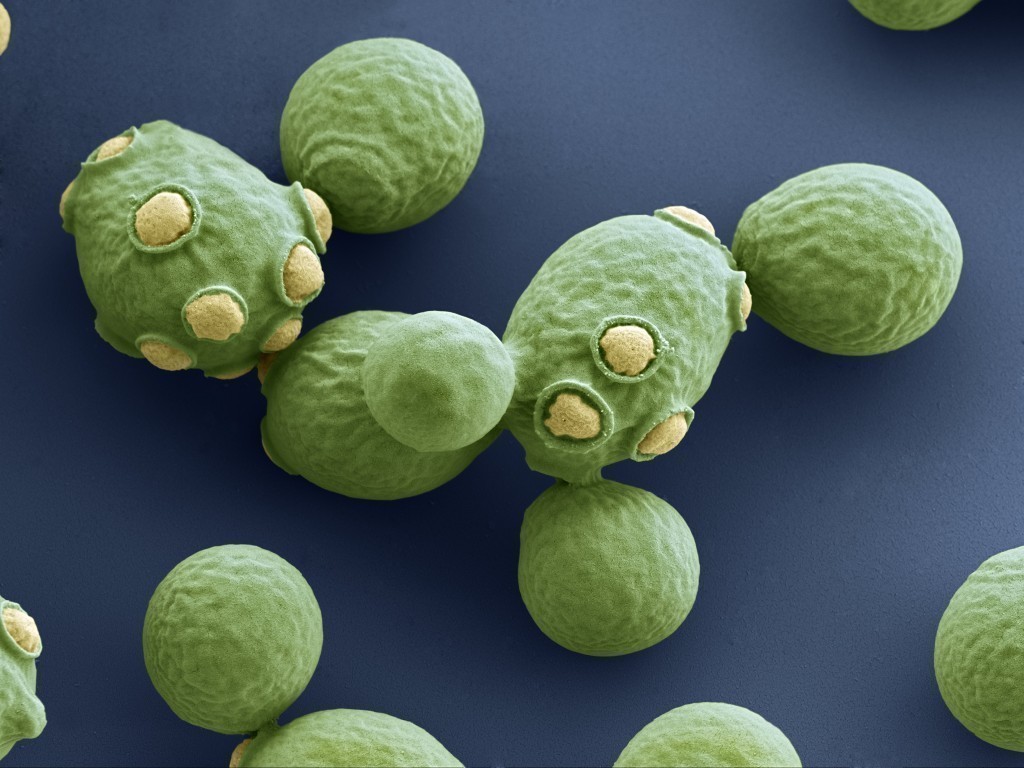Nuova annata Jassarte 2015
Dopo una lunga attesa, è finalmente pronta la nuova annata del nostro grande Jassarte, dalla vigna Campo Giardino, complantazione di diverse varietà rosse. Il 2015 è stata un'annata molto interessante, di grande equilibrio, che ci ha "consolato" da un 2014 difficile, nel quale avevamo deciso che non ci fosse la qualità sufficiente per un vino di questo livello.
Il 2015 ci ha riservato invece un grande vino. Dal colore intensissimo, come suo solito, qui diventa quasi tenebroso. Gli aromi sono complessi e cangianti, ma spiccano soprattutto la ciliegia, il cardamomo, l'incenso, il tabacco ed il cioccolato. In bocca è molto vellutato e pieno, anche se sempre verticale ed equilibrato, di notevole lunghezza.
Non vi resta che assaggiarlo!
Ecco la scheda tecnica, per gli interessati.
Season's Greetings Auguri!
Saremo chiusi per ferie dal 22/12/18 al 06/01/19 compresi.
We’ll be on holiday from 22/12/18 to 06/01/19.
Gli Etruschi e il vino IV: il vino nella vita sociale e religiosa
“Essi abitano in una regione che produce di tutto e, impegnandosi nel lavoro, hanno frutti con cui possono non solo nutrirsi a sufficienza, ma anche concedersi una vita di piaceri e di lusso” Diodoro Siculo (I sec. a. C.).
Dopo aver parlato degli Etruschi come primi vignaioli, della loro viticoltura e della produzione, come erano i vini Etruschi?
Quello che sappiamo c’è arrivato attraverso gli scritti, spesso a posteriori, di autori Romani. In generale erano molto apprezzati. Ad esempio, Marziale ed Orazio elogiano il Massico (dell’area campana di cultura etrusca). Viceversa, denigrava il rosato di Veio. Certi giudizi negativi sono però da prendere con cautela, perché espressi in un momento storico in cui gli Etruschi erano in forte decadenza, ormai soggiogati dall’Impero Romano. Più tardi Columella (I sec. d.C., nel “De re rustica”) elenca alcune delle varietà dell'Etruria, numerose indigene ed altre d’importazione, come il Pompeiano o Murgentino. Plinio il Vecchio ricordava diversi vitigni aretini, come la Talpona nera (vinificato in bianco), l’Etesiaca, la Conseminea (per il consumo da tavola), la Sopina o Tudemis o Florentia, la Perusinia (uva nera). La Pariana è invece indicata nel territorio di Pisa. L’Apiana era un uva moscato da cui si ricavava un buon vino dolce. I vini di Gravisca (l’antico porto di Tarquinia) e di Statonia sono descritti come eccellenti.

Sappiamo di più su come li consumavano. Sembra che rituali legati al vino fossero già presenti in Etruria fin dalla fine dell’età del Bronzo. Tuttavia, il contatto con la cultura greca segnò una profonda evoluzione. Il vino si legò in modo più profondo alla dimensione religiosa ed veniva utilizzato in modo collettivo nelle celebrazioni agli Dei e nelle cerimonie funebri. La maggior produzione lo rese anche più disponibile e così divenne protagonista dei riti sociali, i banchetti ed i simposi (momenti dopo la cena, in cui si beveva vino, assistendo a spettacoli di musica e danza, con conversazioni e giochi). I meno abbienti probabilmente consumavano anche loro un vinello leggero, derivato dal ripasso con acqua delle vinacce, pratica frequente anche in epoca Romana e fino all'Ottocento.
La prima forma di banchetto, che segna il passaggio dalla “barbarie” a forme di civiltà più evolute, è quella seduta, come rappresentato sul vaso di Montescudaio. Comparve in Etruria almeno dall’inizio del VII sec. a.C., dall’influenza della cultura greca. Secondo questi modelli dello status aristocratico, il banchetto non avviene più in modo barbaro e scomposto, ma stando seduti di fronte ad una tavola. Dal VI sec. a.C., sempre da modelli culturali greci, si introdusse la figura del banchettante semi sdraiato sul letto conviviale, col gomito appoggiato ad uno o più cuscini. Su ciascun letto trovavano posto due o tre persone. Davanti a ciascuno erano sistemati tavolini bassi, per il cibo e le coppe di vino.
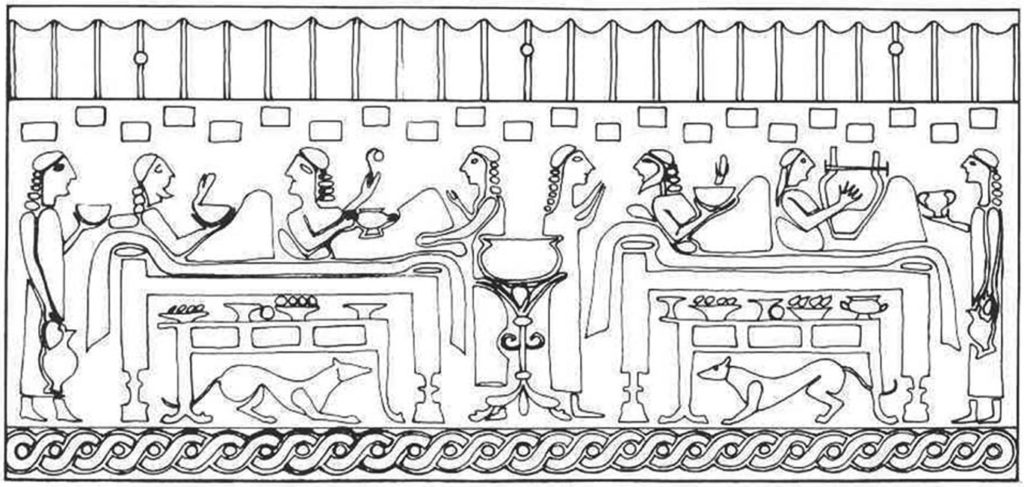
Una caratteristica tipicamente etrusca è la presenza delle donne ai banchetti, rappresentate dopo il 500 a.C., a volte adagiate accanto all’uomo e, più tardi, sedute vicino. Nel mondo greco il simposio era invece solo maschile o al più aperto alle etere (prostitute di alto livello). I greci (e i romani delle origini) consideravano questa presenza come un segno di corruzione morale. In realtà la donna, nel mondo etrusco, beneficiava di una considerazione civile e sociale ben diversa dal ruolo subalterno del mondo greco-romano. Al banchetto prendevano parte coppie sposate, ritratte nei sarcofagi o sugli affreschi come simbolo di unità famigliare. 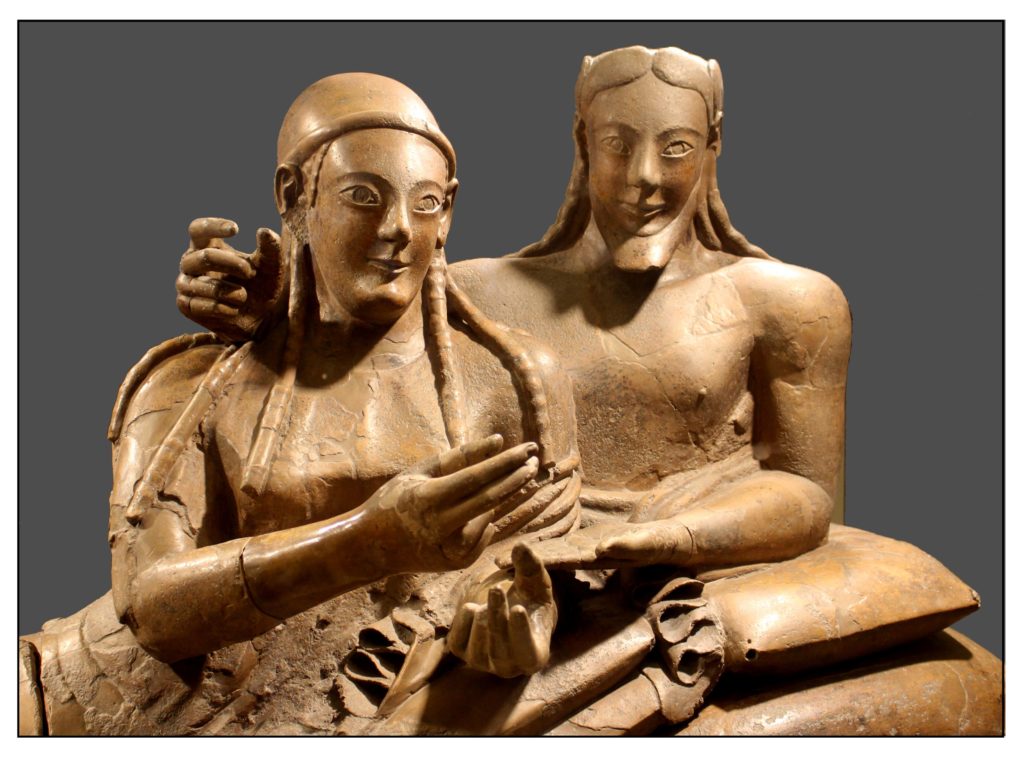
I commensali mangiavano con le mani, pulendosi spesso con ciotole d’acqua profumata e tovaglioli. Nella sala scorrazzavano animali domestici (cani, gatti, polli, anatre...), che mangiavano i resti di cibo che cadevano (o erano buttati) a terra. Il banchetto era sempre accompagnato da musica, soprattutto dai flauti. Ci potevano essere anche spettacoli di danza e di giocolieri. Si giocava anche: ai dadi o con la tabula lusoria (una specie di scacchi o dama). Il kottabos, arrivato dalla Sicilia greca, consisteva nel centrare un bersaglio con le ultime gocce di vino rimaste nella coppa.
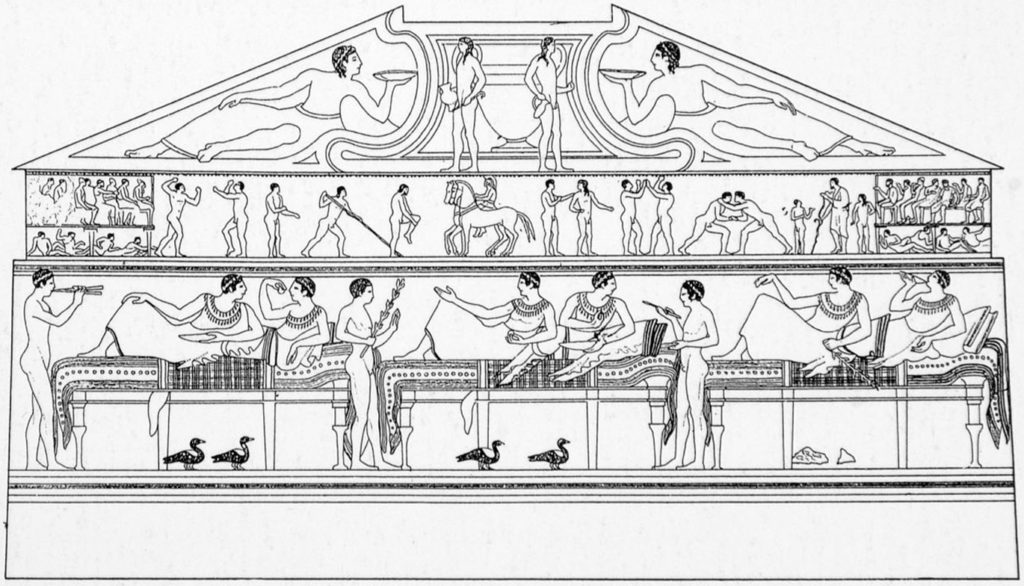
In autori greci e romani si trovano accuse morali rivolte al grande lusso dei banchetti etruschi, dove si esibivano vasellame pregiato, preziosi tessuti ricamati, col servizio di numerosi servi. C’è chi riporta, scandalizzato, che addirittura banchettavano due volte al giorno (l’uso comune dei tempi antichi, sia presso i Greci che i Romani, era che a pranzo si consumasse un pasto molto veloce e frugale). Alcuni autori romani definivano gli etruschi “schiavi del ventre” (gastriduloi), tanto che era popolare l’immagine dell’Etrusco obeso diffusa da Catullo. Di nuovo, prendiamo queste critiche con le dovute cautele: gli Etruschi furono a lungo nemici di Roma, prima di esserne conquistati. Tuttavia quest'immagine non presentava accezioni solo negative, visto che nella cultura antica l’individuo “grasso” era colui che poteva permettersi di diventarlo, cioè era un simbolo di grande ricchezza e potere.
Come si beveva il vino allora?
Il vino, in antichità, era molto alcolico e concentrato. Ai banchetti e ai simposi (sempre per influenza greca) era diluito con acqua, perché era considerato da barbari perdere il controllo in società. Veniva anche aromatizzato ed addolcito, pratiche comuni nel passato antico e medievale, per coprire i difetti dovuti alle limitate tecniche produttive e di conservazione.
I vari oggetti usati per il vino e la tavola erano in ceramica o bronzo. Per essi gli archeologi usano i nomi greci perché il nome etrusco è spesso sconosciuto oppure incerto.
Al centro della sala, su un tavolo di servizio, era posto il cratere per il vino (krateres), un vaso in ceramica riconoscibile dalla larga imboccatura. A fianco c’era una grossa anfora (hydria) per l’acqua, la quale era servita anche a tavola in piccoli secchi (situla).
Il vino era portato in sala nelle anfore di conservazione e mescolato nel cratere con acqua, fredda o calda a seconda delle stagioni. Ad esso erano aggiunti ingredienti addolcenti ed aromatizzanti, soprattutto miele, erbe, fiori, spezie, resine, ecc.

 Del corredo dei simposi faceva parte anche la grattugia, usata appunto per grattugiare nel vino spezie, radici o, probabilmente (come succedeva nel mondo greco) anche il formaggio. Dal cratere il vino era poi attinto con dei mestoli o attingitoi come il kyathos, di foggia tipicamente etrusca, a metà fra una coppa per bere e una per attingere.
Del corredo dei simposi faceva parte anche la grattugia, usata appunto per grattugiare nel vino spezie, radici o, probabilmente (come succedeva nel mondo greco) anche il formaggio. Dal cratere il vino era poi attinto con dei mestoli o attingitoi come il kyathos, di foggia tipicamente etrusca, a metà fra una coppa per bere e una per attingere.


Era versato nelle brocche di servizio (oinochoe, anche questa una forma originaria etrusca) o direttamente nelle coppe dei commensali. Era anche filtrato con un colino, per eliminarne le torbidità.


Per bere si usavano coppe in ceramica di diversa foggia, come il calice semplice (in etrusco probabilmente thavna). Una forma importata dalla Grecia era la kylix (in etrusco culichna). Con manici più alti e tipicamente etrusco era invece il kantharos (in etrusco, probabilmente, chiamato zavena).







Il vino era legato alla dimensione religiosa non solo nel consumo ai banchetti funebri o nei riti sacrificali. Presso gli Etruschi la coltivazione stessa della vite era così importante che la classe sacerdotale era custode delle tecniche di coltivazione della vigna, della definizione dell’orientamento dei vigneti e delle pratiche magiche per preservarli dal maltempo.

Questi rituali si mantennero anche in epoca Romana, in particolare durante i Vinalia Rustica, festività celebrate il 19 agosto. Plinio Il Vecchio (Plin., Nat. Hist.) cita la pratica di deporre fra le vigne un grappolo d’uva posticcio, che attirasse su di sé i danni e risparmiasse il resto. Il sacerdote di Giove (il Flamen Dialis) celebrava l’auspicatio vindemiae. Cicerone cita anche le auguratio vineta, pratiche augurali che fa risalire ad Atto Navio, augure famoso al tempo di Tarquinio Prisco. Atto Navio, quando era un giovane pastore di scrofe, ne perdette una e promise che, se l’avesse ritrovata, avrebbe donato alle divinità il grappolo più grande della sua vigna. Fu esaudito e allora si pose al centro della vigna, la divise in quattro parti, secondo le pratiche della Disciplina Etrusca, ed interpretò il volo degli uccelli. Siccome gli uccelli avevano dato auspici sfavorevoli per le prime tre, cercò nella quarta parte e vi trovò un grappolo di mirabile grandezza.
La potatura presentava un alto contenuto simbolico: come forma di controllo e regolazione della produzione delle viti, veniva percepita come segno di valore e di regalità. In tombe dell’Età del Ferro la presenta di un falcetto per potare non rappresentava il mero strumento da lavoro, ma il simbolo distintivo della proprietà di vigneti e quindi di alto lignaggio. Questa concezione rimase anche a Roma: Virgilio, nel descrivere gli avi latini da cui discendeva la stirpe di Augusto nell’Eneide (libro VII), cita Sabino, descritto come coltivatore di viti e connotato da un falcetto ricurvo.
Le divinità connesse al vino erano due:
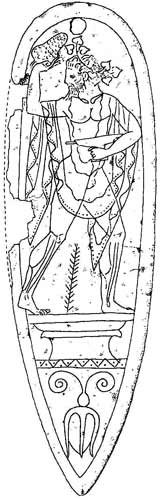
TINA/TINIA/TIN. É la massima divinità etrusca e ha come attributo principale il fulmine. Tina è una divinità celeste ma presenta anche aspetti legati alla vegetazione, in particolare alla viticoltura. Plinio tramanda che a Populonia esisteva una raffigurazione di Tina ricavata da un unico grosso ceppo di vite. Più tardi venne assimilato a Zeus-Giove.
FUFLUNS. Il nome ha come radice puple (germoglio), richiamando il suo legame originario con le forze della Natura. Nel “Fegato di Piacenza”, un bronzetto che riporta una sorta di “mappa” delle divinità etrusche, è elencato fra le divinità silvestri (dei boschi). Dalla metà del VI sec. a.C. venne assimilato sempre più al greco Dioniso, che, dall’appellativo Dionysos Bakchos, diventerà il latino Bacco. Nel IV secolo si diffusero sempre più in Etruria i riti dionisiaci, raggiungendo una grande diffusione nel IV-III sec. a.C. soprattutto fra gli aristocratici, al punto che erano organizzati collegi di Baccanti. Livio sostiene che proprio dall’Etruria questi culti arrivarono a Roma, dove furono proibiti dal senato nel 186 a.C. perché turbativi dell’ordine e della morale pubblica. Questi riti sono stati scambiati spesso per puri eccessi sessuali e di sfrenatezza. In realtà, nella filosofia greca il vino è connesso alla potenza di un furore esaltante e liberatorio. L’estasi che si libera al culmine dell’eccitazione dionisiaca è una forma di conoscenza più alta, il mezzo per unirsi al divino.
Continua: nella prossima parte parleremo del commercio etrusco del vino qui
Attilio Scienza presenta il suo ultimo libro "La stirpe del vino"
Martedì 4 dicembre presso la libreria Hoepli di Milano, alle ore 18.00, il nostro prof. Attilio Scienza presenterà, con la co-autrice Serena Imazio, il suo nuovissimo libro "La stirpe del vino" ed. Sperling & Kupfer.
In questo libro si raccontano, attraverso la storia, il mito e la scienza, origini e viaggi geografici delle principali varietà di uva, oltre che le (a volte) impensabili parentele che hanno dato loro vita.
Interverrà anche Isabella Bossi Fedrigotti, mentre Maria Grazia Pennino (sommelier AIS) supporterà la degustazione di alcuni nostri vini (Guado al Melo) e di altre aziende (Bellavista della Franciacorta e Banfi di Montalcino) che hanno gentilmente offerto alcune delle loro migliori etichette.
Guado al Melo News 2018
Ecco il nostro notiziario annuale, subito dopo la vendemmia. Si può scaricare la versione in pdf qui








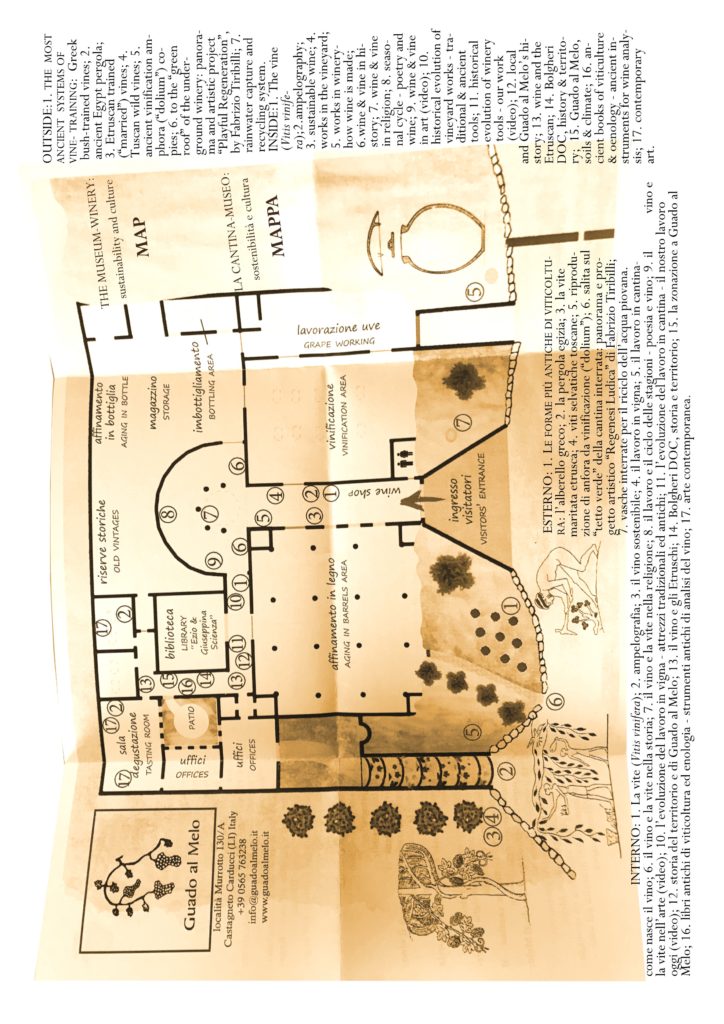



Criseo 2016 raggiunge l'eccellenza sulla guida Vitae AIS e gli altri vini
Grazie di cuore all'AIS per l'importante premio d'eccellenza al nostro Criseo Bolgheri DOC Bianco 2016, anche per la descrizione che ci hanno dedicato. Michele ed io abbiamo apprezzato molto questo passaggio: "...assistiamo a una perfetta fusione fra tradizione e ricerca scientifica, che dà luogo ad una valorizzazione autentica della zona di Bolgheri".

Con la guida, scopriamo che anche gli altri vini hanno avuto ottimi riscontri. Fantastiche, fra l'altro, le suggestioni che sanno creare i sommelier con le descrizioni dei vini.
Criseo Bolgheri DOC Bianco 2016: "Giallo dorato con brillanti riflessi paglierini. All’olfatto è intenso: propone ampie ed assortite suggestioni, che spaziano dal fieno alla melissa, dagli agrumi alla pesca, fino al corbezzolo, acacia e zenzero. In bocca è denso, ricco di aromi e succulenta sapidità. Scorre lungo il binario di una freschezza citrina, chiudendo su un finale balsamico."
E' già disponibile.
Atis Bolgheri DOC Superiore 2015: "Luminosa trama rubino. Il profumo, centrato su mirtillo e amarena sciroppata, si arricchisce di fragranti sensazioni di menta e mirto, poi passa a caffè in grani e baccello di vaniglia. Al palato è avvolgente: i tannini evidenti non impediscono al vino d’allargarsi e si fondono con le evidenze chinate della conclusione."
Sta completando l'affinamento in bottiglia, diamogli ancora qualche mese.
Jassarte 2015: "Rosso rubino profondo, quasi nero. Il naso evoluto scandisce crème de cassis, cardamomo, scatola di sigari e cioccolato fondente. Il gusto progredisce al ritmo di tannini setosi. Avvolgente e corroborante, conclude il suo percorso su un ricordo di anice."
Un po' più avanti dell'Atis nell'evoluzione in bottiglia, sarà pronto fra poco.
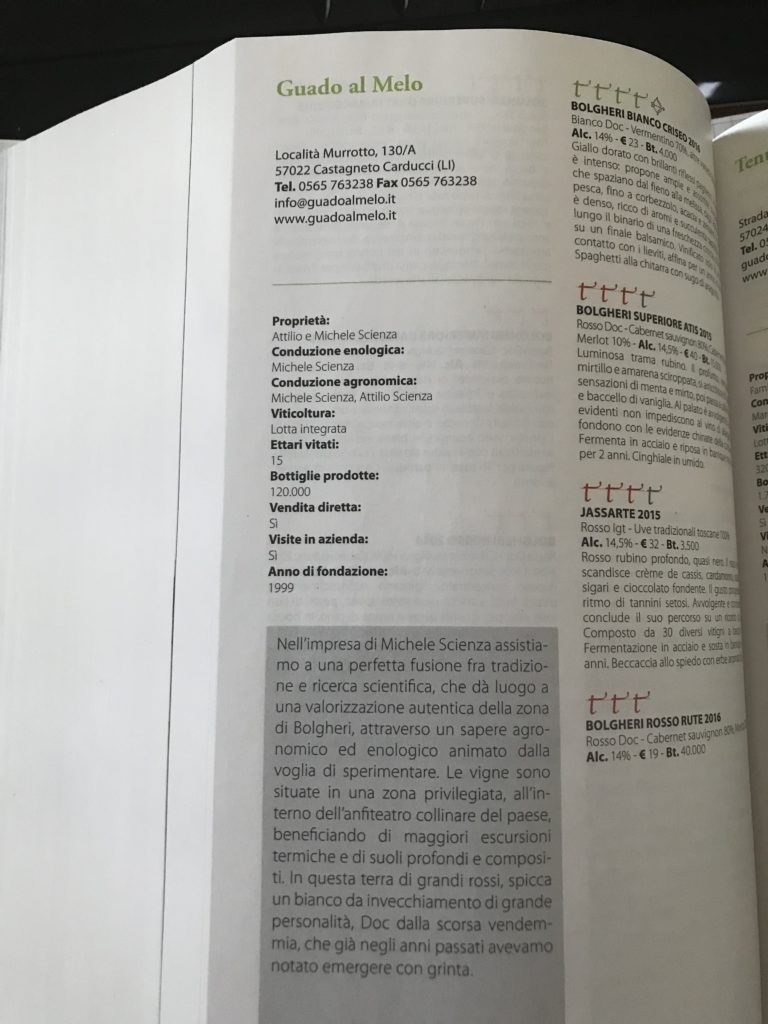
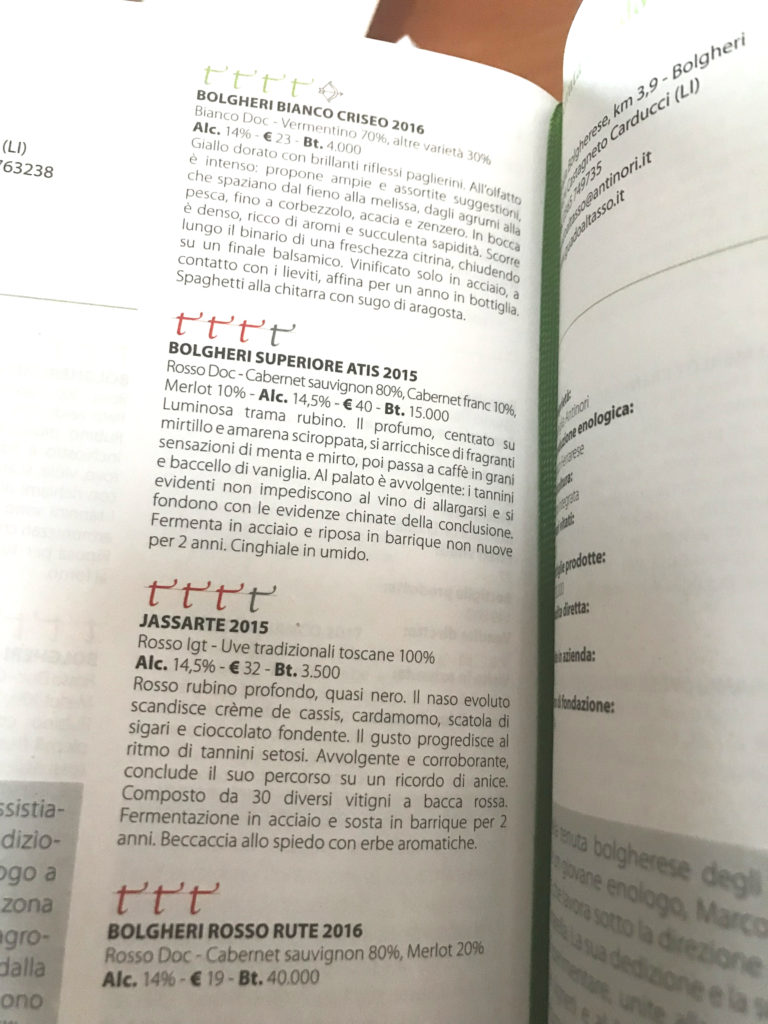
Criseo 2016, un grande bianco da complantazione a Bolgheri
I Sommelier AIS hanno deciso di dare il massimo riconoscimento (4 viti) della loro guida Vitae 2019 al nostro Criseo Bolgheri DOC Bianco, annata 2016. Voci di corridoio ci hanno fatto sapere che è arrivato anche in finale per i TreBicchieri del Gambero Rosso! Purtroppo non ce l'ha fatta quest'anno, ma comunque rimane un bel riconoscimento di qualità.
Criseo 2016 ha già preso tanti importanti riconoscimenti e recensioni entusiaste, fra tutti ricordiamo anche i 91 punti di Wine Enthusiast. Anche le annate precedenti hanno avuto successo. Ricordiamo ad esempio il giornalista americano Tom Hyland che lo ha definito qualche anno fa: "the best Italian white wine you've never tried" (Il miglior vino bianco italiano che non hai mai provato).
Tuttavia non ci stupisce tutto questo: ogni giorno sentiamo le lodi e l'amore per questo vino dai nostri visitatori e clienti più affezionati. Questo è, alla fine, il parere più importante noi. E non è retorica: è chi ha speso per acquistarlo, anche non pochissimo, e noi dobbiamo dargli qualcosa di grande, quel qualcosa capace di regalargli momenti di grande piacevolezza, a tu per tu col nostro terroir.
Criseo è infatti l'espressione assoluta del nostro territorio e del vino artigianale italiano: un bianco che nasce da una singola piccola vigna (Campo Bianco), da 5 varietà in complantazione, raccolte e vinificate insieme in modo sensibile e rispettoso delle uve, senza aggiunte o correzioni in cantina (previo un grande lavoro di cura e selezione in vigna), affinato per 1 anno sui lieviti in acciaio e almeno un altro anno in bottiglia.
Un grande vino bianco a Bolgheri?
Non deve stupire: ormai Bolgheri è conosciuta quasi solo per i rossi ma è sempre stata terra anche di bianchi. Già nelle nostre vigne è documentata la presenza importante di uve bianche (Vermentino, Trebbiano toscano e altre) da metà Ottocento, quando era parte della tenuta Espinassi Moratti. La stessa tenuta, nel 1925, vinse il primo premio all'esposizione vinicola di Roma per il proprio vino bianco.
Il territorio, per fare un grande vino, è condizione necessaria ma non sufficiente. Poi ci vuole la cura e la sensibilità di chi vi opera, i gesti del lavoro umano che si mette al servizio della Terra, capace di portare il terroir a compiersi al suo massimo. Noi abbiamo Michele Scienza, con la sua sensibilità, esperienza e competenza sia in vigna che in cantina, con la sua voglia di percorrere vie spesso controcorrente che lo portano all'essenza del suo territorio, senza curarsi delle mode del momento. Una di queste è proprio l'aver scommesso, vent'anni fa, sulla possibilità di poter fare un grande vino bianco a Bolgheri, da complantazione. Può dire di esserci riuscito.
Grazie a tutti
Gli Etruschi e il vino III: la produzione
Finora abbiamo imparato a conoscere gli Etruschi e le loro vigne, basate sulla vite maritata. Parliamo ora della produzione del vino.
Come per la viticoltura, anche quando si parla di vinificazione antica, in Italia, si accenna quasi solo a quella Romana. Eppure i Romani impararono dagli Etruschi anche a fare il vino. La stessa parola vinum, vino, è passata al latino dall’etrusco. Dal latino è poi rimasta nelle moderne lingue europee (vino italiano e spagnolo, vin francese, wine inglese, wein tedesco, ecc.). La sua origine è però ancora più antica e viene da lontano. Sembra che sia una sorta di “parola viaggiante” che ha seguito molto probabilmente lo stesso percorso storico-temporale della vite e del vino, da Oriente ad Occidente:
winuwanti nell’antica Licaonia (Caucaso)
wnš / wnšt in egiziano antico
wo-na-si o wo-no a Micene
foinos- voinos in dialetto eolico
vinom in falisco (antichissima lingua dei Falisci, popolo che viveva nella parte meridionale dell’Etruria, fra i monti Cimini ed il Tevere, nella zona dell’odierna Civita Castellana)
vinum in etrusco e, poi, in latino.
L’attuale georgiano (Caucaso) gwino segna il punto di partenza.

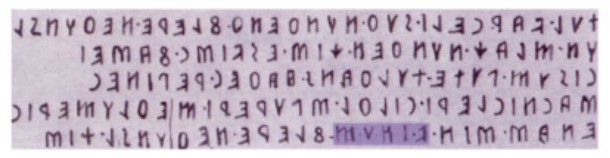

La parola etrusca vinum deriva quindi da un'influenza straniera, dalla cultura greca. Si pensa quindi che sia entrata in uso solo dal VIII sec. a.C. Esiste una parola autoctona per indicare questa bevanda: temetum. Questa appartiene alle radici protostoriche delle genti Etrusche e Latine. La parola vinum sarà però quella vincente.
Dopo questa digressione linguistica, veniamo al nostro punto. Come facevano il vino gli Etruschi?
Non è semplicissimo rispondere a questa domanda. Alcune cose le sappiamo per certe, altre le possiamo desumere per affinità da altri popoli mediterranei. Sicuramente possiamo prendere molte informazioni dagli autori romani. Sappiamo infatti che sono stati gli Etruschi ad insegnare loro la produzione del vino. Quindi, le tecniche produttive della Roma arcaiaca ci raccontano molto dell'enologia etrusca.
In epoca molto primitiva, in generale, gli studiosi ipotizzano che l’uva venisse schiacciata in piccoli contenitori, semplicemente spremuta con le mani o usando pietre come pestelli.

Tuttavia da quando l’uomo ha iniziato a rappresentare le scene di vinificazione in affreschi o su vasi (o almeno su quelli che ci sono pervenuti), già prevaleva l’uso di pigiarla con i piedi, in contenitori più grandi.
Sappiamo per certo che ad un certo punto, presso gli Etruschi, si iniziò a schiacciare l'uva in rozzi pigiatoi scavati nella pietra, detti PALMENTI, scavati in affioramenti rocciosi naturali. Questi, prima della domesticazione, erano realizzati in prossimità dei luoghi dove si trovavano le viti selvatiche. Con l’inizio della coltivazione, i palmenti furono realizzati nelle vigne. Questi potevano essere coperti con strutture leggere, tipo cannicciati o altro, per ombreggiarli o per proteggerli da piogge leggere. Lo sappiamo perchè, in alcuni di essi, sono stati trovati 4 fori intorno, scavati anch'essi nella roccia, come basi per alloggiare i pali di sostegno di una tettoia.


Si pensa che i palmenti in pietra comparvero più o meno dal primo millennio a.C. Esempi rari risalgono all’età del Bronzo ma diventano più numerosi in seguito. La loro datazione tuttavia non è semplice, perché furono usati anche per secoli. In Italia, molti palmenti antichi furono utilizzati dai contadini del luogo fino all’epoca medioevale e, a volte, anche in quelle successive, alcuni addirittura fino alla metà del Novecento.
Palmenti rupestri sono stati ritrovati in Toscana, nelle Marche, nel Lazio, in Campania, in Calabria, in Sardegna, così come in quasi tutte le aree del Mediterraneo Orientale. Si sono trovati anche nei paesi del Mediterraneo Occidentale (come Spagna, Portogallo e sud della Francia) ma risalgono alla colonizzazione romana.
Mancano invece, se non per rare eccezioni, nelle colonie greche dell'Italia del Sud. Ma come, direte, i palmenti non sono tradizionali in Sicilia ed altre zone della Magna Grecia? Sì, ma arriveranno dopo, con i Romani. Si pensa, verosimilmente, che nella cultura greca si usassero maggiormente contenitori in legno per pigiare, dei quali ovviamente non sono rimaste tracce archeologiche. Le testimonianze sono soprattutto artistiche, come è possibile vedere nelle numerose scene di vendemmia sui vasi, come quelle qui sotto. Da esse si desume che in Grecia, in epoca arcaica, si utilizzassero soprattutto pigiatoi in legno trasportabili, con gambe, che si posizionavano direttamente in vigna o in cantina.


Il palmento, comunque, appartiene anche ad altri popoli mediterranei. A Creta, in epoca precedente (età del Bronzo) le raffigurazioni mostrano la pigiatura dell’uva, con i piedi, in specie di tinozze in ceramica. Anche in Magna Grecia si ha testimonianza di alcuni pigiatoi in argilla rivestiti di calce. Costruzioni simili, fatti con mattoni crudi, sono testimoniati anche nel mondo fenicio-punico e in Egitto.
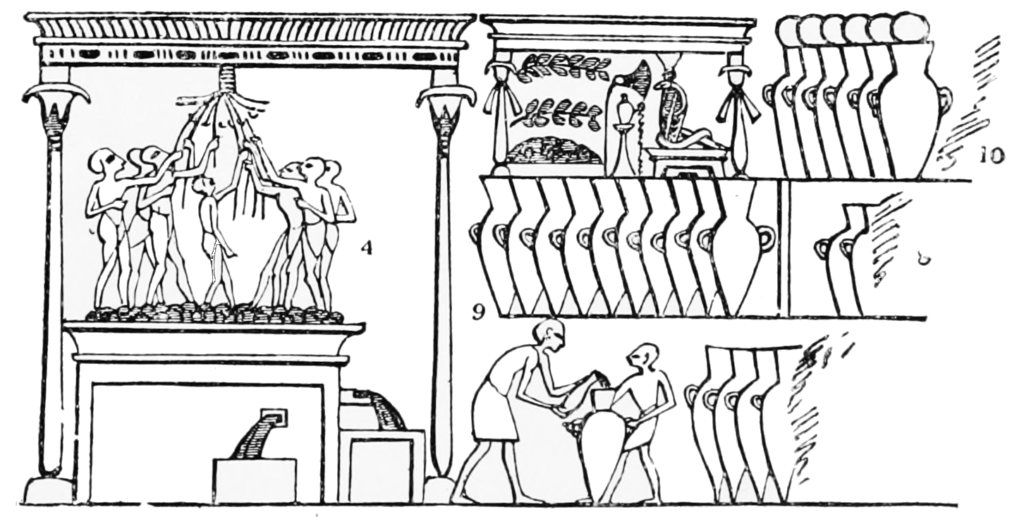
Tornando ai palmenti etruschi, questi erano scavati all’interno di affioramenti rocciosi trovati sul luogo, in materiale di origine vulcanica e quindi facilmente lavorabile, come il peperino, il nenfro, la trachite o il tufo. Il materiale usato, molto tenero e facilmente corrosibile anche dagli agenti atmonsferici, ha fatto sì che molti palmenti non siano arrivati a noi, diventati col tempo irriconoscibili nella loro funzione.
Erano formati da una cavità o, più frequentemente, da due, comunicanti per un canale di scolo. L’uva era pigiata a piedi nudi nella vasca superiore, di forma più o meno squadrata e non troppo profonda, col canale di scolo chiuso con argilla. Il pigiato era lasciato riposare e poi si apriva il foro comunicante e si lasciava filtrate il liquido in quella di sotto, più profonda e più piccola, spesso semicircolare. Qui si completava la vinificazione. Il mosto/vino era poi raccolto in otri in pelle o anfore, dove poteva completare la fermentazione. I contenitori in terracotta erano simili a quelli che i Romani chiameranno dolii (dolium, al singolare).
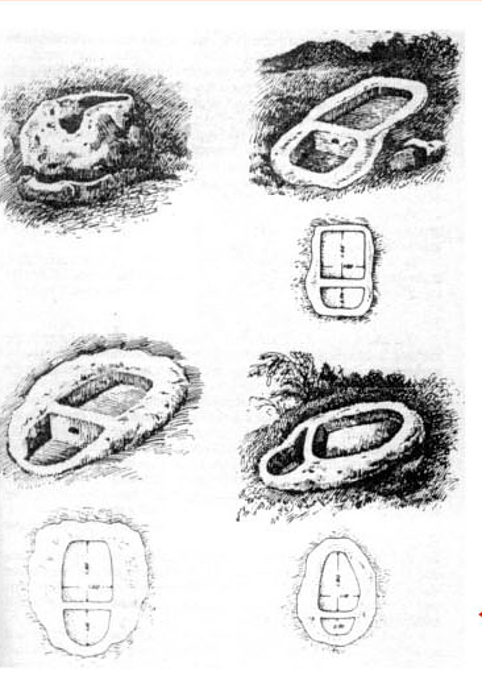
Le vinacce, rimaste nella vasca superiore, erano schiacciate per recuperare il liquido ancora contenuto. I sistemi più primitivi di torchi si basavano semplicemente sullo schiacciamento, fatto con pietre o pezzi di legno appoggiati sopra alle vinacce. In seguito, esse potevano essere spremute in sacchi e ripassate con l'acqua, producendo vinelli leggeri destinati alle classi inferiori (i Romani chiameranno questi vini loria, pratica che rimarrà comune fino alla modernità).
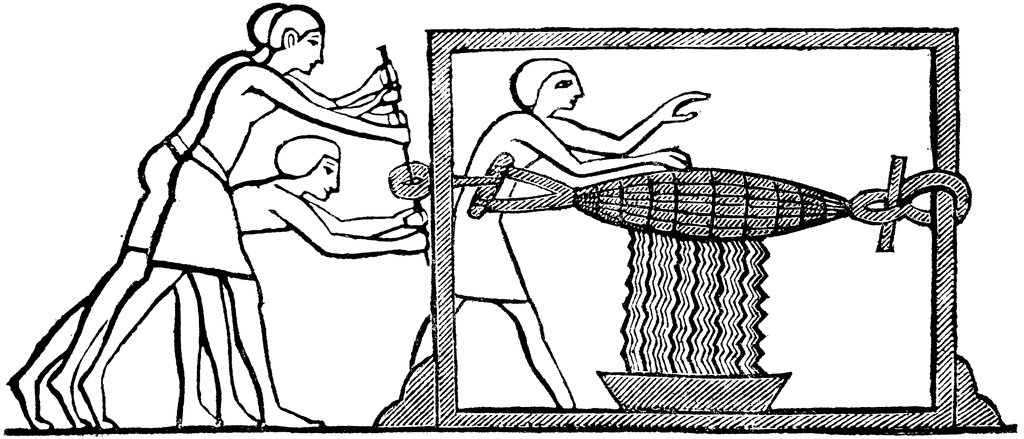
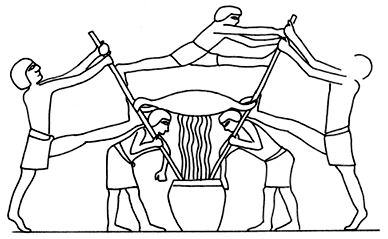
In Grecia sono documentati (su anfore), dal VI sec. a.C., anche dei rudimentali torchi a leva per il vino, fatti da un tronco abbassato dalla forza umana o anche appesantito con pietre. È impossibile trovare resti di questi torchi, perché realizzati con materiali grezzi (le pietre) e deperibili (le parti in legno). Tuttavia, si può presumere che fossero usati anche dagli Etruschi, per sviluppo proprio oppure per influenza greca. La prima reale documentazione di torchi da vino in Italia, di questa tipologia, si deve a Catone, nel II sec. a.C.

I vini erano conservati in contenitori in terracotta, come tutti i prodotti dell'epoca antica. Molto probabilmente si usavano anche otri in pelle, di cui non ci sono rimasti reperti, ma che sono spesso raffigurati.
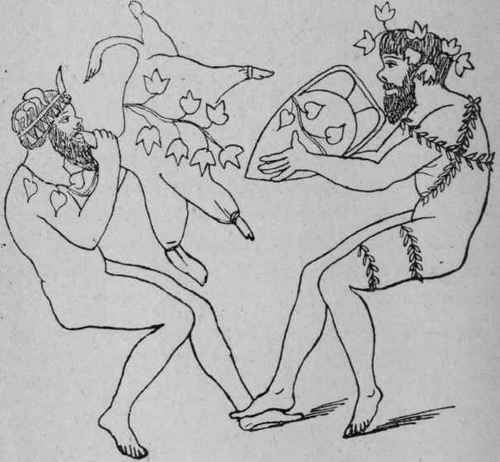
Intanto l’Etruria venne progressivamente annessa da Roma, in un periodo che va dal III al I secolo a.C. Dall’età tardo-repubblicana in poi, i metodi di produzione di vino in Italia sono ampiamente noti e documentati dagli autori romani.
Compaiono in questa fase i palmenti in muratura, che rimarranno tipici di moltissime parti d’Italia, fin quasi ai nostri giorni. Erano realizzati in pietre o mattoni cementati con malta e poi intonacati con malta impermeabile. L’uva vi era pigiata coi piedi e il mosto era lasciato sedimentare. Poi era fermentato in cisterne in muratura o in vasi di terracotta (dolii), rivestiti internamente di pece ed interrati. In tutte queste epoche non si può escludere a prescindere l’uso del legno, di cui purtroppo non restano tracce.


Il primo mosto ottenuto dalla vendemmia veniva in genere consumato subito, mentre il restante veniva versato in contenitori di terracotta con le pareti interne coperte di resina o pece. Il vino veniva lasciato riposare, schiumandolo spesso, e a primavera era decantato e versato nelle anfore da trasporto. Le vinacce erano spremute in torchi a leva, azionati da funi tirate da un argano. Nelle aziende più grandi, dal I sec. a.C., erano presenti anche grandi torchi a leva e a vite, con grosse pietre che facevano da contrappeso.
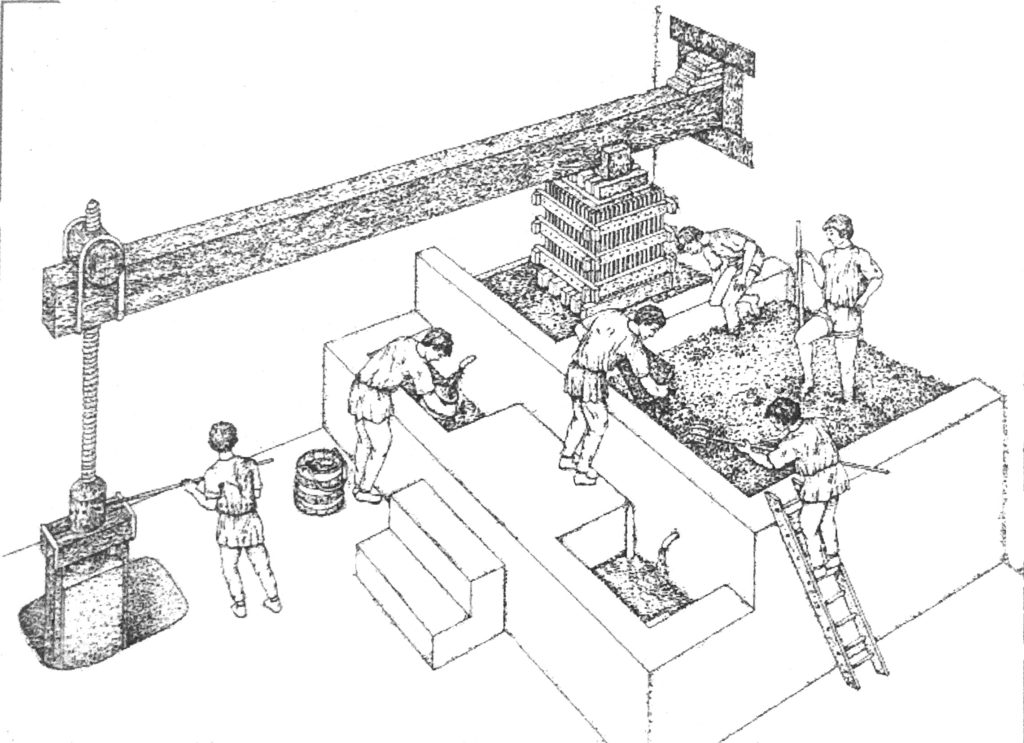

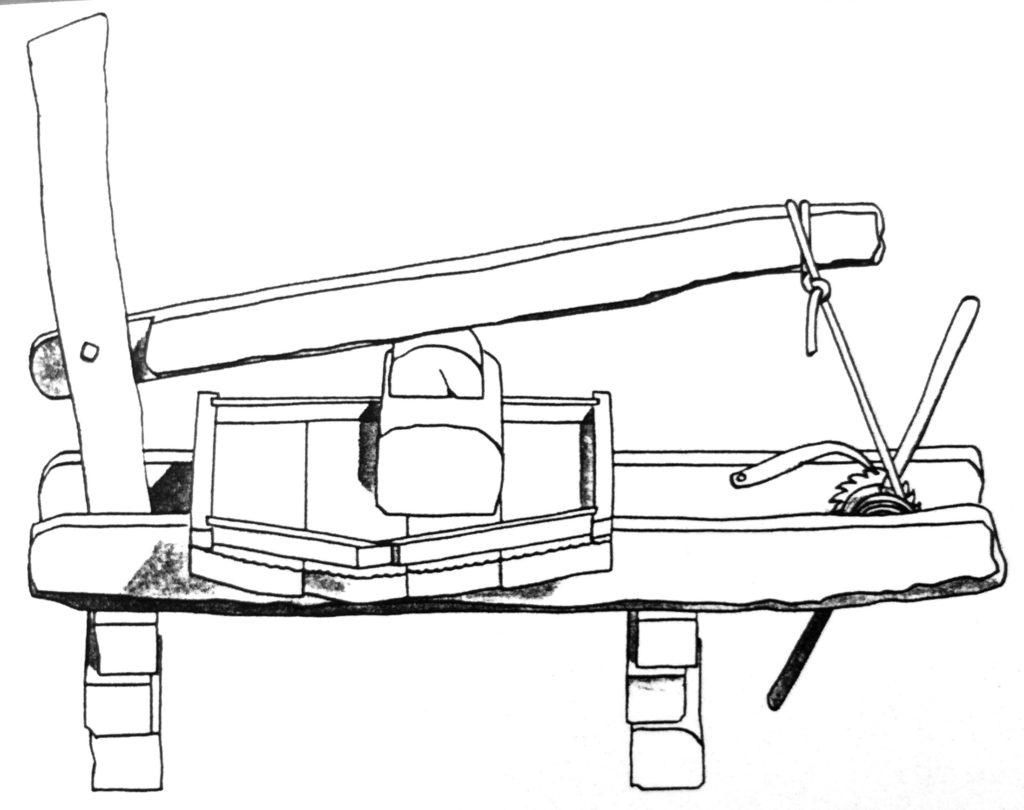
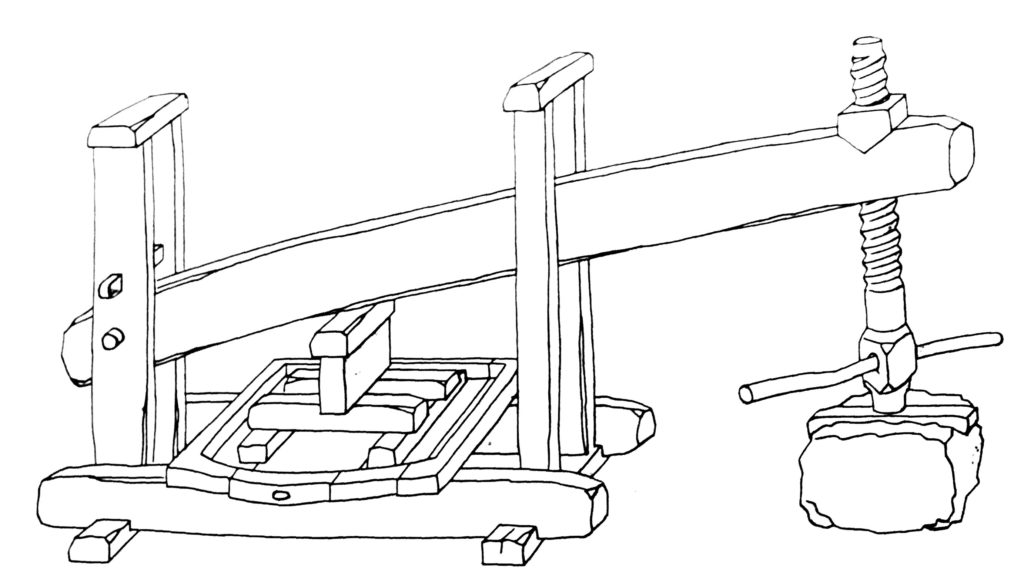
Dal I secolo d.C. venne inventato il torchio a vite centrale, più sicuro e maneggevole di quelli a leva, anche se un po’ meno potente. Era realizzato completamente in legno e quindi non ci sono rimasti pressoché reperti. Abbiamo queste informazioni dai documenti, soprattutto dalla testimonianza di Plinio (Naturalis Historia). Per questo viene anche chiamato "torchio di Plinio."
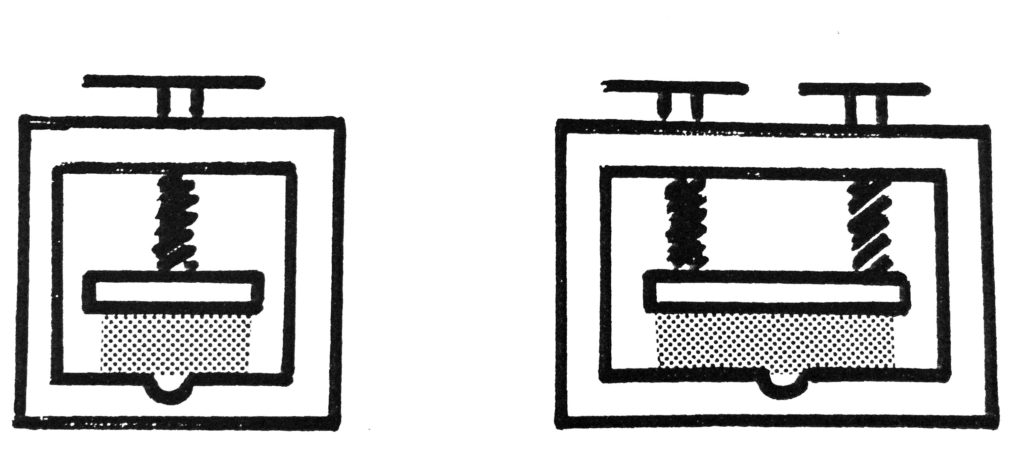

Il torchio di Plinio farà un salto notevole solo quando potrà passare dagli ingranaggi in legno a quelli in ferro, che avverrà solo nella seconda metà del XIX secolo. In epoca romana e in quelle a seguire il ferro era un materiale molto costoso (senza considerare le difficoltà tecniche di filettarlo in modo regolare). A nessuno sarebbe venuto in mente di usare ferro dove si poteva usare il legno. Solo nell’Ottocento, grazie alla maggiore disponibilità e al minor costo del metallo, si iniziò ad usarlo per gli ingranaggi e poi per tutto l’attrezzo, permettendo l’abbandono definitivo degli ingombranti (e difficili da maneggiare) torchi a leva.


La tecnica di produzione del vino del tardo impero sarà quella che rimarrà sostanzialmente immutata in Italia (e altre zone dell’Impero) per i secoli a venire. Coesistevano i vari sistemi spiegati fin qui, alcuni molto arcaici e altri molto avanzati. Ci possiamo immaginare i grandi proprietari terrieri che si facevano costruire ville all’avanguardia e molto costose. Questi potevano essere imitati dai notabili locali, ma non certo dagli altri piccoli produttori, con minori disponibilità finanziarie, che continuavano a produrre il vino con strumenti semplici e di facile auto-realizzazione.
Quindi, l’uva era pigiata coi piedi in palmenti in pietra o in muratura. Era fermentata in cisterne in muratura o, soprattutto, nei dolii in terracotta. In questa epoca compaiono sempre più i contenitori in legno (documentati) per la pigiatura, fermentazione e trasporto, che diventeranno prevalenti dal Medioevo in poi.

La spremitura era fatta nei vari tipi di torchio descritti sopra, ma prevalentemente con torchi a leva con funi ed argano. Anche se questa era una tecnologia sorpassata, rimase comunque la più diffusa perché era la più semplice e la meno costosa. I più moderni sistemi dei torchi a leva e a vite o a vite centrale, invece, richiedevano artigiani qualificati per realizzarli e legname di qualità, per cui erano presenti solo nelle cantine più ricche.
Dal Medioevo in poi si riprenderanno questi stessi sistemi. Spariranno pressochè i contenitori in terracotta e prevarrà soprattutto il legno. Resteranno i palmenti ed i diversi tipi di torchi. Per cambiamenti veramente sostanziali da questi modelli, dovremo aspettare il XIX secolo.
Nel prossimo post, parleremo invece del vino Etrusco, come era fatto, con quali varietà e come veniva bevuto qui.
Il vino e gli Etruschi (II): la vite maritata, tremila e più anni di viticoltura ed arte
Gli Etruschi sono stati i primi in Italia a coltivare la vite a partire dalle varietà selvatiche. Era una pianta che vedevano nel loro ambiente naturale, di cui avevano già imparato a raccogliere i frutti nei boschi.
Infatti la vite selvatica, Vitis vinifera sylvestris, è una specie autoctona dell'area mediterranea e, soprattutto in Italia, trova le sue condizioni ideali. Ancora oggi è possibile trovare viti selvatiche nei nostri boschi (anche se bisogna far attenzione a distinguerle da viti coltivate inselvatichite, di vecchi vigneti abbandonati). Le varietà che coltiviamo oggi derivano dalla vite selvatica, modificata attraverso millenni di selezioni ed incroci attuati dall'uomo.
Tornando agli Etruschi, sembra che coltivassero la vite fin dall’età del Bronzo, comunque almeno dal XII sec. a.C.
Più tardi, con lo sviluppo della civiltà, essendo grandi navigatori e mercanti, ebbero contatti sempre più intensi con i popoli del Mediterraneo orientale (soprattutto con i Greci), dove cultura e tecniche viticole erano già più evolute. Questo permise loro di affinare le tecniche produttive, d'importare nuovi attrezzi e nuove modalità di lavoro. Vennero importati anche nuovi vitigni di origine orientale, il cui processo di domesticazione erano iniziato in epoca ben più remota nell'area del Caucaso. I nuovi vitigni vennero coltivati tal quali e anche incrociati con le varietà locali.
In questo modo la primitiva viticoltura etrusca s'affinò e crebbe nei secoli. Dal VI sec. a.C., vista la crescita in quantità e qualità della produzione del vino, cominciò anche il commercio oltremare. Vediamo ora di capire com'era questa produzione.
Gli Etruschi coltivavano le viti come le vedevano crescere spontaneamente nei boschi. La vite è un arbusto rampicante, una specie di liana. In un bosco, il suo ambiente naturale alle nostre latitudini, tende ad arrampicarsi su un albero per raggiungere il più possibile la luce (è molto eliofila). Non è però una specie parassita: la vite non interferisce con l'albero su cui s'aggrappa.
Questa modalità di coltivazione etrusca è stata chiamata per secoli vite maritata. La vite è come "sposata" all'albero a cui s'avvinghia. Questa definizione non è d'epoca etrusca ma nacque più tardi, in epoca Romana. Gli Etruschi sembra che l'indicassero col termine di àitason (letto, probabilmente, "aitasun").

Le viti erano allevate su soprattutto su aceri campestri, ma anche pioppi, olmi, ulivi ed alberi da frutto. In origine non erano potate, più tardi furono soggette a potatura lunga. La vite quindi tendeva a crescere molto, ad avere tralci anche lunghissimi. La raccolta dell’uva era effettuata con le mani o con falcetti, con scale appoggiate agli alberi, oppure usando strumenti dal manico molto lungo.
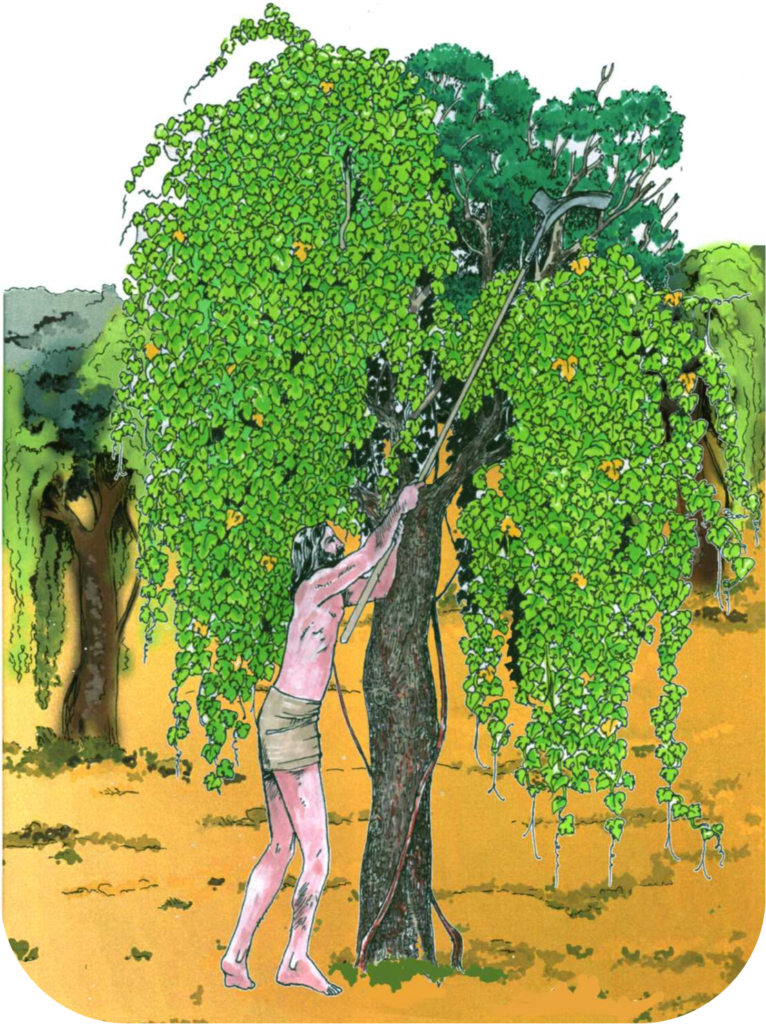
La coltivazione delle vite in Etruria non era specializzata, così come rimarrà in prevalenza in Italia per secoli: non c'era una vera e propria vigna come la intendiamo oggi. Era invece promiscua con altre colture, alternata a campi di cereali, ulivi, alberi da frutta, ecc.
La vite maritata è rimasta nella cultura viticola italiana fino a quasi i nostri giorni, in tutti quei territori dove in antichità era arrivata la civiltà etrusca.
 Gli Etruschi, dall'originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all'Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest'ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno "morto" (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell'attuale nord Italia).
Gli Etruschi, dall'originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all'Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest'ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno "morto" (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell'attuale nord Italia).
Gli Etruschi trasmisero molto della loro cultura anche alla nascente civiltà romana, compresa la viticoltura e la produzione del vino. Infatti, nella viticoltura romana antica, come testimoniato nel De Agri Cultura di Catone (II sec. a.C.), la coltivazione della vite era fatta alla maniera etrusca, maritandola all'olmo o al fico. L'àitason etrusco divenne l'arbustum (vitatum) latino, che Catone a volte chiama anche vinea, così come Cicerone.
Con Varrone, nel De Re Rustica (39 a.C.) comparve però l'esigenza di distinguere due forme diverse di coltivazione. Molto probabilmente nella sua epoca stava emergendo una nuova forma di viticoltura, quella di derivazione greca già accennata sopra. L'arbustum rimase ad indicare la vite maritata. Vinea divenne il termine per indicare questa nuova coltivazione a vite bassa. Entrambe appartenevano alla categoria generale del vinetum (vigneto).
Virgilio, nelle Georgiche (29 a.C.) scrive della viticoltura della sua terra (Mantova) e racconta che le viti erano maritate all'olmo.
Columella nel suo De Re Rustica (65 d.C.), considerato il primo vero e proprio trattata agrario della storia (rimarrà come testo base per tutti i secoli a venire, fino almeno al XVIII sec.), descrive a fondo le diverse forme di viticoltura romana. Emerge però la sempre maggior diffusione della vinea a discapito dell'arbustum, per via del fatto che il primo garantisce una viticoltura più specializzata.
Plinio il Vecchio (Naturalis Historiae, 77 d.C.) testimonia la viticoltura campana dell'epoca, con viti maritate ai pioppi, anche altissime, soprattutto nella zona di Aversa. Distingue l'arbustum italicum, tipico del centro Italia, dove le viti salgono sul singolo albero, dall'arbustum gallicum (chiamato così perché molto frequente in quella che era all'epoca l'ex-Gallia Cisalpina), dove i tralci delle viti passano da un albero all'altro formando dei filari.


Le viti maritate ritornano anche in opere meno rilevanti del tardo impero, come la Opus Agricolturae di Palladio (IV sec. d. C) e nel Geoponica del bizantino Cassiano Basso (VI sec. d.C.) che la consiglia nei terreni umidi. In epoca medievale le ritroviamo nell'opera del bolognese Crescenzi, l'unico testo medioevale agrario rilevante del Medioevo Europeo (1304) e in altri scritti minori.
L'agronomo bolognese Vincenzo Tanara nel 1644 descrive i due principali sistemi di coltivazione della vite maritata del suo tempo, che corrispondono esattamente ai sistemi romani. Li chiama piantate (l'arbustum gallicum ) e alberate (arbustum italicum).
Per tutti i secoli successivi, la viticoltura italiana del Centro e del Nord è stata dominata da questi due sistemi, a seconda delle zone. Le alberate erano appezzamenti con viti arrampicate su alberi singoli, posizionati in modo casuale nel campo o con impianti regolari. Originarie dell'Etruria centrale, sono rimaste tradizionali soprattutto in Toscana (col nome di testucchio), Lazio ed Umbria. Le piantate formavano invece filari nelle zone di confine di un terreno o lungo gli argini dei fossi. Erano più diffuse nel centro-nord dell'Etruria e nelle zone di espansione a Sud, infatti rimasero tradizionali soprattutto nella pianura Padana e in Campania.
La vite maritata continuò quindi a far parte del paesaggio agrario italiano anche dopo l'epoca classica e si ritrova infatti raffigurata nell'arte di tutti secoli.



Questi paesaggi affascinarono anche i viaggiatori stranieri del Sette-Ottocento che compivano il loro viaggio culturale in Italia, all'epoca ritenuto indispensabile nella formazione giovanile della classe colta europea. I paesaggi con le viti maritate si ritrovano così in diverse rappresentazioni pittoriche di quel periodo. Sono raccontate anche nei diari di viaggio, come ad esempio dall'architetto francese Jacques-Germain Soufflot a metà Settecento, in visita a Paestum (Suitte Des Plans, Coupes, Profils, Elévations géometrales et perspectives de trois Temples antiques, tels qu’ils existoient en mil sept cent cinquante, dans la Bourgade de Pesto… Ils ont été mésurés et dessinés par J. G. Soufflot, Architecte du Roy. &c. en 1750. Et mis au jour par les soins de G. M. Dumont, en 1764, Chez Dumont, Paris, 1764), oppure da Goethe nel suo celebre "Viaggio in Italia" (1813-1817).
Scriveva Aubert de Linsolas nel suo libro "Souvenirs de l'Italie" (1835):
" ... i rami della vite intrecciati ai grandi alberi all’orlo della carreggiata, danno l’idea di tanti archi trionfali di verzura, preparati per il passaggio di un potente monarca."



L'immagine così evocativa della vite che abbraccia l'albero non rimase però confinata ai soli contesti agrari. Accese anche l'immaginazione di artisti e letterati, che le attribuirono diversi significati simbolici.
Dal I secolo d.C. comparve nella letteratura latina la metafora poetica della vite e dell'albero (soprattutto l'olmo) come simbolo dell'amore coniugale. La vite è "sposata" all'albero: da qui nacque il termine vitis maritae che usiamo ancora oggi ("vite maritata").
Ad esempio, Gaio Valerio Catullo identifica la vite e l'olmo come moglie e marito nella "canzone nuziale di giovani e fanciulle" (Carmina, poema 62, traduzione di Mario Ramous):
..."
Come la vite che nasce isolata in terra spoglia
non riesce ad alzarsi né a maturare l'uva,
ma piegandosi sotto il peso del tenero fusto
quasi sfiora con le sue radici il tralcio piú alto
e da nessuno, contadini o buoi, è presa a cuore,
se per caso si lega in matrimonio all'olmo
tutti, contadini o buoi, l'hanno a cuore;
cosí invecchia trascurata una fanciulla vergine,
ma se a tempo debito stringe giuste nozze,
eluso l'odio del padre, avrà l'amore di un uomo.
..."
Nelle Metamorfosi di Ovidio (XIV, 623 e seguenti) questa metafora compare nella storia d'amore di Vertumno e Pomona. Vertumno era un Dio di origine etrusca, rimasto anche nella religione Romana. Presiedeva alle trasformazioni (verto, in latino, significa appunto cambiare): al cambio delle stagioni ma anche ai commerci. Il Dio s'innamorò di Pomona, antichissima Dea latina della coltivazione dei frutti, che tuttavia era inavvicinabile. Cercò di raggiungerla con diversi travestimenti e ci riuscì prendendo le sembianze di una vecchia donna. Allora cercò di convincerla d'abbandonarsi all'amore con diversi argomenti, fra cui appunto la metafora della vite e l'olmo:
C’era di fronte un olmo avvolto da un rigoglio d’uva luccicante. Elogiato l’olmo insieme alla vite che l’accompagnava, (la vecchia) disse: “Però se questo tronco se ne stesse lì celibe, senza tralci, non avrebbe nulla di attraente se non le proprie fronde. E anche la vite, che si abbandona abbracciata all’olmo, se non gli fosse unita, per terra giacerebbe afflosciata. Ma a te l’esempio di questa pianta non dice nulla ed eviti l’accoppiamento, non ti curi di congiungerti. Oh, se tu lo volessi..."

Al termine del discorso, Vertumno si rivelò in tutto il suo fulgore. Pomona, colpita dalle parole sentite e dalla bellezza del Dio, cedette all'amore.
Questa storia ebbe grande eco nel Rinascimento e rimarrà un tema artistico molto frequente fino al XVIII secolo.
Di nuovo troviamo in Ovidio (Amores, elegia XVI) questo tema:
Ulmus amat vitem,
vitis non deserit ulmus;
Separor a domina
cur ego saepe mea?
(L’olmo ama la vite e la vite non si separa dall’olmo;
perché mai tante volte io sono diviso dalla mia amata?).
Il tema della vite maritata all'albero raggiunse però la sua massima diffusione grazie al giurista milanese Giovanni Andrea Alciato (1492-1550). Egli pubblicò una collezione di allegorie e simboli (riprodotti con xilografie), spiegate nel loro valore morale con brevi testi in latino. Il titolo era "Emblemata", pubblicato ad Augusta nel 1531. Ebbe un successo straordinario in tutta Europa, con traduzioni in italiano, francese, spagnolo, tedesco ed inglese. Alciato creò un vero e proprio nuovo genere letterario, di grande successo anche nei secoli seguenti, l'emblematica.
La vite maritata è riportata da Alciato come emblema dell'Amicizia e, nella sua forma più pura, dell'Amore, col titolo latino:
"Amicitia etiam post mortem durans"
(l'amicizia perdura anche dopo la morte).

Il disegno è così descritto:
Una vite, coperta di verde vibrante, abbraccia un olmo, asciutto per l'età e persino spogliato di fogliame. Riconosce il cambiamento naturale, e ringrazia con gratitudine i reciproci obblighi di servizio. E così con l'esempio ci consiglia di cercare gli amici quelli il cui patto di amicizia non è rotto nemmeno dalla morte.
Questa interpretazione era stata influenzata da un epigramma del poeta greco Antipatro di Tessalonica (I sec. a.C.), in cui un platano appassito racconta come la vite, allevata su di esso, lo mantenga verde. Alciato, che è lombardo, corregge l'errore del greco. La vite maritata era parte dei paesaggi agrari della sua terra natia e quindi sapeva bene che è l’olmo lo sposo ideale della vite, non il platano.
Grazie ad Alciato e al successo dell'emblematica, il simbolo della vite maritata all'albero ebbe un'enorme diffusione e comparve in moltissime raffigurazioni artistiche, in poemi ed opere letterarie di tutta Europa. La vite maritata di origine etrusca, mediterranea, divenne quindi un simbolo culturale decontestualizzato.
Ad esempio, il fiammingo Daniël Heinsius, in Emblemata amatoria (1620), più che all'amicizia, tornò a legarlo all'Amore Imperituro. come in epoca classica. Fra l'altro, riprese il platano originario dell’epigramma greco. La vite maritata, con Heinius è l'emblema dell’amore eterno che va anche oltre la morte, con la dicitura
"Ni mesme la mort"
nemmeno la morte.

Divenne anche il logo degli Elzevier, editori di Leida (Olanda) dal 1580. L'attuale casa editrice Elsevier (rifondata nel XIX sec.) è il maggior editore mondiale in ambito medico e scientifico. Il loro simbolo è rimasto quello originale, una vita maritata all'albero, col significato dell'allenza fra apprendimento e letteratura.

Dall'Ottocento la viticoltura divenne una scienza e fiorirono numerosi trattati agrari che descrivevano nel dettaglio i sistemi tradizionali italiani. Per questa parte mi sono riferita alle opere di due insigni studiosi dell'Otto-Novecento, i piemontesi Ottavio Ottavi e Domizio Cavazza.
La viticoltura italiana dell'epoca, nel centro-nord, era rimasta ancora di base quella dell'arbustum italicum (alberata) e dell'abustum gallicum (piantata) dell'antica Roma. Da questi due archetipi, si erano però differenziati miriadi di sistemi diversi. Gli stessi studiosi ammettono che sono difficili da elencare in tutte le varianti possibili. Inoltre c'è parecchia confusione nei termini, rispetto al passato. Si usa spesso il termine alberata per indicare sia l'uno che l'altro sistema.
Si usano ancora soprattutto l'olmo, l'acero e il pioppo. Ora, però, ci sanno anche spiegare il perché. L'ideale, per un tutore vivo, è una pianta con un apparato radicale e chioma che interferiscano poco con lo sviluppo della vite. Così è l'acero (Acer campestris), beniamino delle vigne fin dagli antichi Etruschi. È lento d'accrescimento, ha poche radici che scendono in profondità e non intralciano quelle delle viti. La chioma, poco folta, è facilmente modellabile con la potatura. Si adatta bene anche ai terreni poveri e poco profondi.
L'olmo (Ulmus campestris) rimane l'albero più usato nel nord, anche se non è così perfetto per la vite. Ha una forte espansione radicale ma è molto longevo, produce ottimo foraggio (le foglie) e fascine e legna. Si adatta molto bene ai terreni fertili ed umidi della Pianura Padana.
Il pioppo (Populus nigra) era usato per via del suo rapido accrescimento e perché produce foraggio e legna. Non è però così adatto per la vite perché ha un esteso sistema radicale e chioma folta che ombreggia.
Il gelso (Morus alba) era usato molto in Veneto, anche se non era proprio adatto. Fa troppa concorrenza alla vite. Tuttavia era usato per mettere insieme due economie: l'uva e l'allevamento del baco da seta. L'introduzione dei trattamenti col rame di fine Ottocento (che uccide il baco) rese però molto difficile questa convivenza.
Si usavano anche, in minor misura, il salice, l'orno, il frassino, il corniolo, il tiglio, il carpino, la quercia, il ciliegio, l'olivo, il noce e il fico.
Il sistema più semplice, il vecchio arbustum italicum, in questo periodo era chiamato testucchio. Era diffuso soprattutto in Toscana, ma anche nelle Marche e Lazio, con modalità d'impianto e potatura un po’ diverse. Si usavano soprattutto aceri, chiamati in Toscana oppi o loppi o pioppi. Fra i testucchi si potevano anche coltivare delle viti basse, appoggiate su pali, formando così il filare o filone pieno. Nel Casertano si trovavano soluzioni simili, ma con le viti intermedie coltivate alte.
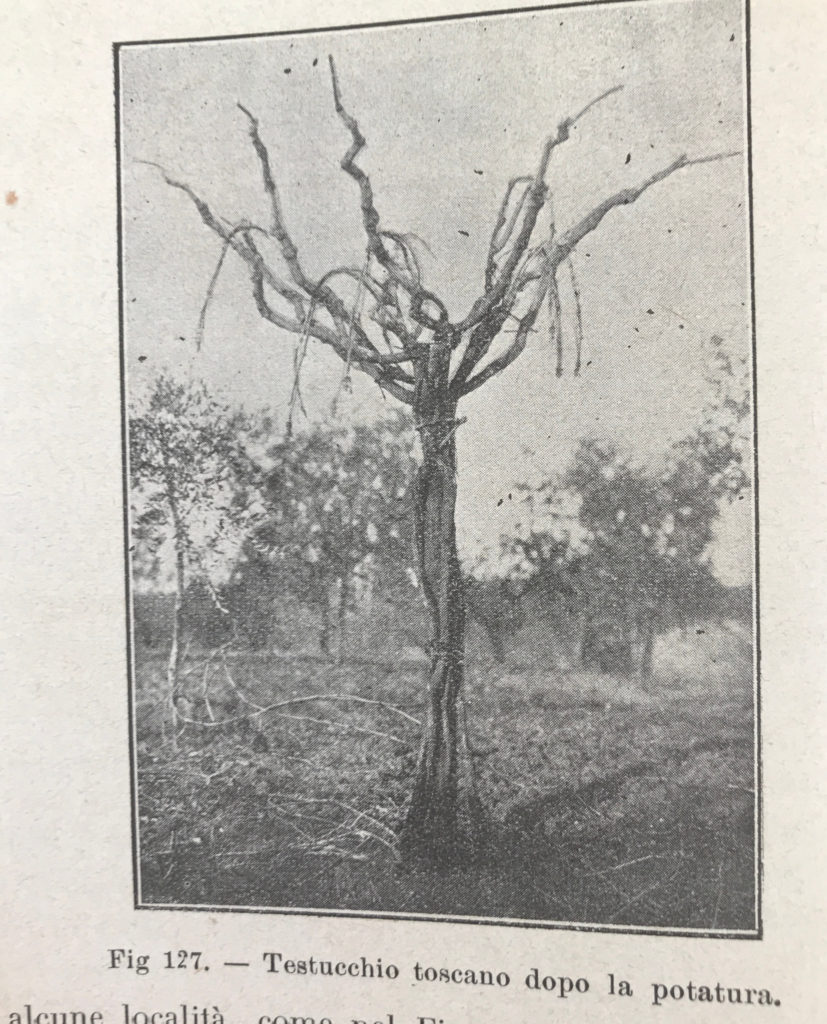

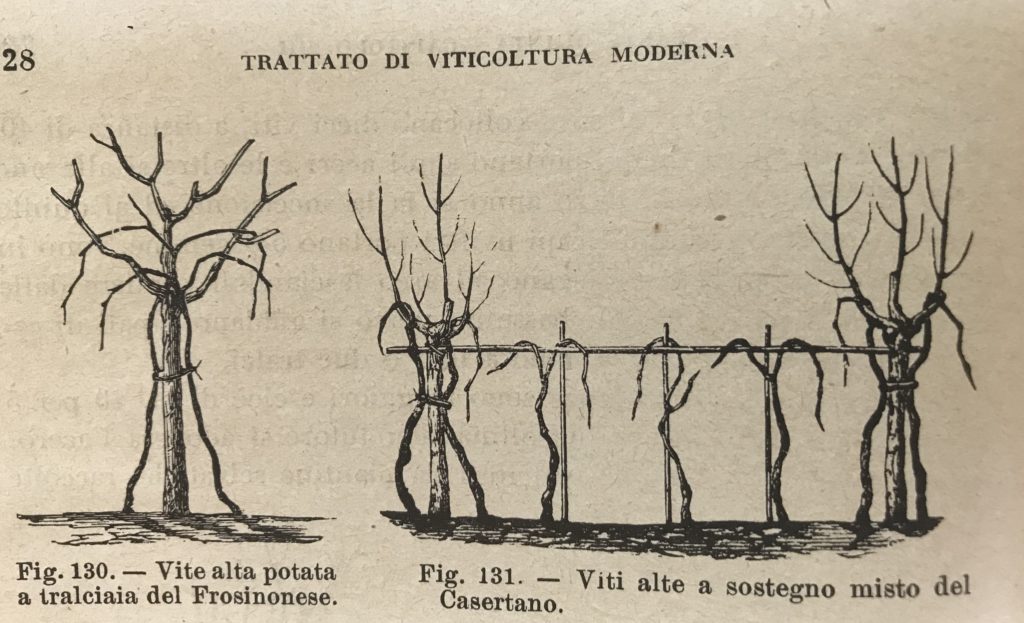
In Abruzzo i tralci erano intrecciati a formare un grosso quadrato orizzontale, formando i cosiddetti capanne o capannoni.
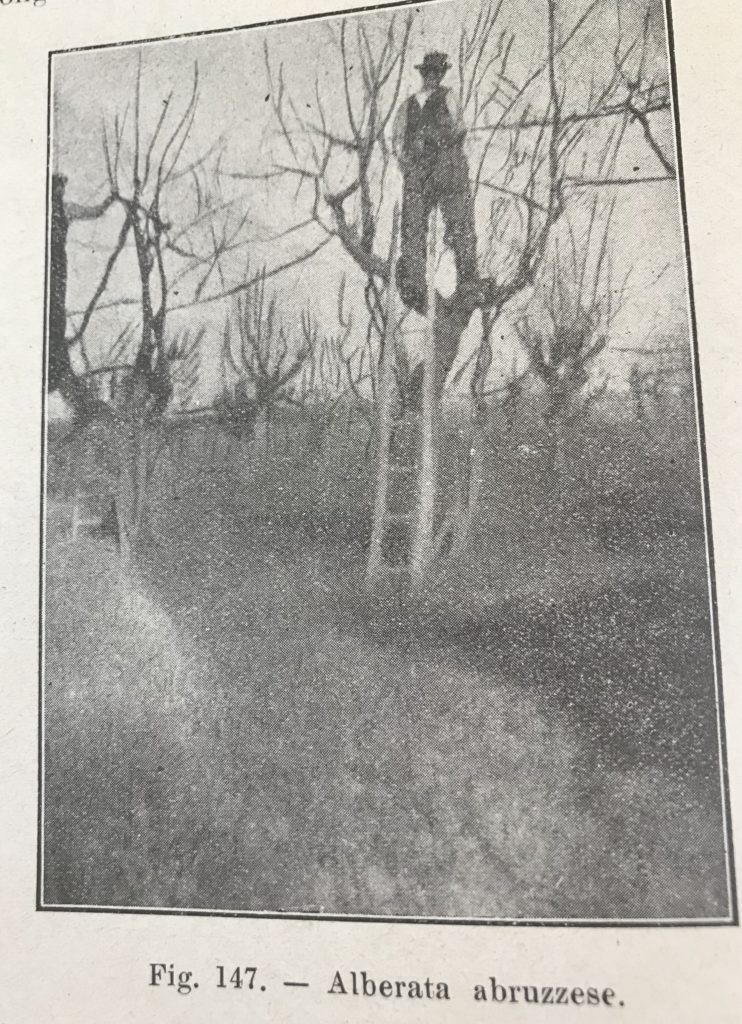
Nell'Aversano, con la coltivazione dell'uva Asprinio, si arrivava a 20 metri d'altezza con i pioppi. Si noti, nella foto d'epoca, la dimensione dell'omino sull'albero. Nell'interfilare si coltivano altre specie come la canapa, il granturco, la patata e vari cereali.
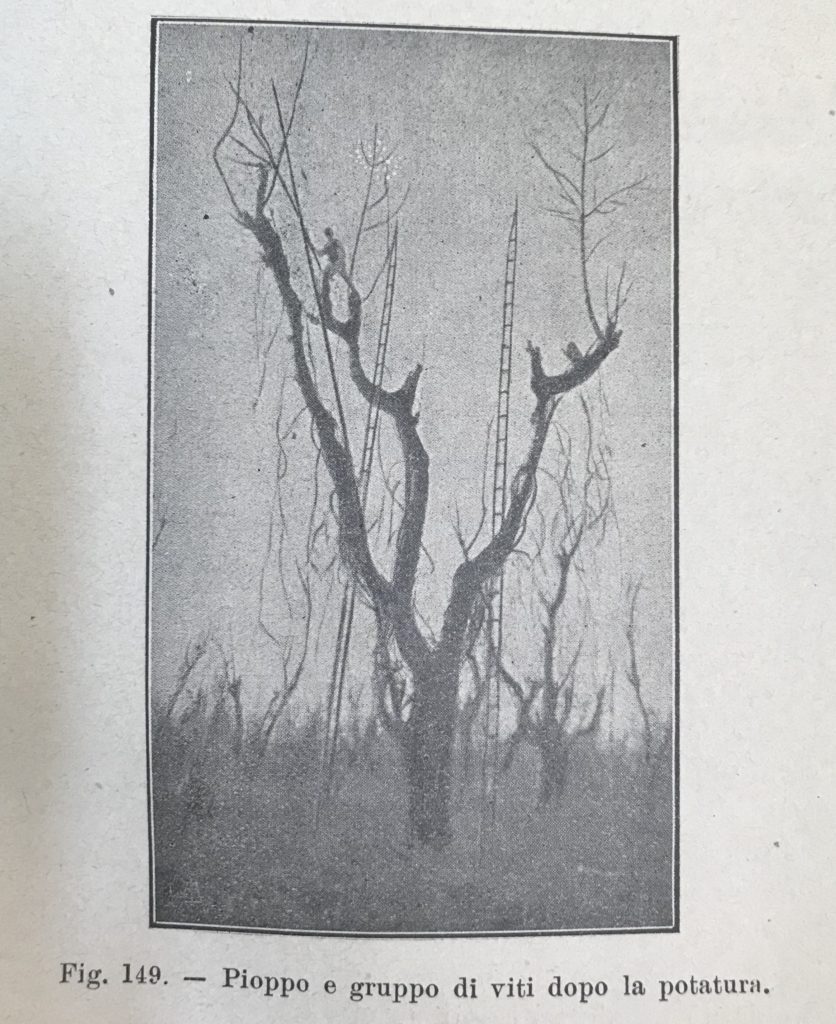
Il "sistema chiantigiano” era basato sempre sull'acero, i cui rami erano potati per stare in orizzontale ed unirsi a quelli dei vicini, ottenendo una sorta di spalliera continua su cui s'arrampicava la vite.
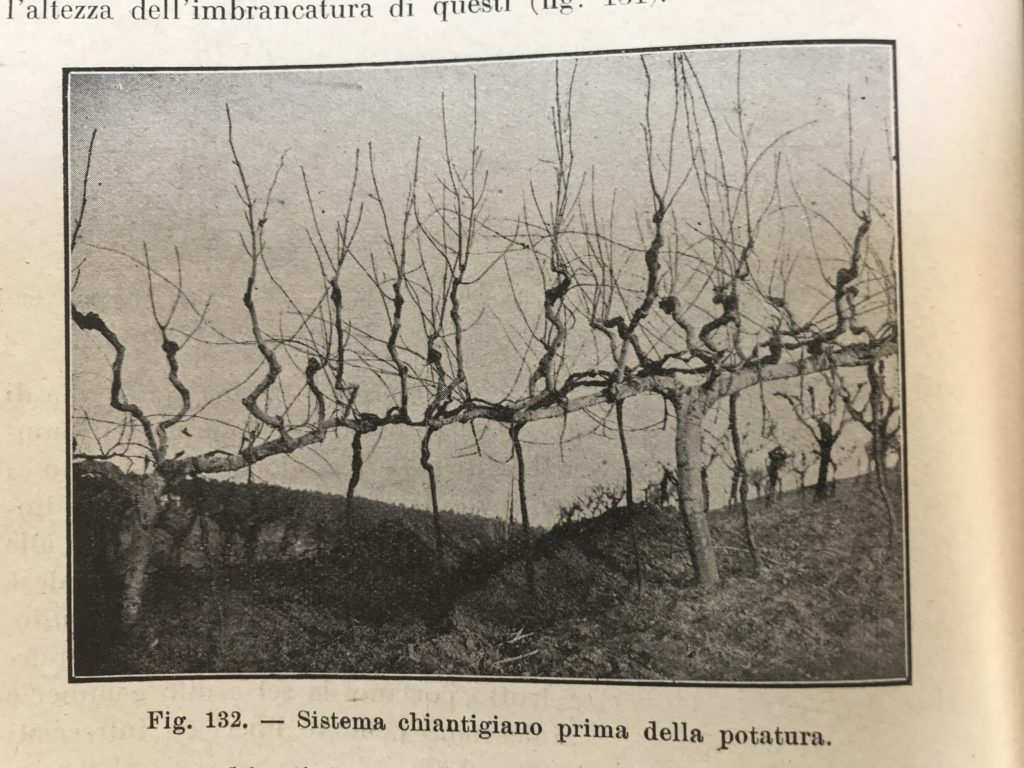
Il “sistema a festoni” o "a tralciaia" o "pinzana" era tipico della Toscana, soprattutto nel Pisano, del Casertano, Napoletano e dell'Emilia. I festoni erano formati dai lunghissimi tralci delle viti intrecciati. A volte dovevano essere sostenuti a metà da bastoni o separati da una traversa.
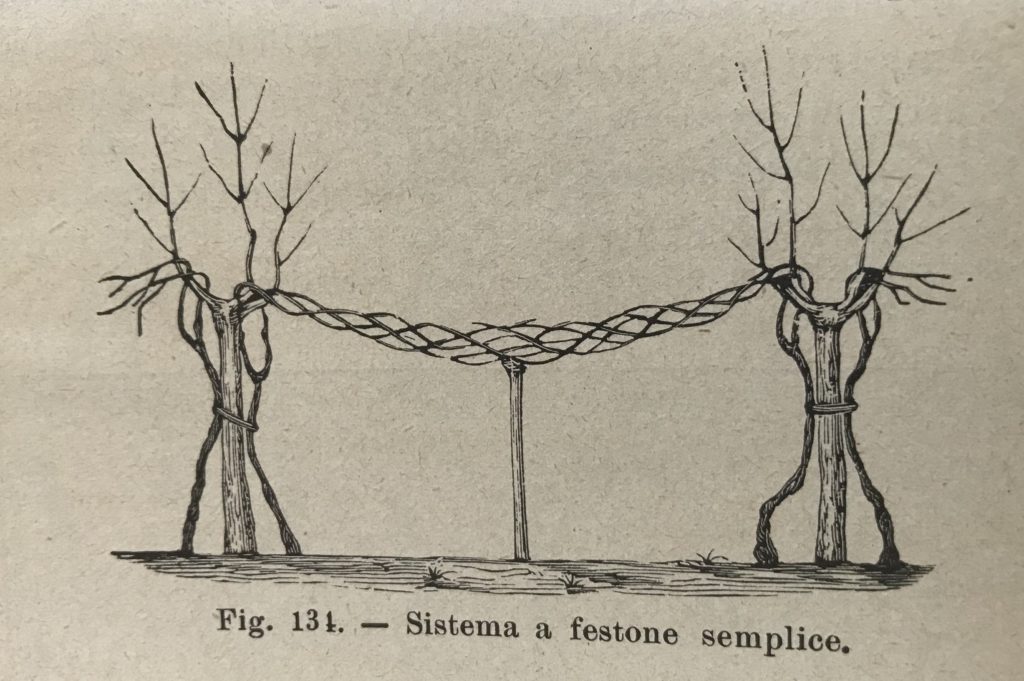


In Emilia si usava soprattutto l'olmo, in Romagna l'acero, molto più bassi. Nel Ferrarese le viti si portavano altissime su alberi di noce. Si trovano molto spesso ai margini dei campi e lungo i fossi.
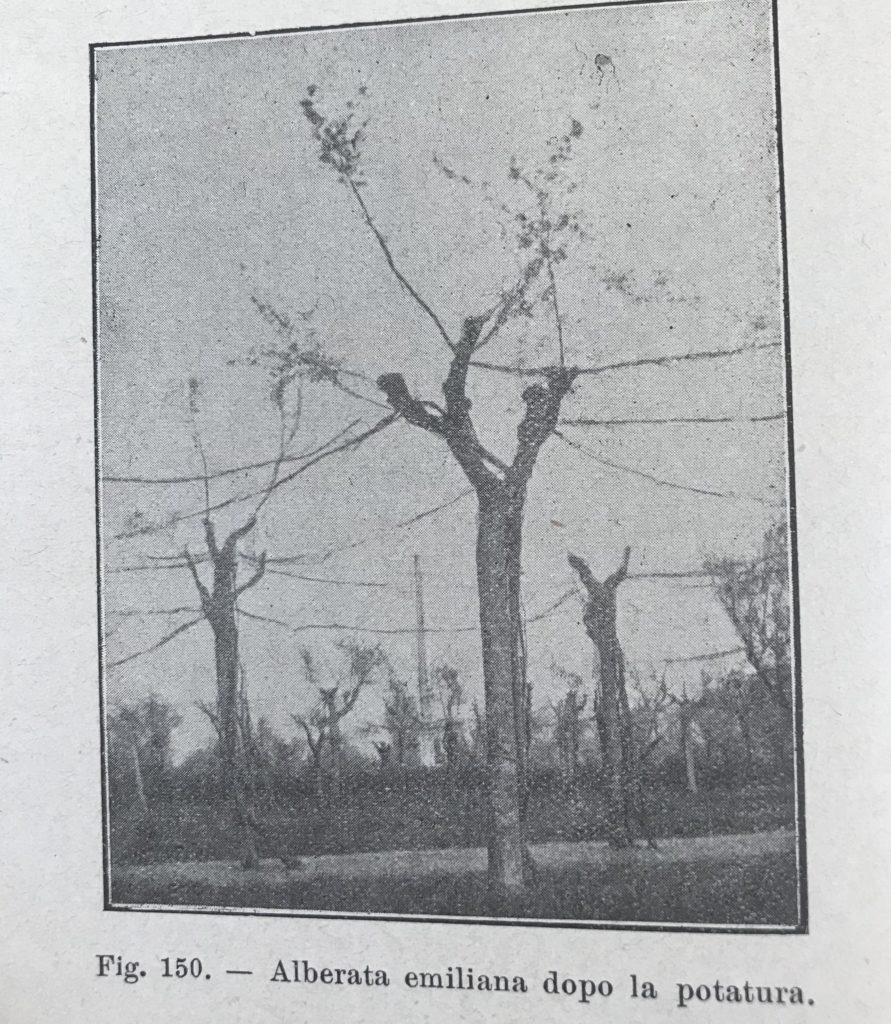
Il “sistema istriano” si basava su aceri o frassini coltivati bassi, come una ceppaia, da cui partivano numerosi rami divaricati che, ad una certa altezza, venivano riuniti a formare un cerchio. Le viti si allungavano fino al cerchio, poi si si distendevano a filare e si univano alle viti vicine. Questo sistema era usato per varietà locali come il Terrano, l'Isolana, la Nera tenera, la Crevatizza. Ottavi dice che è un sistema che sta scomparendo del tutto già alla sua epoca.
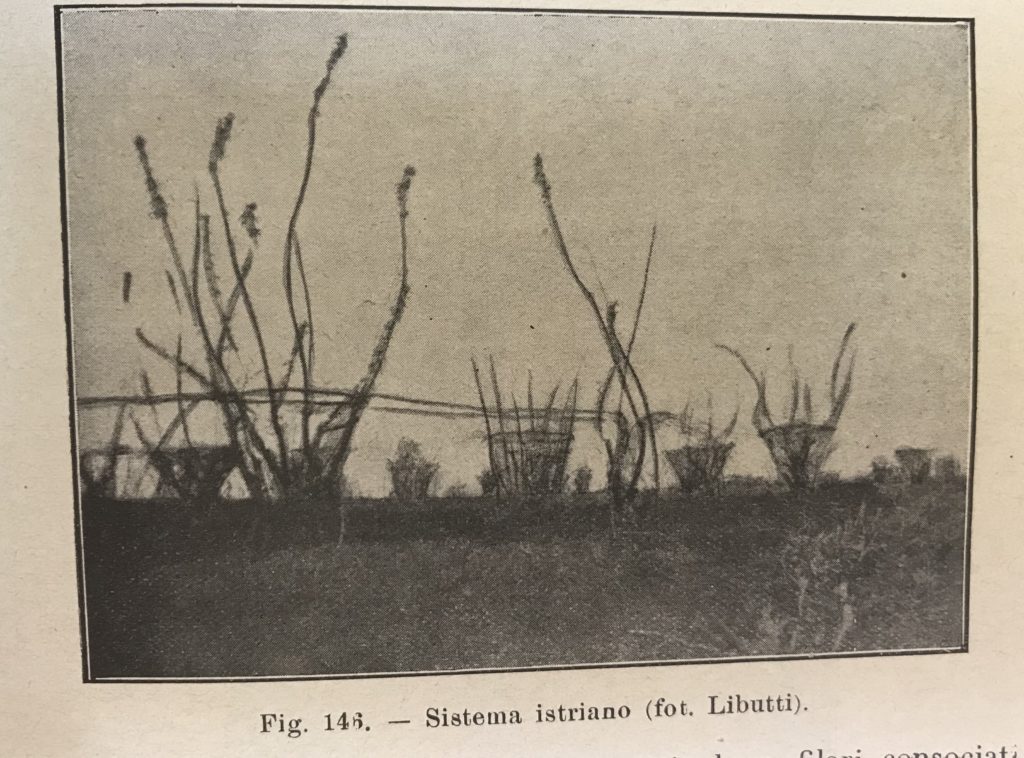
Dalle forme più tradizionali si erano poi evolute, nell'Otto-Novecento, delle forme miste con fili e pali, per cercare d'intensificare questo tipo di coltura. Un esempio era il sistema "a raggi" o Bellussi (dal nome dei fratelli ideatori). Era diffuso soprattutto in Veneto. I sistemi a raggi presentavano numerose varianti.
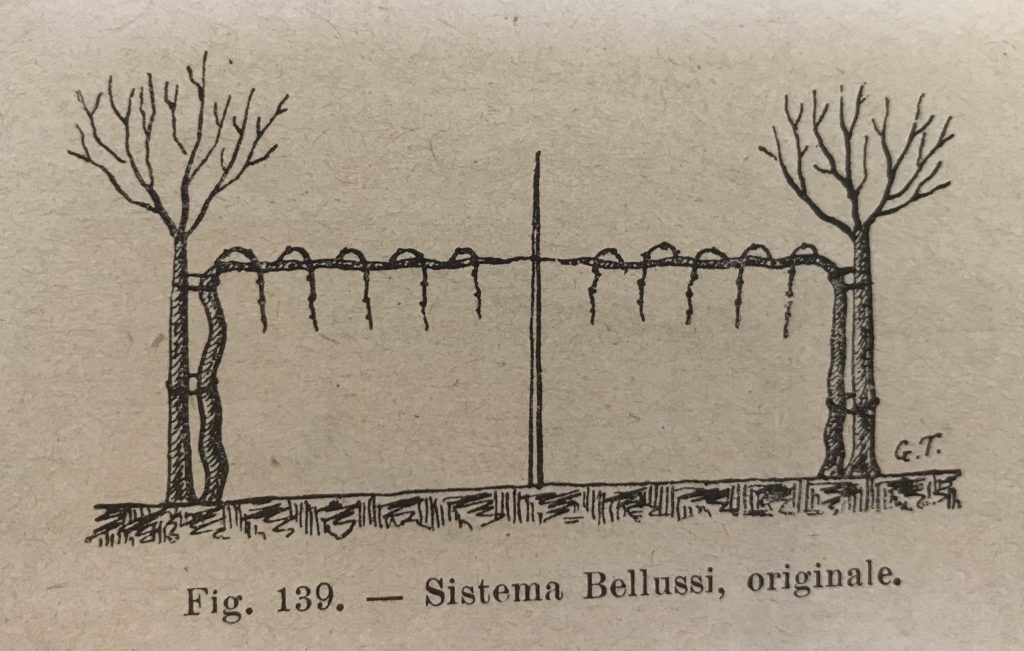
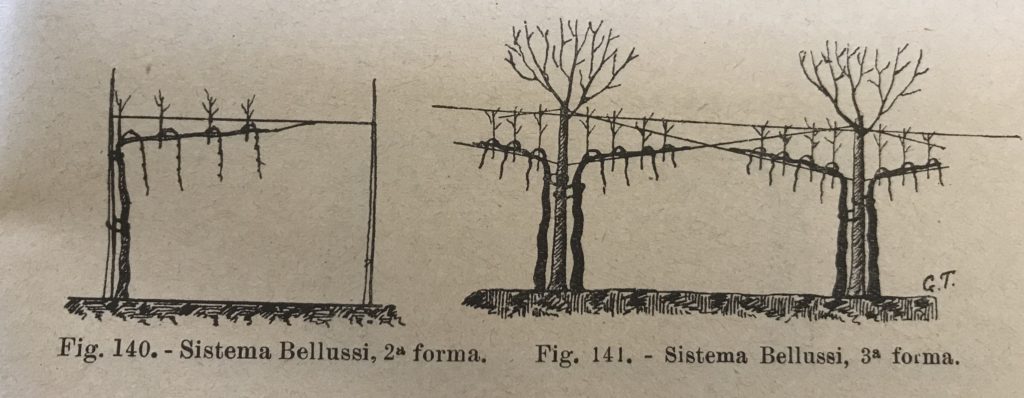
I pergolati misti erano costituiti da tutori vivi sui quali si arrampicavano viti ad impalcature in legno e fili di ferro. Si trovavano nel Tivolese, in Piemonte e in Emilia.
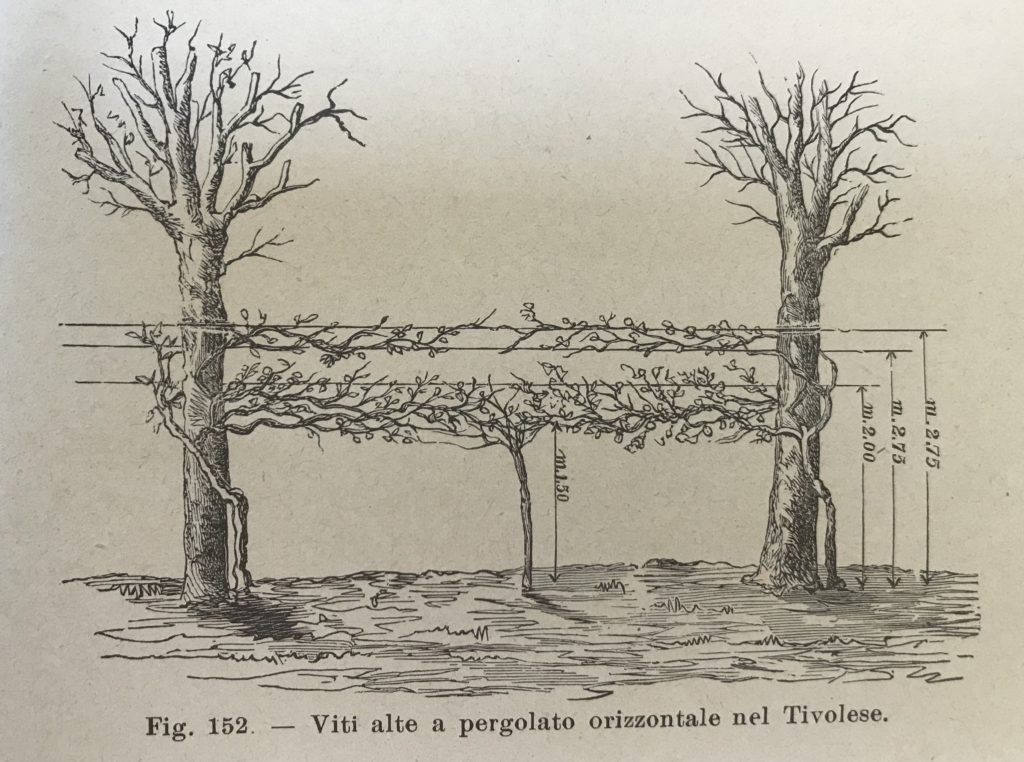
Ad ogni modo, nel Novecento questa cultura millenaria è scomparsa.
Una prima "botta" derivò nel 1920 dalla decimazione degli olmi, per una malattia causata da un fungo arrivato dall'Asia (la grafiosi).
Cavazza, nel 1924, parla di scomparsa graduale delle viti maritate anche per mutate condizioni tecniche ed economiche. Egli elenca gli svantaggi di questo sistema rispetto al tutore morto (palo): ci vuole più tempo per raggiungere la normale produzione, gli alberi ombreggiano la vite, le uve maturano più tardi, ci sono maggiori esigenze di concime (sia della vite che del tutore), maggior difficoltà e spesa nella potatura e di tutti gli altri lavori (dai trattamenti alla vendemmia).
Eppure aveva resistito per tanto tempo anche per vantaggi indubbi, elencati dallo stesso Cavazza, come la grande longevità della vigna, veramente secolare. Inoltre i tutori davano anch'essi prodotti utili all'economia agricola, come il foraggio per gli animali e le fascine. Gli alberi proteggevano in parte le viti da brina e grandine. Fra gli alberi si potevano coltivare altre specie agricole, ... Balza agli occhi come questi vantaggi appartengano però ad un'agricoltura promiscua, ad un mondo contadino che nel Novecento era ormai al tramonto.
Infatti il secondo dopoguerra ha visto una profonda trasformazione del mondo contadino italiano. La realtà produttiva moderna richiedeva ormai una viticoltura altamente specializzata. In questo nuovo mondo la vite maritata, sopravvissuta per oltre tremila anni, non ha più trovato posto.
Se volete vedere coi vostri occhi una vigna etrusca potete venire a Guado al Melo, l'abbiamo ricreata con viti selvatiche locali. Oppure potete trovare ancora una delle forme descritte sopra, nell'Aversano o in qualche piccola realtà della Toscana e dell’Emilia Romagna.
L'Italia ha certamente sacrificato tanto della sua cultura contadina alla modernità. L'importante è non perderne la memoria, perché è parte della nostra storia. Per questo un disegno di vite maritata sta sull'etichetta del nostro Atis Bolgheri DOC Superiore.
Nemmeno la morte.
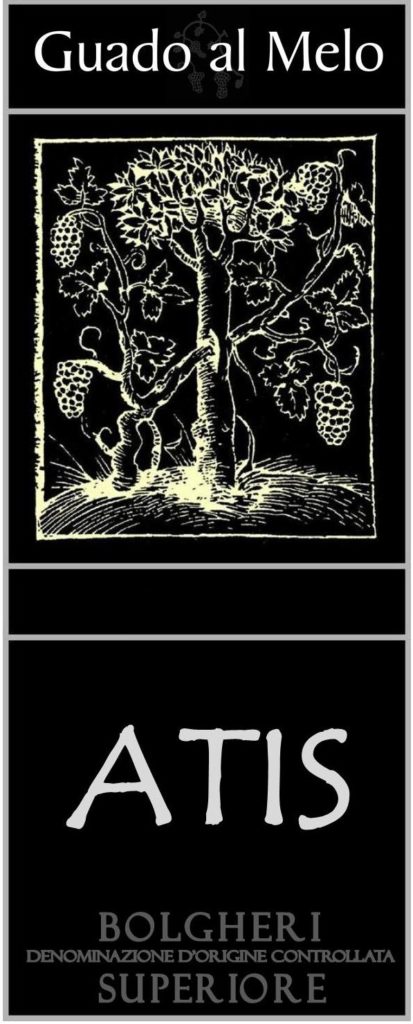
Nella prossima puntata scopriremo invece le varietà ed i vini Etruschi, oltre che le modalità di vinificazione qui.
Il vino e gli Etruschi (I): i primi vignaioli
Il vino e gli Etruschi è un tema affascinante quanto poco conosciuto. Quando si guarda all'antichità del vino italiano si pensa quasi esclusivamente a Roma. Ovviamente Roma ha avuto un ruolo fondamentale e straordinario nella storia del vino ma anche gli Etruschi sono stati rilevanti. Soprattutto sono venuti prima e hanno insegnato ai Romani tante cose.
Vi chiedere: perchè vi interessano così tanto gli Etruschi?
Perchè sono stati i primi abitanti delle nostre terre e furono i primi viticoltori in Italia. Millenni fa, quindi, erano qui al nostro posto, a fare il nostro stesso lavoro!
Ma chi erano gli Etruschi? Un ripassino dalla storia... se questa parte la conoscete già, saltatela. Dopo un inquadramento territoriale, ci dedicheremo invece in modo specifico al vino.
“… tanto potente era l’Etruria da riempire della fama del suo nome non soltanto la terra, ma il mare, per l’Italia tutta, dalle Alpi allo stretto di Sicilia...“
Tito Livio, Ab Urbe Condita, Libro I (I sec. a.C.)

Il nostro territorio è caratterizzato da un fila di colline parallele al mare, con in mezzo una zona pianeggiante paludosa, l’Alta Maremma, inospitale e dove storicamente proliferava la malaria. Fin dalla Preistoria le popolazioni vissero quindi solo sulle colline, praticando la caccia e la raccolta di prodotti spontanei. Più tardi nacquero i primi insediamenti stabili agricoli dai quali si sviluppò la civiltà etrusca.
La grande ricchezza del territorio era legata alla presenza di importanti risorse minerarie, sfruttate a partire dall’Età del Bronzo (XII sec. a.C.). A differenza dell’Etruria Meridionale, dove nacquero molte città, qui prevalse un popolamento sparso nelle campagne. Il territorio della provincia di Livorno era suddiviso fra tre città-stato: Pisa a nord, Volterra su tutta la val di Cecina fino al mare e Populonia per la zona più a sud. Gli Etruschi, ottimi ingegneri idraulici, seppero bonificare anche parte della palude ed usarla per scopi agricoli.
Il territorio dove siamo noi, Castagneto Carducci e Bolgheri, era parte della città-stato di Populonia. I resti dell'antica città sono a pochi Km dalla nostra cantina, affacciati sul bellissimo Golfo di Baratti.

Populonia decadde come città già in epoca romana. Claudio Rutilio Namaziano, nel V sec. d.C., passando lungo la costa con la sua imbarcazione, non vedeva già che rovine:
"Vicinissima, Populonia schiude il suo lido scuro
portando la baia naturale entro i campi...
I monumenti del passato non si possono vedere più:
il tempo che divora ha consumato baluardi grandiosi.
Fra i crolli della mura restano solo tracce;
tetti sepolti giacciono sotto l’estensione delle rovine.
Non indigniamoci che i corpi mortali si dissolvano:
vediamo bene, da esempi come questo,
che possono morire le città."
Claudio Rutilio Namaziano, 417 d.C.
De Reditu Suo (Sul proprio ritorno), I, 401-414

A Castagneto il sito più importante rimasto di origine etrusca è la Torre di Donoratico, purtroppo non visitabile perchè situata in una proprietà privata.

Ebbene gli Etruschi, che abbiamo ora conosciuto molto brevemente, svolsero un ruolo chiave nella diffusione della cultura del vino nel mondo occidentale.
Furono fra i primi a sviluppare la viticoltura in Italia e la diffusero in buona parte della penisola, dal Nord (Emilia Romagna) fino al Sud (Campania), Roma compresa. Grandi navigatori e mercanti, vennero a contatto con le culture del Mediterraneo orientale ed introdussero in Occidente gli aspetti culturali del vino, come il simbolismo religioso e il consumo rituale nei simposi, oltre che le varietà di vite orientali. Infine, gli Etruschi diffusero il vino e la sua cultura attraverso il commercio anche presso popoli dell’Europa Occidentale che ancora non conoscevano questa bevanda, come i Celti, i Germani e gli Iberici.
Entreremo però più nel dettaglio nei prossimi post: la viticoltura etrusca, la produzione, il vino e il suo ruolo sociale-religioso.

Segnaliamo da visitare:
Parco Archeologico di Baratti e Populonia, loc. Baratti, Piombino.
Collezione Gasparri, Via di Sotto 8, Populonia Alta.
Museo Archeologico del territorio di Populonia p.za Cittadella 8, Piombino.
Parco Archo-minerario di San Silvestro, via di Sa Vincenzo Sud 34/b, Campiglia M.ma.
Museo del Palazzo Pretorio, via Cavour, Campiglia M.ma.
Museo Archeologico di Cecina, Villa Guerrazzi loc. La Cinquantina, San Pietro in Palazzi.
Museo Civico Archeologico di Rosignano M.mo, Palazzo Bombardieri, va del Castello 24.
Area Archeologica di San Gaetano a Vada.
Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello, via del Museo 8, Castiglioncello.
Museo Etrusco Guarnacci, Via Don Giovanni Minzoni 15, Volterra.
Malvasia passita "La volpe e l'uva", dolce naturale
Ecco pronto un nuovo vino, una minuscola produzione che appaga la nostra necessità di avere un ottimo passito da bere, ma non troppo dolce!
Non amo molto i vini dolci perchè spesso hanno un dolce stucchevole, che stanca. Per questo abbiamo voluto, Michele ed io, cimentarci nella produzione di un vino molto profumato ed avvolgente, ma con una dolcezza moderata.
I profumi sono fantastici: fiori bianchi, albicocca, cannella, erbe aromatiche, scorza d'arancia, uva passa... In bocca è pieno ed avvolgente, dolce al punto giusto. Per questo l'abbinamento è versatile: ottimo come aperitivo o dopo-pasto, si abbina anche a formaggi stagionati ed erborinati, fois gras (non ne mangio, per scelta, ma non so voi). Si abbina anche ai dolci, basta che non siano troppo dolci, proprio per la sua delicatezza. E' perfetta soprattutto con dolci a base di frutta secca o cioccolato.


Perchè "La volpe e l'Uva"? Nelle notti estive ci è capitato spesso di vedere delle volpi nel vigneto e pensare alla celebre favola di Fedro “La volpe e l’uva”. Tuttavia, più che sulla morale del finale, l'abbiamo scelta soffermandoci sullo sguardo della volpe, sul desiderio intenso per quel frutto perfetto, unico e prezioso (come questo vino). Da qui nasce l'etichetta, che ho realizzato graficamente pensando sempre a questa idea di un grande desiderio che si vuole appagare! La confezione si completa con una bella scatolina in cartone, bicolore.
Perchè "dolce naturale"?
Perchè è prodotto in modo assolutamente artigianale, senza zuccheri aggiunti. Michele ha utilizzato il sistema (antico e tradizionale) detto "mistella". C'è una prima vendemmia, in cui si selezionano alcuni grappoli di Malvasia(fra i più perfetti ed assolutamente sani). Questi sono messi ad appassire su graticci in un luogo fresco ed asciutto, per alcune settimane. Un po' più tardi, a maturazione piena, abbiamo completato la raccolta, pressato l'uva in un torchio in legno manuale (quando lo usiamo sta nel nostro museo), avviando poi la fermentazione (che chiameremo mosto-vino 1). Al momento giusto, si riprendono i grappoli leggermente passiti e si spremono anch'essi nel torchio in legno a mano. Da questi si ottiene una piccolissima quantità di mosto molto concentrato e zuccherino (che chiameremo mosto 2). Aggiungendo il mosto2 al mosto-vino1, la fermentazione viene bloccata e il vino rimane dolce in modo naturale, senza aggiunte di nessun tipo. E' seguito poi un periodo d'affinamento in botti di legno non nuove, che è durato circa 4 anni.

La Malvasia è una varietà italiana spesso usata per produrre vini dolci. Noi ne abbiamo alcuni filari e abbiamo prodotto solo 593 bottiglie.
Una rete per "viaggiatori consapevoli", alla scoperta dell'identità culturale di un territorio
In inverno c'era stato presentato un progetto finalizzato a creare un marchio turistico, centrato sulla valorizzazione della cultura del territorio. Chi ci conosce (conosce Guado al Melo) sa sicuramente che sembrava fatto apposta per noi !
Ci siamo presentati e ora c'è giunta la notizia che siamo stati selezionati per far parte del progetto pilota!
Ecco in sintesi di cosa si tratta:
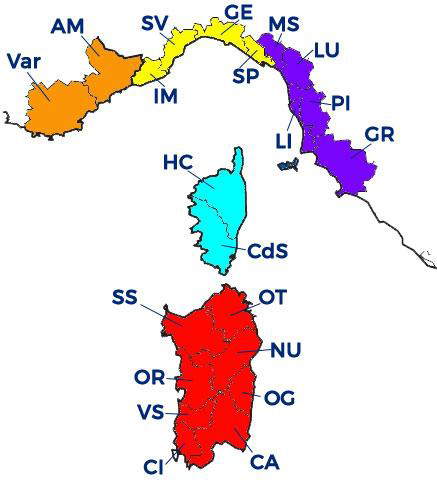 DOVE. Il progetto è centrato su una fascia di Europa mediterranea, accumunata da ambienti naturali simili e realtà culturali di continuità: la fascia costiera italiana di Toscana, Liguria e Sardegna, la costa mediterranea francese e la Corsica.
DOVE. Il progetto è centrato su una fascia di Europa mediterranea, accumunata da ambienti naturali simili e realtà culturali di continuità: la fascia costiera italiana di Toscana, Liguria e Sardegna, la costa mediterranea francese e la Corsica.
COSA. Il progetto vuole far nascere una rete di piccole realtà locali, accumunate da profonde radici territoriali e culturali. L'idea è di presentare un percorso particolare a "viaggiatori consapevoli", cioè persone alla cerca di esperienze turistiche non banali, desiderosi di incontrare realtà locali capaci di approfondire la narrazione dei propri territori, assaporando esperienze vere e uniche. La rete integra luoghi di memoria e di naturalità (come musei, città d'arte, parchi) ma anche luoghi del presente umano, rappresentati da itinerari del gusto, produzioni tipiche ed artigianali.
SOSTENIBILITA'. Le realtà che entrano a far parte del progetto devono rispondere ai principi fondamentali della sostenibilità culturale, ambientale e sociale.
IL PROGETTO. Per ora siamo ancora agli inizi. Sono state selezionate, fra le tante candidate, 80 realtà dei territori indicati, scelte per la particolare rispondenza allo spirito e finalità del progetto. Queste aziende-pilota, noi compresi, verranno ora accompagnate in un percorso di certificazione ed (eventuale) adeguamento a tutti gli standard richiesti. Dopo di che il progetto potrà essere aperto ad altre realtà e, contemporaneamente, promosso presso il pubblico.
Il progetto si chiama S.MAR.T.I.C., acronimo di «Sviluppo Marchio Territoriale Identità Culturale», è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020. http://interreg-maritime.eu/it/web/s.mar.t.i.c./progetto
Il riferimento per il territorio di Livorno è la cooperativa Itinera Progetti e Ricerche gbenucci@itinera.info +39 0586 894563 www.itinera.info/blog/
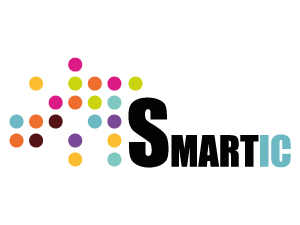
Storia della fermentazione 4: ci sono lieviti e lieviti...
(puntate precedenti qui, qui e qui)
Finora abbiamo parlato di ricerca pura, ma per la produzione di vino?
 L’applicazione pratica delle importanti scoperte fin qui descritte avvenne grazie soprattutto al microbiologo danese Emil Christian Hansen (1842-1909), alla fine dell'Ottocento. Egli conosceva gli studi di Pasteur e cercò un'applicazione pratica per il suo settore, la birra, che presentava problemi produttivi (legati alle fermentazioni) ancora più gravi che il vino. Lavorava per il grande birrificio danese Carlsberg.
L’applicazione pratica delle importanti scoperte fin qui descritte avvenne grazie soprattutto al microbiologo danese Emil Christian Hansen (1842-1909), alla fine dell'Ottocento. Egli conosceva gli studi di Pasteur e cercò un'applicazione pratica per il suo settore, la birra, che presentava problemi produttivi (legati alle fermentazioni) ancora più gravi che il vino. Lavorava per il grande birrificio danese Carlsberg.
Hansen riuscì a capire che le fermentazioni andavano spesso male proprio per la compresenza di diversi tipi di lieviti. Alcuni risultavano essere utili, altri invece erano dannosi, al punto da compromettere il processo. Lavorò allora sull'isolamento dei singoli ceppi, al fine di creare colonie pure. Ideò un sistema (nel 1883) che permetteva la propagazione da queste colonie pure, per l’uso produttivo. In particolare, egli isolò un lievito “utile”, che battezzò Saccharomyces carlsbergensis, ancora fondamentale per il settore della birra.
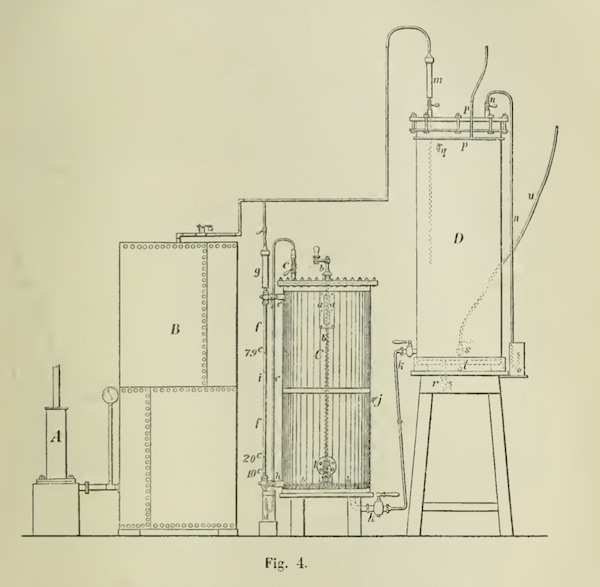
Hansen era un filantropo: decise di non brevettare la sua scoperta ma la pubblicò con indicazioni operative dettagliate, offrendola al servizio di tutti. Il suo lavoro fece fare un salto in avanti notevole a tutte le produzioni di bevande fermentate. Gli studi di Hansen furono la base infatti anche per i molti selezionatori che nei decenni successivi lavorarono sui lieviti del vino. Fra i primi, pochi anni dopo il lavoro di Hansen, si ricorda il botanico ed agronomo svizzero Hermann Müller (1850-1927), anche creatore del famoso incrocio Müller-Thurgau (Riesling renano e Madeleine Royal).
Nel 1893 nacque a Scandicci (FI) un centro di ricerca che ebbe grande rilevanza per lo studio e la selezione dei lieviti, l'Istituto per la produzione di Fermenti Selezionati Zimotecnico, fondato da docenti e studiosi dell'Istituto Agrario locale. Questo centro fu supportato e collaborò con la Scuola Enologica di Conegliano e poi con tanti esperti del settore. I lieviti qui selezionati erano messi gratutitamente a disposizione di tutti gli enologi e produttori di vino che ne facevano richiesta. Questo Istituto divenne privato nel 1933 ed opera ancora oggi.
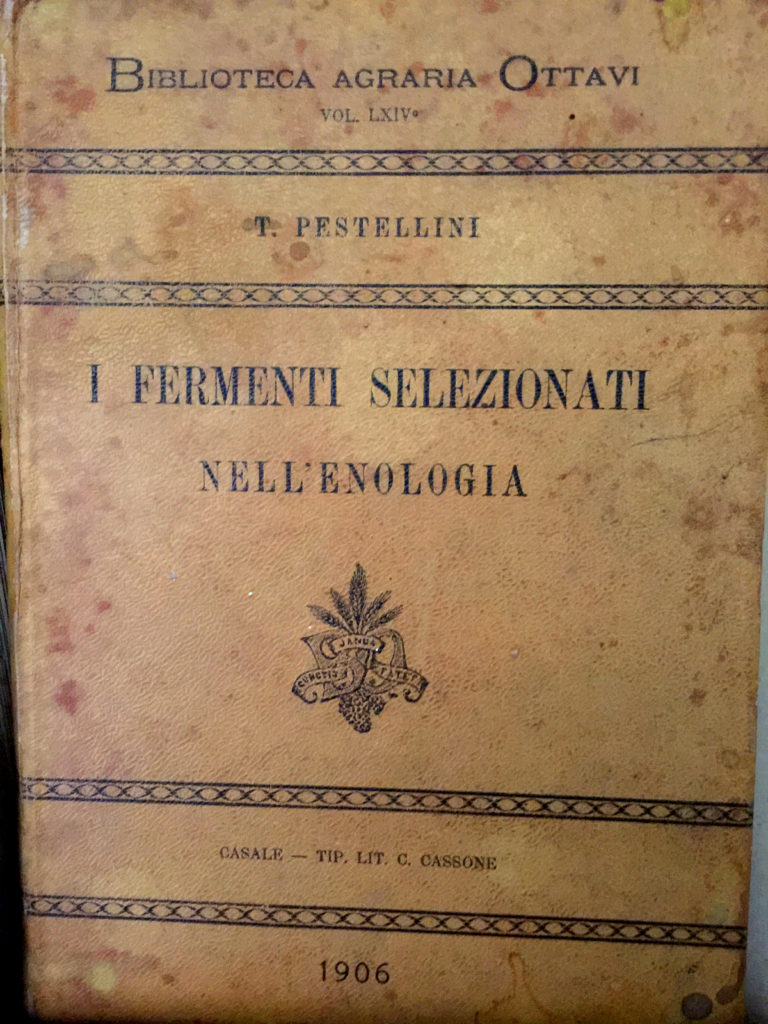
Il principio generale della selezione di un lievito è semplice: si prende l’insieme eterogeneo dei microorganismi presenti in una cantina dove le fermentazioni procedono da anni senza particolari problemi. Poi si isolano i diversi microrganismi, si creano colonie pure e ciascuno è studiato per capire come si comporta durante la fermentazione. In questo modo si selezionano quelli con un’azione migliore sul processo.
La fase pionieristica delle selezioni si concentrò sulla soluzione dei problemi fondamentali della fermentazione. Si cercarono quindi quei lieviti con ottime capacità fermentative, capaci di mettersi all'opera quanto prima, di resistere bene all'accumulo di alcool, di non produrre troppo acido acetico, ecc. Solo più tardi si sono aggiunte selezioni rivolte agli aspetti più diversi e sempre più sofisticati, come ad esempio la ricerca di una specificità rispetto a certe varietà di uva, ecc.

Non dobbiamo però focalizzare l 'attenzione solo su questo punto. Tutte queste fasi di studio sui lieviti sono state anche fondamentali per aumentare sempre più le conoscenze sui processi fermentativi nel loro complesso. Infatti la risposta ai gravi problemi produttivi del passato sulla fermentazione, superati nel corso del Novecento, non è stata data da un singolo accorgimento ma dalla sinergia di una serie di azioni ben calibrate.

In cantina gli ottimi risultati di vinificazione dipendono da un insieme di elementi che devono essere gestiti in modo attento e coordinato tra loro.
Nel corso del Novecento si è riusciti finalmente ad arrivare ad alti standard d’igiene nelle cantine. Vi ricordate che questo aspetto era stato già intuito da Columella e sicuramente anche successivamente. Tuttavia nei tempi passati era difficilmente ottenibile. In epoca moderna è stata sempre più perfezionata grazie a tanti fattori (pensiamo all'introduzione nelle cantine degli scarichi, la rete idrica, l’elettricità, detergenti e disinfettanti, il miglioramento generale dell’istruzione,…). Sicuramente l’igiene fu anche favorita dal passaggio a vasi vinari in materiali sempre più pulibili e sanificabili, come l’acciaio.
Anche la gestione delle temperature del processo si sa che è fondamentale da tempo. Nel passato le temperature però si subivano, al più si poteva cercare di sfruttare i cambi stagionali per svolgere certe operazioni. All'inizio del Novecento in realtà ci fu un certo regresso in questo senso, con la diffusione delle cantine fuori terra per questioni di maggiore economia (e spesso anche vasche esterne). Dagli anni '60, con una nuova comprensione degli effetti delle temperature sui vini, si è iniziato prima a dotare le cantine d'impianti di condizionamento molto dispendiosi, per poi tornare, soprattutto negli ultimi decenni, a costruire le cantine ipogee, come in passato. Si è iniziato a dotare anche le vasche di sistemi di controllo e possibilità di variazione delle temperatura, importante in fermentazione ma anche per per la pulizia dei vini, sfruttando fenomenici fisici di precipatazione legati al freddo.
Da Pasteur in poi si è sempre più affinata la comprensione della gestione dell’ossigeno: un’esposizione attentamente controllata è fondamentale per la buona riuscita del processo. L’uso sempre più diffuso di vasi vinari chiusi, con la possibilità di esporre il vino a ossigenazioni controllate quando necessario, ha diminuito sempre più certi problemi microbiologici ed ossidativi.
A tutto questo si è aggiunto nel corso del Novecento anche l’uso della solforosa (di cui parleremo a parte), una miglior comprensione della necessità di lavorare con uve di grande qualità e soprattutto sane, una sempre maggior consapevolezza a lavorare sulla pulizia del vino, ecc.

Si è anche approfondito sempre più lo studio sulle necessità nutritive dei lieviti, non solo in termini di zucchero, ma di composti azotati e vitamine per avere vini interessanti. Questi composti, in una produzione artigianale, derivano da uve ben equilibrate. Su questo punto purtroppo non si è al sicuro neppure oggi. Il ritorno, in alcuni casi, a concenzioni filosofiche naturalistiche un po' distorte, porta alla conduzione di vigne eccessivamente stentate che producono uve povere di questi elementi, con la conseguente difficoltà fermentativa e la nascita di vini non molto espressivi (se non difettosi). Nelle produzioni più industriali questo punto si è risolto con l’aggiunta in fermentazione di elementi nutritivi specifici.
Si sono capiti sempre meglio i ruoli e soprattutto gli equilibri determinati da pH, acidità e tante altre sostanze (ora non è il caso di scendere ancora di più nei particolari in questa sede). Si è affinata sempre più anche la comprensione di come un determinato ceppo di lievito possa avere più o meno influenza sulle caratteristiche del vino.

Tutto questo percorso ci ha portati ben oltre le premesse inziali. Ci ha permesso non solo di superare i gravi problemi nella produzione del passato ma anche d'aumentare sempre di più la qualità dei vini. Certo, c'è voluto tempo perché le conoscenze tecniche si diffondessero nel mondo agrario italiano, appesentatito da una mentalità molto restia al cambiamento. Ancora negli '70-'80 c'erano degli alti e bassi incredibili nei livelli qualitativi. All'epoca, mentre alcuni produttori già esprimevano alta o discreta qualità, molti vini erano invece ancora ricchi di difetti dovuti a carenze di conoscenze. Purtroppo ci è voluto lo scandalo del metanolo di fine anni Ottanta per far raggiungere un certo standard produttivo a tutto il comparto.
Siamo arrivati alla fine allora? Non ancora.
Arrivati negli anni Novanta, nel decennio d'oro del vino, le tecniche erano ormai affinate ed i lieviti erano ormai scontati. Si è iniziato allora a ripensare ad una riscoperta più profonda dell'artigianalità del processo, legata soprattutto alla necessità di sottrarsi ad un'omologazione sempre più spinta nel gusto dei vini. Questa sensibilità, non nuova ma portata alla ribalta, ha spinto a riflettere molto sui lieviti selezionati e il pericolo d'uniformazione che possono creare, focalizzando l'attenzione su un ritorno ai lieviti selvaggi (o indigeni o autoctoni, ci sono diverse definizioni a riguardo). Una spiegazione più dettagliata su cosa sono la trovate in altri miei predenti post, qui e qui.

Intorno a questo tema è nato un dibattito, spesso molto acceso, che ha raggiunto il suo apice in questi ultimi anni. Chi sostiene la necessità dell'inoculo pensa che sia il modo migliore per eliminare ogni possibile difetto produttivo, l'unico modo per ottenere vini fini ed eleganti. Chi sostiene i lieviti indigeni crede che l'inoculo tolga complessità al vino e lo omologhi.
Chi sostiene i lieviti selezionati dice che questi non sono quei mostri tecnologici dipinti dai detrattori. Sono lieviti presi dal loro ambiente, valutati per le loro capacità e per questo riprodotti. Alcuni lieviti stravolgono gli aromi del vino? È vero, basta non usarli! C'è chi critica l'infondatezza del concetto stesso di lievito autoctono, in quanto di massima chi conduce la fermentazione sembrano essere soprattutto lieviti derivati da contaminazioni in cantina. Non c'è dubbio che oggi tendiamo spesso ad attribuire significati confusi alla “naturalità” o meno di un alimento o di un processo.
I temi sono tanti in questo dibattito e non voglio certo elencarli tutti qui. Ne ho già parlato anche nei post di cui ho messo il link poco sopra. Molti aspetti sono interessanti e apriranno sicuramente nuove prospettive nella ricerca enologica. Altri discorsi invece sono sicuramente trascurabili, banalizzati da prese di posizione aprioristiche e prive di ogni fondamento sperimentale, spesso solo utili alle esigenze del marketing: sfumeranno nel tempo fino a scomparire, come tante altre mode.
È però ormai dimostrato che più c'è varietà nella popolazione che conduce la fermentazione, soprattutto nelle fasi iniziali, più aumenta la complessità sensoriale del vino. Inoltre non siamo più nel passato: le nostre conoscenze dei diversi fattori in gioco (elencati a grandi linee sopra) ci possono permettere di gestire (e non subire) una condizione di maggiore complessità. Ricordiamo anche che il progresso delle conoscenze consente a volte anche di capire che certe scelte iper-tecnologiche tolgono più al vino di quanto aggiungano in qualità.
Senza dubbio la gestione di una fermentazione spontanea richiede situazioni di partenza specifiche, non può essere fatta sempre (soprattutto se si parte da uva di scarsa qualità, non molto sana, ecc.). Inoltre richiede molta più cura ed accorgimenti per evitare che il vino passi dalla complessità al difetto più o meno conclamato. Qui si gioca la profonda capacità e conoscenza ( = professionalità) di un vignaiolo artigiano. Il vino prima di tutto è piacere per chi lo beve. Questo aspetto non è un optional sacrificabile per difendere i propri limiti produttivi.
In definitiva consideriamo che il lievito è fondamentale nella fermentazione e saperlo gestire su un piano di complessità è sicuramente un plus che rende i vini ancora più unici ed emozionanti. Non dobbiamo però anche dimenticare che è un elemento di una serie molto complessa di eventi che partono dal territorio, dalle tante buone pratiche e scelte fatte in vigna, dal momento delicatissimo della vendemmia e da tutto quello che viene dopo. Fermarsi solo a questo aspetto per giudicare bene o meno un vino è estremamente riduttivo.

Ho trovato un ampio ed articolato sviluppo di questo argomento su :http://www.innovino.it
Pronti per Vinitaly?
Eccoci pronti per Vinitaly, dove potrete incontrarci al Padiglione 7 stand B5, presso il nostro distributore per l'Italia Cuzziol GrandiVini. Allo stand ci saremo, come sempre, noi ad accogliervi: Michele Scienza ed Annalisa Motta.
Ci saranno le annate correnti dei nostri vini e, in più, in anteprima, le nuove annate di:



Storia della fermentazione 3: " È un animaletto che spruzza alcol dall'ano e acido carbonico dai genitali"
 Come visto nelle puntate precedenti (qui e qui), all’inizio dell’Ottocento si era arrivati a comprendere a grandi linee cosa succede chimicamente nella fermentazione, ma non si sapeva ancora il perché.
Come visto nelle puntate precedenti (qui e qui), all’inizio dell’Ottocento si era arrivati a comprendere a grandi linee cosa succede chimicamente nella fermentazione, ma non si sapeva ancora il perché.
Questa non è una domanda da poco. Infatti la produzione di vino fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento era ancora enormemente limitata da problematiche tecniche che rendevano troppo fragile il settore. Le fermentazioni non partivano oppure s’arrestavano inspiegabilmente. Inoltre, con grande frequenza, subentravano alterazioni irrimediabili del vino, soprattutto in fase di conservazione. Per risolvere questi problemi non era sufficiente aver capito cosa succedeva. Era essenziale capire il perchè ed approfondire ancor di più il processo.
All’inizio dell’Ottocento la Francia aveva già un settore vitivinicolo molto avanzato, che rappresentava un importante fattore economico nazionale. Quindi fu lo stesso governo a stimolare e supportare le ricerche sul vino. Ad esempio, nel 1803 l’Istituto di Francia offrì un premio in 1 Kg di oro, riproposto nel 1805, a chi fosse stato in grado di dare risposte alle domande sulla fermentazione alcolica, ma nessuno fu in grado di farlo. L'attenzione rimase però altissima.
All'inizio dell'Ottocento si continuava a cercare una spiegazione sul perché della fermentazione solo da un punto di vista prettamente chimico. La teoria presa in maggior considerazione, qualche anno più tardi, fu quella del famoso chimico tedesco Justus von Liebig. Egli ipotizzò che la reazione avvennisse per via del moto delle molecole. Questo causerebbe degli scontri che portano ad un disequilibrio nelle forze che tengono insieme la molecola di zucchero, ottenendo come risultato la sua decomposizione in sostanze più semplici.
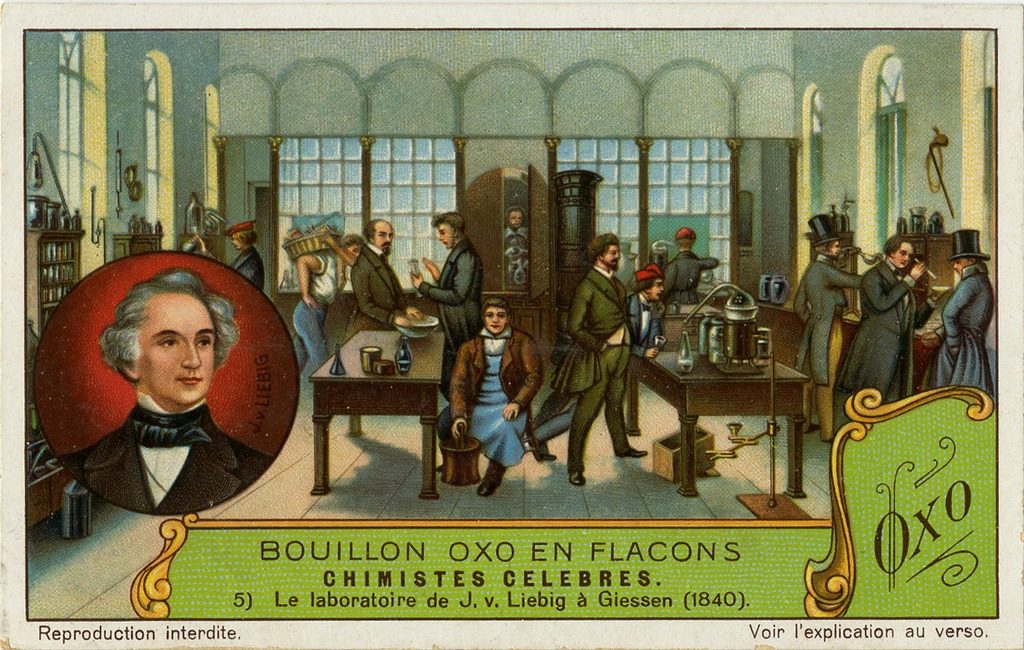
Una spiegazione puramente chimica era la più accettabile e lineare col pensiero di quel tempo. All’epoca si conosceva già l’esistenza dei microrganismi, ma non erano presi molto in considerazione. Anche quando alcuni primi studi sembrarono dimostrare un ruolo dei microrganismi nelle fermentazioni, ci volle diverso tempo perchè fossero accettati.
Il pensiero dominante dell’epoca era che i microrganismi fossero un mondo a parte, da non prendere in considerazione, un universo in miniatura che non poteva avere influenza sul nostro. Inoltre da secoli predominava il cosiddetto vitalismo, già accennato rapidamente con van Helmont. Secondo questo pensiero, largamente diffuso, le leggi chimico-fisiche (che erano via via scoperte) riguardavano essenzialmente la materia inanimata, solo secondariamente gli esseri viventi. Si continuava a credere che i fenomeni della vita avessero proprietà particolari (dette “psico-chimiche”) e che fossero governati da leggi proprie. Nell’Ottocento c’erano ancora molti strascichi in questo senso, nonostante l’avanzare delle conoscenze. Ad esempio, a lungo si credette che le sostanze proprie degli esseri viventi (come grassi o zuccheri) potessero derivare esclusivamente da organismi viventi. Per questo una delle grandi rivoluzioni dell’Ottocento fu capire senza più ombra di dubbio l'importante nesso fra vita e chimica (dando il via alla nascita della biochimica).
L'esistenza di un mondo microscopico, già ipotizzata da alcuni, fu dimostrata per la prima volta dall'olandese Anton van Leeuwenhoek nel XVII secolo. Riuscì a perfezionare i primi microscopi, ottenendo un ingrandimento mai visto prima (fino a 270 volte!). Con questo strumento riuscì ad osservare per la prima volta dei microrganismi nel 1676. Ipotizzò che fossero esseri viventi perché si muovevano e li chiamò “animalcula”, cioè piccoli animali.

La scoperta del mondo piccolo non fu però accettata subito da tutti, per lo meno non con questa interpretazione. Ancora nel Settecento c'era chi credeva che gli animaletti di van Leeuwenhoek non fossero altro che particelle vitali fuoriuscite da materia morta. Infatti, in linea col vitalismo, si credeva che la vita, soprattutto quella di certi animali “inferiori” (insetti, vermi o pidocchi), derivasse da materia inanimata che prendeva vita grazie a delle particelle, “atomi” vitali indistruttibili ed immortali, alla base anche delle attività fisiologiche degli esseri viventi. Alla morte dell'animale queste particelle tornavano in libertà e si ricombinavano con la materia inorganica per generare altri esseri viventi.
Facciamo un ulteriore salto all'indietro, perché questi concetti nascono e si ricollegano ad un pensiero antichissimo, avallato da Aristotele e da tanti altri dopo di lui, trasversale fra le più diverse culture: la famosa teoria della generazione spontanea. Secondo questa teoria gli esseri viventi “inferiori” originano dalla materia inanimata che viene “attivata” in determinate condizioni. Testi dell'antica Cina riportano come le mosche nascano dal sudore. Per i babilonesi i vermi nascevano dal fango. Nel Medioevo e nei secoli successivi si credeva che i topi e altre bestie simili nascessero dallo sporco, dal sudore o dalla materia putrescente (vi ricordate di van Helmont?). 
La teoria della generazione spontanea venne per la prima volta messa in discussione per mosche, larve o altre insetti, dai celebri esperimenti del medico e letterato italiano Francesco Redi (1668), basati sul metodo sperimentale.
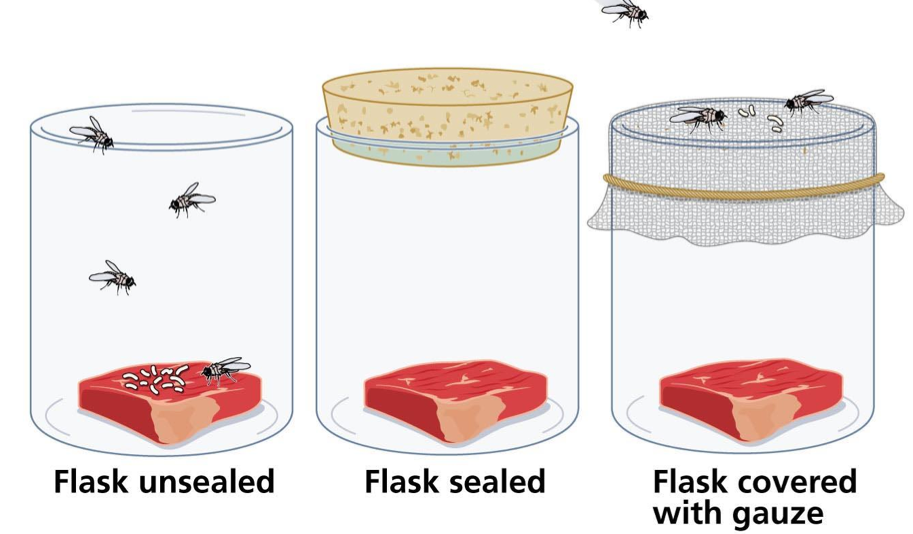
Le sue dimostrazioni aprirono un ampio e lungo dibattito, con sostenitori e detrattori. Tuttavia, se non più applicabile per insetti, la teoria tornò alla ribalta con la scoperta degli "animalcula". A questo contribuì il lavoro del naturalista inglese John Turberville Needham che, all’epoca, ebbe una grande eco. Nel 1745 pubblicò i risultati di una serie di esperimenti che sembravano dimostrare in modo scientifico la fondatezza della generazione spontanea per questi piccoli esseri (in “New microscopical Discoveries”).
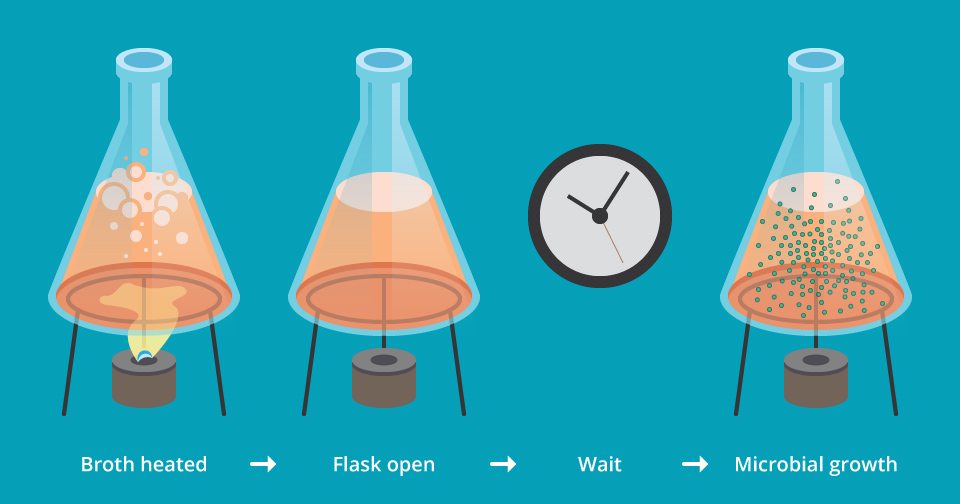
Questa dimostrazione gli valse quasi la nomina a membro della Royal Society di Londra, se non fosse stato per quel guastafeste di Lazzaro Spallanzani.
Dopo Redi, ci volle infatti un altro illustre scienziato italiano, Lazzaro Spallanzani appunto, a contrastare questa visione. Egli studiò questo piccolo mondo, sostenendo l'ipotesi che gli infusori fossero esseri viventi e non particelle vitali. Nel 1765 pubblicò un lavoro che dimostrava la fallacia dell'esperimento di Needham (“Saggio di osservazioni microscopiche concernenti il sistema della generazione de’ signori Needham e Buffon”).
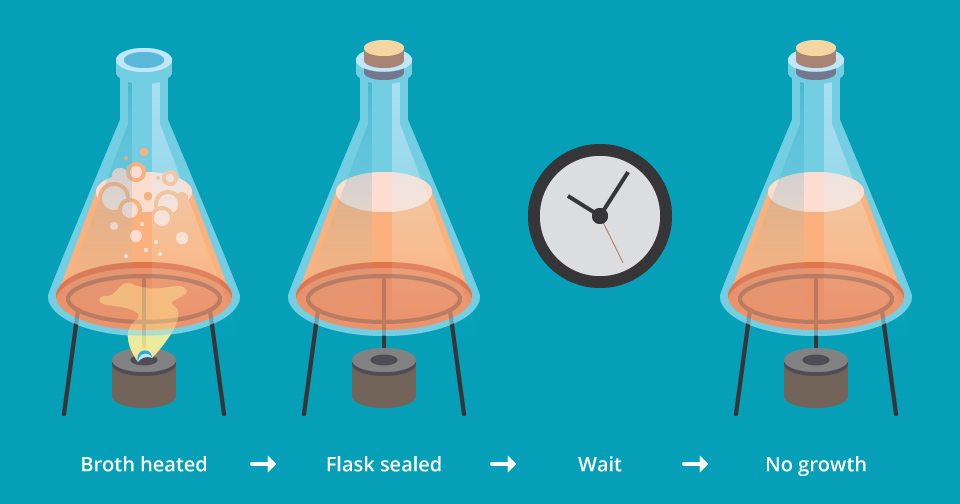
Dimostrò anche che era qualcosa di vivo a causare la fermentazione alcolica del vino, perché era possibile impedirla con la bollitura del mosto (1765).
Eppure l’esperimento di Spallanzani non convinse del tutto i sostenitori della generazione spontanea. C’era chi criticava la bollitura, che avrebbe potuto eliminare anche quegli “atomi vitali” che avrebbero dovuto rigenerare gli infusori. C’era chi invece criticava la chiusura dei contenitori, sostenendo che questo impediva l’accesso dell’aria. Inoltre le idee di Needham erano supportate dal celeberrimo naturalista francese Buffon, la cui autorità contribuì ad offuscare il lavoro di Spallanzani.
Intanto l'attenzione di alcuni studiosi si concentrò anche su alcune antiche pratiche empiriche nella produzione del vino. Vi ricordate di quelle "cose strane" messe nei tini di cui ci ha già parlato il conte Dandolo? Oltre a lui anche altri ne parlavano, ma uno in particolare ebbe un'eco rilevante: il fiorentino Adamo Fabbroni o Fabroni (si trovano entrambe le versioni) (1748-1816). Nel suo testo “Sull’arte di fare il vino” (1787) dedicò alcune parti alla descrizione di certe pratiche tradizionali, basate sull'aggiunta al mosto di alcune sostanze che sembravano facilitare la fermentazione.
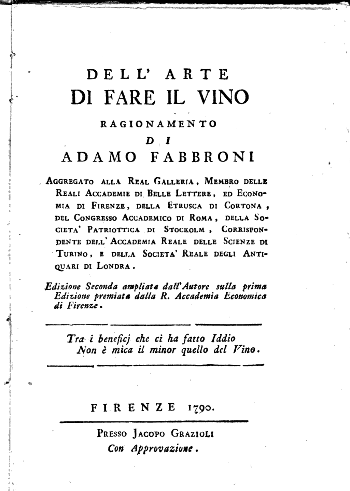
Fabbroni fa un elenco delle diverse tradizioni in tal senso, ricordando l'aggiunta di pasta madre del pane o la sola parte glutinosa, foglie di vite o altre piante, la spuma o i depositi della birra e del vino in fermentazione. Ricorda come Plinio raccontava che si usasse spuma di cerevisia (birra) in antichità. Racconta che i Cinesi preparano un vino con l’aggiunta di cereali e pezzi di carni di agnello. I Mossi, abitanti dell’America Meridionale, fermentavano il granoturco con l’aggiunta della loro saliva. Allo stesso modo gli abitanti di Formosa facevano col riso. Il romano Ulpiano (circa 170-228 d.C.) raccontava che si preparava una bevanda alcolica solo col pane, chiamata zyhtum.
Secondo lui tutte queste sostanze sono accomunate dal contenere una sorta di materia “vegeto-animale” (così la chiama, perchè di origine a volte vegetale e a volte animale) che secondo Fabbroni è capace d'incrementare in qualche modo la fermentazione.
Egli stesso racconta di aver verificato che, se la fermentazione stenta ma non mancano le altre componenti, questo può essere dovuto proprio al difetto di materia “vegeto-animale”. In questi casi, dice, è utile aggiungere alla vasca della spuma di altri tini già in fermentazione oppure della pasta di pane, glutine oppure del pane stesso.
 Fabbroni non investigò oltre in questo senso, perchè anche lui era più concentrato sulla parte puramente chimica. Per Fabbroni il responsabile della fermentazione è soprattutto un acido nitroso o acido dell’uva. Critica anche Macquer nella sua ipotesi che lo zucchero sia la materia fermentata. Per Fabbroni lo zucchero ha un ruolo ma è soprattutto il tartrato ad avere una funzione fondamentale nella fermentazione.
Fabbroni non investigò oltre in questo senso, perchè anche lui era più concentrato sulla parte puramente chimica. Per Fabbroni il responsabile della fermentazione è soprattutto un acido nitroso o acido dell’uva. Critica anche Macquer nella sua ipotesi che lo zucchero sia la materia fermentata. Per Fabbroni lo zucchero ha un ruolo ma è soprattutto il tartrato ad avere una funzione fondamentale nella fermentazione.
Tuttavia il suo trattato ebbe una certa diffusione, grazie anche al fatto che una prima stesura fu vincitrice di un concorso indetto dall'Accademia dei Georgofili nel 1875. Il premio era rivolto a selezionare testi utili per il miglioramento della manifattura e conservazione del vino, al fine d'incentivare l'esportazione.
Così le sue indicazioni sull'aggiunta della materia "vegeto-animale" vennero riprese da Jean-Antoine Chaptal nel suo trattato "L’Art de faire, de gouverner et de perfectionner les vins." (1800), considerato uno dei più importanti della sua epoca. Più tardi arrivarono in questo modo anche a Pasteur, come egli stesso racconta nel suo "Trattato sul vino". Pasteur intuì quello che accomuna tutte queste sostanze: l’apporto di microrganismi al mosto. Questo però avvenne molti anni dopo.
Intanto, all'inizio del XIX secolo, i microscopi ebbero un'importante evoluzione grazie al fisico modenese Giovanni Amici. Il suo lavoro permise di risolvere problemi di aberrazione nella visione, rispetto ai modelli precedenti, consentendo di osservare i microrganismi con grande precisione. Questo miglioramento dello strumento diede il via al lavoro indipendente di tre studiosi, considerati oggi pionieri della microbiologia, anche se all'epoca non vennero presi molto in considerazione.
Il primo fu il francese Charles Cagniard de Latour (1777-1859) che esaminò al microscopio la birra e il vino, pubblicando i risultati nel 1837 in "Mémoir sur la fermentation vineuse".

Descrisse i lieviti come dei globuli e affermò che non erano sostanza inerte o chimica, come si pensava fino ad allora, ma esseri vitali. Ipotizzò però che appartenessero al mondo vegetale perché non si muovevano. Fece anche lui delle prove che dimostravano che fossero in grado di compiere la fermentazione solo se vivi.
Friedrich Traugott Kützing (1807-1893), farmacista e botanico tedesco, pubblicò nel 1837 (poco dopo Latour) descrizioni e disegni delle cellule di lievito.

Egli suggerì che diversi tipi di microrganismi causassero diversi tipi di fermentazione.
Theodor Schwann (1810-1882), biologo tedesco, osservò i lieviti e li descrisse come dei funghi ( “A preliminary communication concerning experiments on fermentation of wine and putrefaction”, 1837). Chiamò questo organismo Zuckerpilz (fungo dello zucchero), da cui deriva ancora oggi il nome scientifico Saccharomyces (significa la stessa cosa in greco antico). Dai suoi studi concluse che la fermentazione doveva essere una decomposizione dello zucchero e delle sostanze azotate che il fungo usa per crescere. Gli elementi non utilizzati sono invece convertiti in alcol.

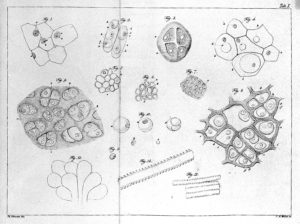
Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Questi lavori passarano però in secondo piano a causa dell'intervento critico dei tre chimici più influenti del tempo, i tedeschi Justus von Liebig (1803-1873, quello dell’ipotesi del moto delle molecole), Friedrich Wöhler (1800-1882) e lo svedese Jöns Berzelius (1179-1848). Questo evento, secondo gli esperti del settore, ritardò lo sviluppo della microbiologia di circa vent'anni.
Addirittura von Liebig e il suo associato Friederich Wöhler arrivarono a scrivere una parodia ridicolizzante della teoria microbiologica, che fu pubblicata (in modo anonimo) sulla rivista scientifica "Annalen der Pharmacie" di cui erano curatori (vol. 29, pp. 100-104, 1839). L'articolo s'intitolava “Il mistero sbrogliato della fermentazione alcolica “ (“Das enträthselte Geheimniss der geistigen Gährung”). 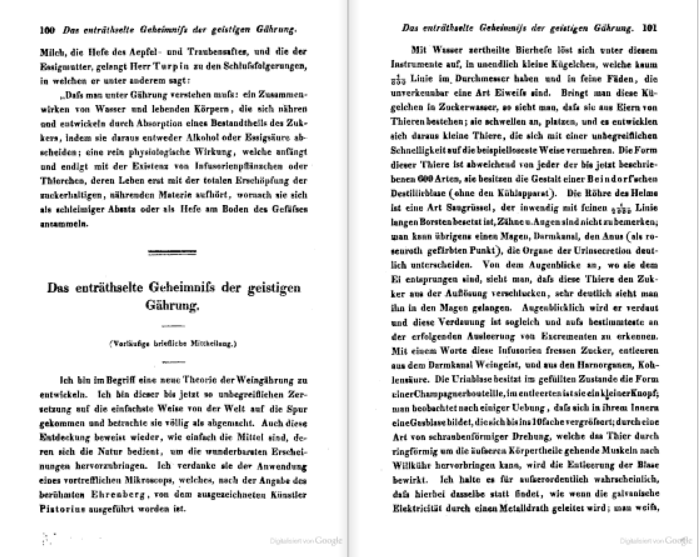
Eccone alcune parti, scritte in prima persona, con tono molto ironico. Prendono in giro quelle che per loro sono solo sciocchezze:
“Sto sviluppando una nuova teoria della fermentazione. Ora sono in grado di spiegare questa forma di decomposizione finora del tutto incomprensibile nel modo più semplice possibile e quindi considerate la questione pienamente risolta... Questo lo debbo all'utilizzo di un eccellente microscopio...
Quando i lieviti della birra sono sospesi in acqua ed osservati al microscopio, si trasformano in numerosissime minuscole sferule... Quando queste sferule vengono poste in una soluzione zuccherina, diventa ovvio che siano delle uova di piccoli animali, perché si gonfiano, scoppiano e si trasformano in creature minute che iniziano a moltiplicarsi in modo inimmaginabilmente veloce....
Non sono stato in grado d'identificare denti o occhi. Questi animali possiedono uno stomaco, intestino, ano (un punto colorato di rosa) e organi urinari. Dal momento in cui si schiudono, iniziano a divorare lo zucchero dalla soluzione, che può chiaramente essere visto entrare nello stomaco. In un batter d'occhio, viene digerito e i prodotti digeriti possono essere riconosciuti con sicurezza dagli escrementi ....
![2_-_Our_Friend_Yeast[1]](https://www.guadoalmelo.it/wp-content/uploads/2018/04/2_-_Our_Friend_Yeast1-292x300.png)
Se la quantità di acqua è insufficiente, cioè la concentrazione di zucchero troppo alta, la fermentazione non avviene... Questo perché i piccoli organismi non possono cambiare il loro posto nel liquido viscoso: muoiono per l'indigestione causata dalla mancanza di esercizio fisico. "
Come già accennato, i chimici non riuscivano ad accettare la teoria microbiologica anche perchè gli sembrava inverosimile che esserini così piccoli potessero produrre effetti così evidenti. Infatti scrivono, sempre in modo ironico:
"...Per dare un'idea dell'enorme voracità delle creature, … 3 parti di lievito di birra possono trasformare 200 parti di zucchero in alcol e acido carbonico. Gli escrementi che producono in 18 ore pesano quasi 66 volte il loro stesso peso ... Non appena gli animali esauriscono lo zucchero, cominciano a mangiarsi l'un l'altro ..."
Nel 1839 entrò nella disputa anche Berzelius, sostenendo che le osservazioni al microscopio non avevano valore scientifico e che il lievito non era un organismo. La fermentazione avviene, secondo lui, per mezzo della catalisi (termine da lui da poco introdotto). Infatti Berzelius aveva introdotto questo termine dimostrando la capacità di alcune sostanze di accelerare una reazione senza esserne modificate. Diversi chimici seguirono questi studi, fra cui proprio Wöhler e von Liebig, i quali estrassero dalle mandole amare uno di questi catalizzatori. Affermarono che, in modo analogo, nella fermentazione ci dovesse essere un’azione catalitica, continuando a rigettare l’ipotesi microbiologica.
Tuttavia alcuni scienziati iniziarono invece ad accettare l'idea che il lievito potesse avere un qualche ruolo. Arriviamo quindi finalmente a Louis Pasteur che pose fine a diatribe ormai secolari.

Gli studi Pasteur, che hanno fondato la microbiologia, dimostrarono definitivamente che i batteri nascevano da altri batteri o da una specie di “semi”, dette spore, che potevano essere trasportate anche a grande distanza dal vento, da insetti o altro. Ripeté una versione ancora più perfezionata degli studi di Spallanzani che chiusero la questione della generazione spontanea (1864). Si stabilì così che ogni essere vivente deriva da un altro essere vivente (biogenesi).
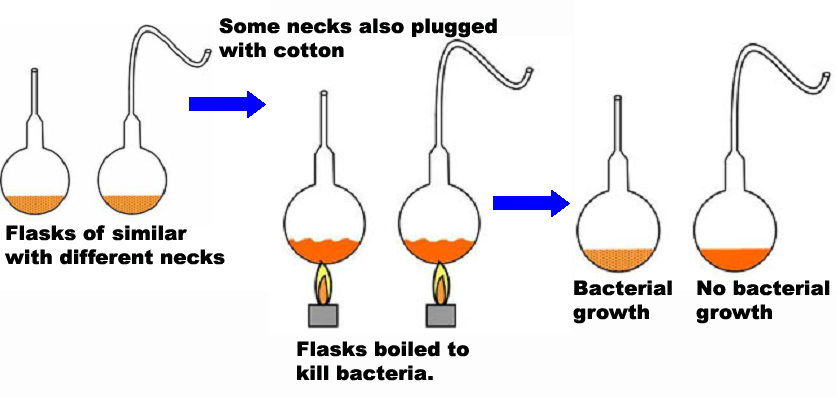
I suoi primi studi sulla fermentazione della birra iniziarono nel 1857. Questi suoi primi lavori attirarono l'attenzione del Governo francese che gli commissionò di approfondire gli studi sul vino. Era più che mai d'interesse nazionale riuscire a trovare rimedi ai problemi di vinificazione. Pasteur pubblicò i suoi studi sul vino nel 1866.
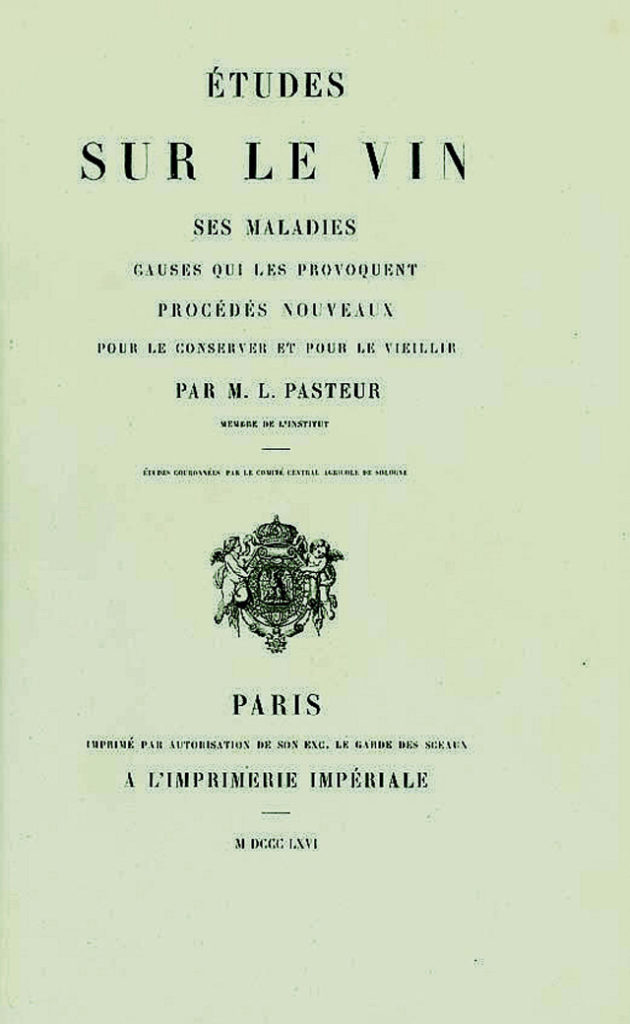
Dimostrò anche che i microrganismi erano in grado di agire su succhi, latte o altro con cui venivano in contatto, grazie a delle loro proprietà che Pasteur non spiegò e chiamò “fermenti”. Dimostrò che i microrganismi non erano tutti uguali, che esisteva una correlazione fra un dato microrganismo e un certo tipo di fermentazione.
Pasteur dimostrò il ruolo del lievito nella fermentazione alcolica e come questa fosse un fenomeno fisiologico. Questo accese una polemica con lo scienziato Marcellin Berthelot che invece ipotizzava che il lievito rilasciasse nel liquido le molecole, dei “fermenti solubili”, che svolgevano di fatto la fermentazione.

Pasteur identificò due classi di microrganismi, l’uno in grado di vivere solo in presenza di ossigeno e l’altro no, definendoli, rispettivamente, aerobi ed anaerobi (termini coniati da lui). Capì anche che il lievito svolge la fermentazione alcolica in assenza di ossigeno. Se questo è presente, il lievito si sviluppa ugualmente, ma la fermentazione alcolica è inibita. Più tardi si chiarirà come questo sia dovuto alla capacità del lievito di avere un metabolismo anaerobio (la fermentazione) ed anche aerobio (cioè la classica respirazione che facciamo anche noi).
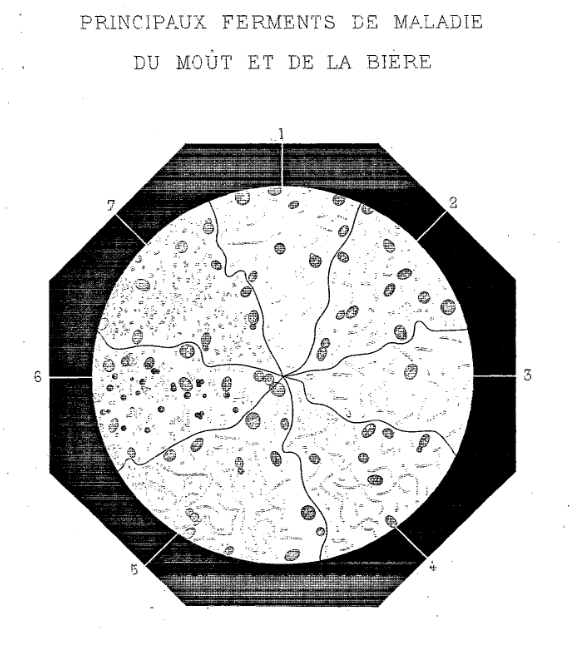
Pasteur studiò poi le principali alterazioni del vino dell'epoca, cioè la parziale acetificazione (lo spunto acetico, causato dai batteri acetici), il girato, il filante, l’amaro (o amarone). Queste ultime erano malattie molto comuni nel passato ma scomparse quasi del tutto ai nostri giorni. Pasteur esaminò moltissimi campioni prelevati da vasche alterate e ricondusse queste malattie alla presenza di diversi microorganismi, ciascuno caratteristico di una certa alterazione.
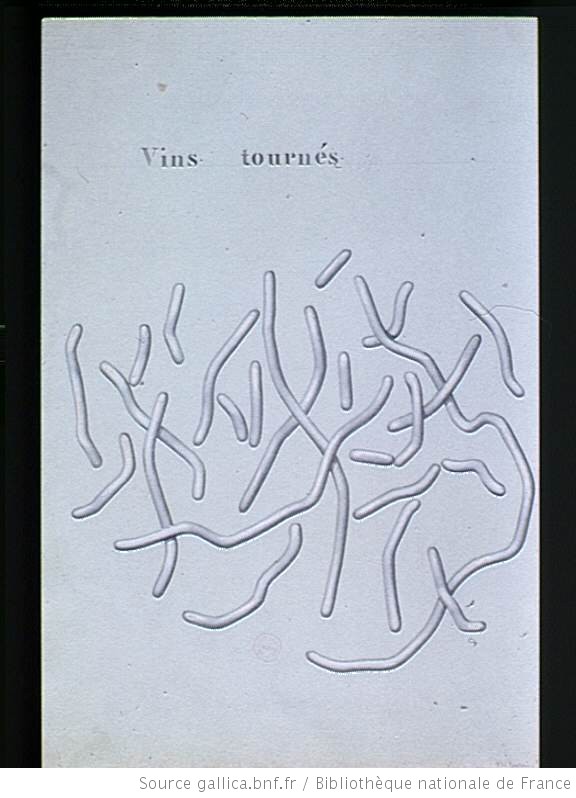
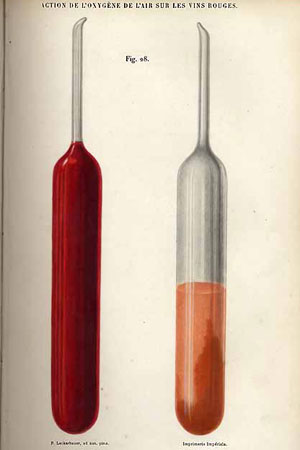 Non era semplice trovare un rimedio. Non poteva certo bollire il vino, altrimenti lo avrebbe rovinato nel gusto. Non poteva neppure usare i disinfettanti disponibili all'epoca! Arrivò allora ad ideare un metodo basato sul riscaldamento del vino a bassa temperatura e in assenza di ossigeno. Dimostrò che questo trattamento bastava per sterilizzarlo in modo sufficiente. Egli brevettò la scoperta, chiamandola pastorizzazione, e la presentò all’Accademia delle Scienza il primo maggio 1865.
Non era semplice trovare un rimedio. Non poteva certo bollire il vino, altrimenti lo avrebbe rovinato nel gusto. Non poteva neppure usare i disinfettanti disponibili all'epoca! Arrivò allora ad ideare un metodo basato sul riscaldamento del vino a bassa temperatura e in assenza di ossigeno. Dimostrò che questo trattamento bastava per sterilizzarlo in modo sufficiente. Egli brevettò la scoperta, chiamandola pastorizzazione, e la presentò all’Accademia delle Scienza il primo maggio 1865.
Questo procedimento, ulteriormente affinato, è ancora oggi utilizzato per diversi alimenti, come ad esempio il latte, la birra o succhi di frutta. Per il vino fu usato fino agli anni ’30 del Novecento, senza però avere mai una grande diffusione, per via dell’idea (vera o presunta) che ne alterasse comunque il gusto.
Pasteur fece anche diversi studi sui processi d'invecchiamento del vino e capì il ruolo dell'ossigeno in questa trasformazione.

Riassumendo, l'Ottocento fu un periodo di grande importanza per la fermentazione alcolica, con anche grandi scontri fra scienziati geniali. Abbiamo visto le spiegazioni chimiche di von Liebig e altri, che però non volevano accettare l'intervento dei piccoli infusori. Poi ci fu Berzelius, che sosteneva la sua teoria catalitica. Infine Pasteur, paladino dei microrganismi che svolgono una funzione fisiologica. Rimase però in lui un rimasuglio del pensiero vitalistico: sostenne fino alla fine che i processi fermentativi, pur spiegabili con formule chimiche, potessero avvenire solo alla presenza di organismi viventi.
Eppure, alla fine di questa storia, si capì che in fondo avevano ragione tutti e tre. Ognuno era però rimasto ostinatamente ancorato ad un solo aspetto del problema.
Questo chiarimento avvenne soprattutto grazie al lavoro del chimico tedesco Eduard Buchner (1860-1917) che nel 1897, due anni dopo la morte di Pasteur, dimostrò che l'attività fermentativa poteva essere attuata anche in assenza dei lieviti, ma solo con estratti di essi. Egli dimostrò che i “fermenti” già intuiti da Pasteur fossero alcune proteine contenute nei lieviti.
Solo mettendo insieme i lavori di tutti (come spesso accade nella scienza) si poté ricostruire il quadro completo. Si definì così che la fermentazione è un processo di nutrizione di un organismo vivente ma che può essere riprodotto in sua assenza, in quanto si tratta di una reazione chimica catalizzata da enzimi (proteine) presenti nelle cellule.

Da qui si è aperto un mondo: da lì in poi, con tecniche sempre più fini, si è esplorato sempre più a fondo il mondo della biochimica e della microbiologia.
Ad oggi, siamo arrivati a conoscere molto bene i responsabili della fermentazione (qui e qui), fino alla sequenza completa del loro DNA.
Questa però è ricerca pura, ma ... e il vino?
(continua...)
La fermentazione nella storia 2: "È rarefatto in Spirito"
Dopo le epoche più antiche, le prime interpretazioni sul processo di fermentazione in sé compaiono solo nell'era degli alchimisti-scienziati, il Seicento. È il momento storico in cui, pur mescolando ancora aspetti oscuri a una primitiva scienza sul nascere, l'investigazione sul mondo si fa comunque più profonda e curiosa.
La comprensione di questo processo iniziò con l'osservazione del fatto che con la fermentazione si forma una sostanza che prima non c'era: l’alcol (anche se allora non era chiamata così). L’identificazione di questa sostanza (in senso molto generico) trova le sue radici nella distillazione e nell'alchimia.

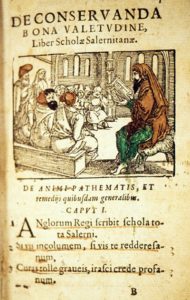
Gli alambicchi più antichi risalgono al II sec. a.C., trovati in Mesopotamia ed Egitto. In antichità erano usati solo per produrre essenze per preparare balsami profumati o per usi medici. La distillazione dell'alcol, per produrre soluzioni idroalcoliche, è iniziata probabilmente con gli alchimisti arabi Rhases e Avicenna (Ibn Sīnā) fra i secoli X e XI. Queste conoscenze furono raccolte e diffuse in Occidente soprattutto dalla Scuola Salernitana, dal X secolo in poi.
Nel XIII secolo il filosofo e vescovo tedesco Alberto Magno parla nei suoi scritti di “aqua ardens” ottenuta dalla distillazione del vino, così leggera da galleggiare sull'olio. Aqua ardens, spirito ardente e spirito di vino sono tra i termini più usati per secoli per indicare l’alcol o una soluzione idroalcolica più o meno concentrata. Spirito deriva dal latino “spiritus” che significa soffio, respiro, spirito vitale e, per estensione, esalazione. Il termine alcol verrà più tardi. Il distillato da bere era indicato in questo periodo col termine generico di acquavite, qualunque fosse la materia di partenza. 
Il primo testo che descrive dettagliatamente come produrre acquavite da vino con un sistema a doppia fermentazione è del 1276 (nel codice vaticano Consilia). Si deve al medico fiorentino Taddeo Alderotti, uno dei più famosi del suo tempo, citato anche nel Paradiso di Dante (12:82-85). Inizialmente era effettuata solo nei monasteri ma, da lì a un secolo, la produzione di acquavite divenne sempre più popolare. Fu diffusa soprattutto grazie al trattato del medico padovano Giovanni Michele Savonarola (1385-1468), il “De conficienda Aqua Vitae”, che spiegava come prepararla (questo Savonarola è il nonno del più celebre frate domenicano Girolamo Savonarola).
Quindi dalla pratica empirica della distillazione, sempre più perfezionata, nacque l'identificazione della sostanza che caratterizza il vino dal mosto. Sulla base di queste conoscenze, nel Seicento, troviamo i primi tentativi di interpretazione della fermentazione.
Il Seicento è un'epoca che rappresenta uno spartiacque nella storia dell'umanità e della scienza, grazie alla nascita del metodo sperimentale. Questo permetterà di superare nel tempo il principio d'autorità e di distaccarsi via via dagli aspetti mistici e magici dell'alchimia.
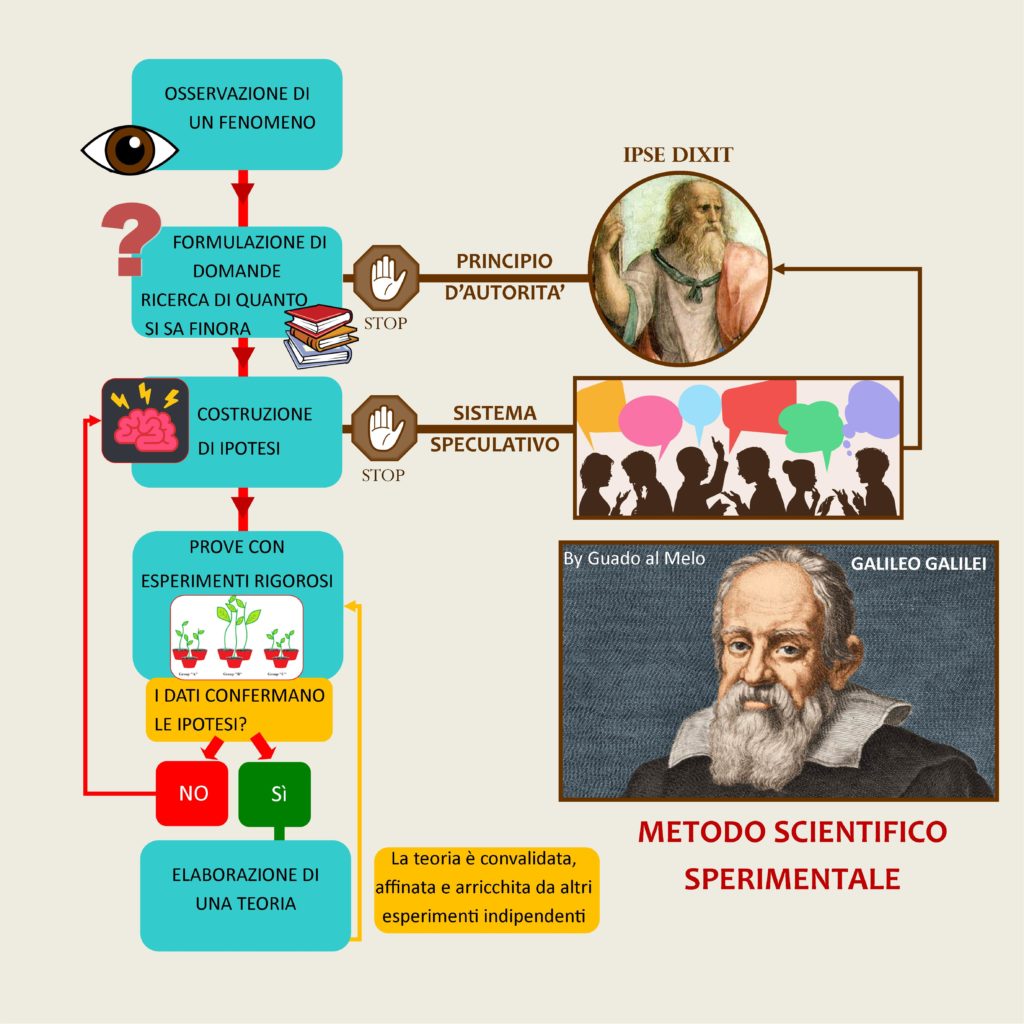
Naturalmente non si è trattato di un taglio netto. Per ancora qualche secolo si rimase in un mondo di mezzo, in bilico fra razionalità e pensiero magico, con diverse figure di scienziati già lanciate avanti e molti ancora legati al passato. Anche gli scienziati ricordati oggi per importanti scoperte e contributi portavano ancora in sé (chi più, chi meno) aspetti magici o irrazionali.

Tornando al nostro tema, alla fine del Cinquecento il grande medico e chimico vicentino Angelo Sala (1576 - 1637) fece i primi studi sulla formazione di alcol dai mosti in fermentazione.

Poco più tardi il medico e filosofo fiammingo Johannes Baptiste van Helmont (1580-1644), discepolo (e critico) di Paracelso, ammiratore del nuovo metodo sperimentale, fu fra i primi ad ipotizzare che la fermentazione fosse un processo di natura chimica, mediato da non ben precisati intermediari. Per van Helmont (e altri del suo tempo) la realtà è costituita da “minima naturalia”, elementi piccolissimi, corpuscoli alla base di tutta la materia. Le reazioni chimiche, che chiama tutte abbastanza indistintamente “fermentazioni “ o “effervescenze”, sono addizioni o sottrazioni di queste particelle. Alla base delle reazioni c'è un principio spirituale che attua attraverso dei “fermenti”, dei mediatori non identificati.
Oltre a questo, van Helmont riconobbe che il gas che si libera nella fermentazione è lo stesso che si ottiene bruciando del carbone, chiamato all'epoca gas silvestre (perché derivante dalla combustione di materia vegetale). Oggi lo chiamiamo anidride carbonica.
Un altro esponente di questo mondo in bilico fra scienza nascente ed alchimia è Nicolas Lémery (1645-1715), studioso francese che, nella seconda metà del Seicento, considerava cinque sostanze alla base delle cose naturali: Acqua, Spirito, Olio, Sale e Terra. La sua opera “Corso di chimica” (1687) ebbe una grande fortuna e fu considerata a lungo un testo di riferimento. In esso troviamo una spiegazione dettagliata del processo della fermentazione alcolica:

“Bisogna sapere che il mosto contiene molto di questo Sale essenziale: questo Sale come volatile facendo forza nella fermentazione per distaccarli dalle parti oleose, dalle quali era quasi legato, le penetra, le divide, le squarcia, finché con li suoi punti sottili e taglienti, l'abbia rarefatte in Spirito. Questa forza causa l'ebollizione che accade al Vino, e nel medesimo tempo la sua purificazione, perché ne fa separar e squarciare le parti più grosse in forma di spuma, una parte della quale s'attacca e si pietrifica ai lati della Botte, e l'altra si precipita sul fondo: questo è quel che si chiama il Tartaro e la flece. ..."
Secondo Lémey quindi la vinificazione consiste nella trasformazione di una parte del mosto (Oglio) in alcol (Spirito), grazie ad un'azione di “rarefazione” da parte dei Sali Acidi. Per Oglio intende la parte che rimane non distillabile, mentre lo Spirito è la parte che può essere distillata ed infiammabile. Per Sali intende sia quelli che rimangono incrostati sulle pareti delle botti (l'acido tartarico) che quelli che precipitano sul fondo al termine della vinificazione.
“Sono ancora i medesimi Sali che essendo un poco districati da i loro inviluppi, mutano la dolcezza fiacca del Mosto in un aggradevole pungimento, tal quale sentiamo ne Vini di Francia.”

Lémery, pur col suo linguaggio per noi un po' oscuro, inizia ad identificare diversi elementi presenti nel mosto e nel vino, pur attribuendo loro ruoli nella fermentazione non proprio esatti. Questa sua spiegazione tuttavia rimarrà a lungo come riferimento. Infatti la ritrovimo più o meno tale e quale nel "Dizionario di Chimica" di Pierre Joseph Macquer del 1766. Troviamo scritto sotto la parola Vino (dall'edizione tradotta in italiano da Giovanni Antonio Scopoli del 1778): "Finalmente, se venga sottoposto alla distillazione, …, si ottiene un liquor volatile, spiritoso, ed infiammabile, che si chiama spirito di vino o spirito ardente. Questo spirito è quindi un nuovo ente prodotto dalla descritta fermentazione.”
Si coglie però anche il passo avanti fatto dai chimici del primo Settecento, i quali ragionano anche su quale sia la sostanza trasformata in alcol. Infatti scrisse:
“Se vengano esaminate le qualità del vino , che ha sofferto il primo movimento della fermentazione ora descritta, si troverà, che distinguesi essenzialmente dal sugo dell’uva non fermentata. Non ha più lo stesso sapore dolce, ma un altro, che sebbene gustoso, è però molto diverso per avere qualche cosa di spiritoso o di piccante. In vece di produrre un effetto lassativo, come il mosto, il vino per lo contrario dà alla testa, quando è preso per una certa dose, e cagiona, come ognuno sa, ubbriachezza."
Egli annota che la fermentazione avviene più facilmente e si produce più sostanza spiritosa più l’uva è matura. L’uva acerba e quella matura cambiano nel sapore: l’una è più acida e per niente dolce, l’altra è molto zuccherina.
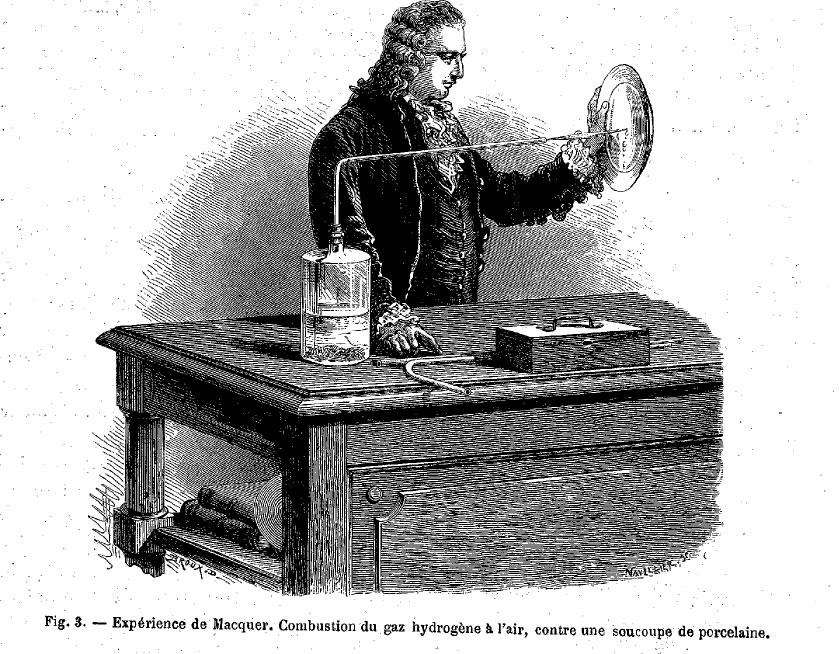
“Da ciò si può facilmente concludere che nella maturazione dell’uva e degli altri frutti tutta l’operazione incognita della natura consiste nel produrre in queste materie un nuovo essere, un nuovo misto, cioè la materia zuccherosa. Questa materia involge così bene l’acido, o diviene nei frutti così atti a far vino come le uve dominante …, essendo certo che il principio zuccheroso è la vera materia della fermentazione spiritosa.”
Macquer fa seguire una lunga e precisa riflessione, alla luce di questa idea, sulle pratiche tradizionali di certe zone geografiche di aumentare lo zucchero nelle uve concentrandole per appassimento. Cita anche la pratica di aggiungere zucchero direttamente al mosto. Inoltre segnala che già ad inizio secolo il medico olandese Herman Boerhaave (1668-1738) indicava come “lo zucchero ordinario sia un mezzo efficace a promuovere la fermentazione”. La pratica dello zuccheraggio fu poi diffusa fra i produttori di vino francesi nei primi decenni dell'Ottocento, grazie soprattutto al chimico Jean-Antoine Chaptal (a cui è rimasta legata nel nome francese: chaptalisation).
“Ma con quale mezzo compie la natura un tale cambiamento? … Tutto ciò è un arcano della natura a noi ignoto, né così facile da scoprire”.
Il primo a descrivere in modo chiaro cosa succede durante la fermentazione fu Antoine-Laurent de Lavoiser (1743-1794) nel suo "Trattato elementare di chimica" del 1789. Lavoisier è una di quelle figure che hanno cambiato la storia. E' riconosciuto come il “padre della chimica moderna" che, grazie a lui, si distaccò completamente dall'alchimia.

Con lui si inizia a parlare di alcol e non più di spirito di vino. Infatti riteneva questo termine poco adeguato perché questa sostanza poteva formarsi non solo dal vino, ma anche dal sidro o dallo zucchero.

Scrisse: “Siamo stati quindi forzati ad adottare un nome più generale, e questo è quello di alkool derivato dagli arabi, ci parve il più confacente al nostro oggetto”.
La parola alcol deriva dall’arabo al-ko-ol. In origine si riferiva alla polvere finissima e nera che le donne usavano per truccarsi gli occhi. Da qui, nell’alchimia araba, venne usato per indicare un qualsiasi composto in polvere sottilissima e così passò anche nel Medioevo Occidentale. Venne poi utilizzato per indicare l’essenza più pura di una sostanza. Sembra che il primo ad usare il termine alcol nel senso moderno fu Paracelso (Theopharst Bombast von Hohenheim, 1493-1541) fra i più noti medici alchimisti della sua epoca. Lo introdusse però nell'uso comune scientifico Lavoisier. Infatti egli viene ricordato anche per la sua importante riforma della nomenclatura della sostanze chimiche, alla base di quella moderna. Volle passare dai termini oscuri e vaghi di origine alchemica ad altri più concisi e razionali.
Tornando alla fermentazione, Lavoiser, sulla base delle conoscenze fino ad allora accumulate, la descrisse approssimativamente come:
mosto d’uva = acido carbonico (anidride carbonica) + alcol 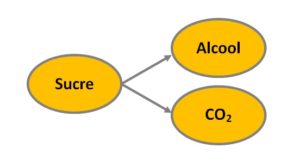
Riprodusse quindi sperimentalmente il processo con zucchero sciolto in acqua tiepida, per poi stimare in modo molto preciso le quantità di sostanze fermentate e dei prodotti ottenuti, determinandone anche la composizione. Fu il primo a scrivere una reazione chimica come una equazione. Scrisse: “in questi esperimenti, noi possiamo assumere che esiste un reale equilibrio o equazione tra gli elementi da cui si parte e quelli ottenuti alla fine della reazione”. Le misure non erano proprio precisissime (dati anche i limiti degli strumenti dell'epoca) ma fu una vera e propria rivoluzione per la chimica.
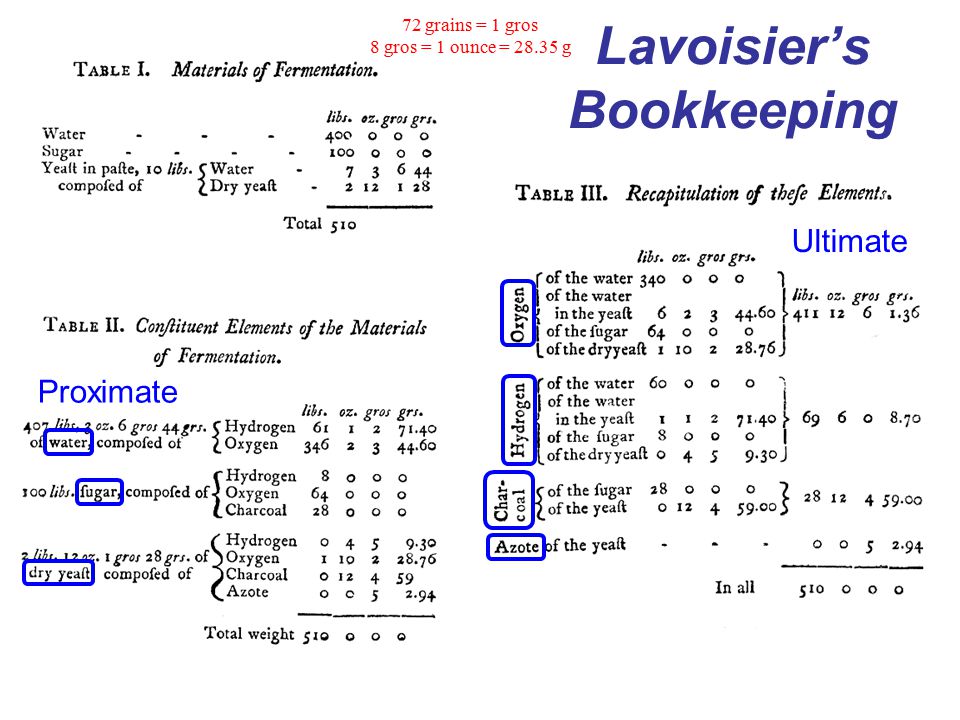
Egli descrisse come lo zucchero si sdoppiasse in due parti, e che la fermentazione consistesse nell'ossigenazione di una di esse a spese dell'altra con formazione di una sostanza combustibile, l'alcol. Dimostrò che la trasformazione non era quantitativamente esatta perché si formano anche altri prodotti secondari.
La formula della reazione fu poi definita in modo quantitativamente più preciso nel 1810 dal chimico francese Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), grazie al perfezionamento ulteriore degli strumenti di misura.
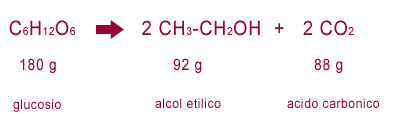
La strada era ormai aperta: da allora in poi i chimici affinarono sempre più le conoscenze sulla reazione, arrivando a definirla con estrema precisione. Oggi viene schematizzata nel modo seguente.
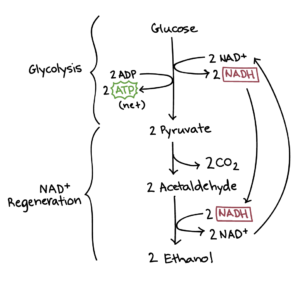

Per arrivare a questa formula tuttavia manca ancora un passaggio fondamentale: all'epoca di Lavoisier non esisteva ancora la chimica organica!
Infatti non si era ancora riusciti a rispondere a quella domanda fondamentale che ci siamo portati appresso in questo viaggio nei secoli: chi opera tutto questo e perché?
Questa domanda sorse spontanea anche a Vincenzo Dandolo, traduttore italiano (contemporaneo) delle opere di Lavoisier che, oltre a tradurre, fece anche numerose annotazioni al testo. Lavoisier infatti, nel descrivere i suoi esperimenti, racconta che allo zucchero aggiunge lievito di birra. Dandolo annota che quest'ultimo è “formato ordinariamente dal sedimento della birra stessa”. Dandolo si chiede “perché, come opera il lievito di birra? ... Dunque la teoria dell’autore sulla fermentazione dello zucchero non è ben determinata… Dunque il lievito diventa sostanza essenziale ed indispensabile per effettuare una completa fermentazione, tuttoché vi siano acqua, calore e zucchero".
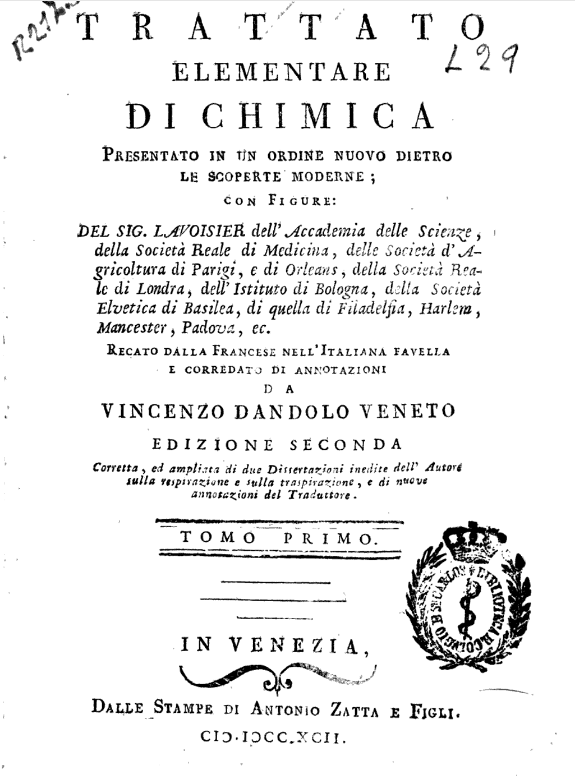 Di nuovo, non confondiamoci! Allora si sapeva già del lievito? No, si usava questo termine per indicare un qualcosa che empiricamente si era visto utile a facilitare la fermentazione. Già dalle epoche più antiche si era visto che aggiungendo dei sedimenti della fermentazione (o un po' di pasta di pane lievitata nel caso della panificazione) il processo partiva con maggior facilità. Tuttavia a fine Settecento, pur avendo definito di massima cosa succede, non si aveva ancora idea del perchè.
Di nuovo, non confondiamoci! Allora si sapeva già del lievito? No, si usava questo termine per indicare un qualcosa che empiricamente si era visto utile a facilitare la fermentazione. Già dalle epoche più antiche si era visto che aggiungendo dei sedimenti della fermentazione (o un po' di pasta di pane lievitata nel caso della panificazione) il processo partiva con maggior facilità. Tuttavia a fine Settecento, pur avendo definito di massima cosa succede, non si aveva ancora idea del perchè.
Si chiede ancora Dandolo: “Qual principio fermentante introduce questa sostanza, o qualunque altra atta a promuovere questa prima notabile alterazione…? Questo fenomeno sarebbe forse da riferirsi all’azoto che il lievito contiene? Se sì, come opera l’azoto? ”
Afferma che i lieviti usati tradizionalmente sono di due specie: 1. “corpi sommamente putrescibili contenenti azoto”, raccontando come alcuni agevolano la fermentazione buttando nel tino pezzi di carne. Inoltre racconta come i Cinesi, per stimolare la fermentazione di un decotto di avena e orzo, ci aggiungano escrementi. 2. “Corpi che contengono molto ossigeno come acidi, sali neutri, creta, ossidi metallici, ecc."
Al di là di questi anedotti e teorie, per molti all'epoca (come per lo stesso Dandolo) il lievito era un qualche composto chimico. Solo Pasteur, nella seconda metà dell'Ottocento, mise fine a questa lunghissima diatriba, identificandolo in un organismo vivente.
Tuttavia il lavoro di Pasteur non nacque dal nulla e fu un traguardo molto difficile e molto controverso.
Prossime fiere del vino
Ecco gli appuntamenti dove incontrarci con i nostri vini nei prossimi mesi.
ProWein, a Duesseldorf, 18-20 Marzo 2018. Halle 16 / C22. Presso il nostro importatore Consiglio Vini
Vinitaly, a Verona, 15-18 Aprile 2018. Padiglione 7 / Stand B5. Presso il nostro distributore per l'Italia Cuzziol GrandiVini
Mostra Mercato dei Vignaioli FIVI a Roma, 19-20 Maggio 2018. Teatro 10 Cinecittà. orario 11.00-19.00. Posizione ancora da stabilire https://www.fivi.it/mercato-roma-2018-fivi-cinecitta-va-scena-territorio/
La fermentazione nella storia 1: "Bolle per sua natura!"
 Dopo aver parlato di fermentazione in generale, soprattutto sul ruolo dei lieviti (qui e qui), vi invito in un piccolo viaggio nella storia, alla scoperta di cosa si pensava nel passato a proposito di questo cruciale passaggio e come si è arrivati a comprenderlo.
Dopo aver parlato di fermentazione in generale, soprattutto sul ruolo dei lieviti (qui e qui), vi invito in un piccolo viaggio nella storia, alla scoperta di cosa si pensava nel passato a proposito di questo cruciale passaggio e come si è arrivati a comprenderlo.
La fermentazione è utilizzata dall'uomo da almeno 10.000 anni nella sua alimentazione, dal vino alla birra, dal pane allo yogurt, al formaggio... Tuttavia per millenni l'umanità lo ha fatto in modo inconsapevole, senza sapere cosa succedesse e perché, a parte il risultato finale.
La parola è antica, deriva dal latino fermentum, dalla radice del verbo fervere che significa muoversi, bollire. Nasce dall'osservazione di quanto succede in modo chiaramente visibile durante il processo: il pane lievita, si gonfia e si espande, il vino (o la birra) bolle.
Ma cosa pensavano nel passato di questo fenomeno?
Se cerchiamo dei riferimenti nei testi agrari , dall'antichità all'Ottocento, non si parla o non ci si chiede granché sul perché e come succede. Piuttosto si trovano indicazioni di lavoro pratico, utili a favorire il processo. Questo è naturale: i testi agrari nel passato erano per lo più rivolti ai lavoratori delle campagne di un certo rango, in particolare ai fattori. Nelle epoche più antiche si ignora del tutto il problema (almeno, per quanto ci è dato sapere). Nei testi del Sette-Ottocento si liquida la faccenda con la frasetta: "(il mosto) bolle per sua natura". Quindi, succede e basta, non stiamo a chiederci il perchè! Queste domande erano lasciate più ai filosofi e poi agli scienziati, che però incontreremo più tardi.

Uno dei testi agrari più dettagliati dell'antichità è il De re rustica di Columella (65 d.C.), in italiano "Sull'agricoltura", che raccoglie la summa di tutte le conoscenze agricole romane (qui riassunte con quelle etrusche). E' un testo così ben fatto e preciso da essere considerato dagli esperti il primo vero e proprio trattato agronomico della storia. Fu così importante da rimanere come principale riferimento per l'agronomia fino al Settecento!
Lucio Giunio Moderato Columella è vissuto nel 1° secolo dopo Cristo, originario di Cadice (l'attuale Spagna). Dopo una prima carriera militare in Siria, si ritirò alla vita agraria nelle sue tenute nel centro Italia. Racconta di essere stato influenzato nel suo interesse per l'agricoltura dallo zio, Marco Columella, che egli descrive come uomo astuto e grande fattore. Quindi i suoi scritti non sono solo un'opera letteraria (come altri testi sull'agricoltura dell'epoca) ma derivano dell'esperienza diretta, oltre che da una mente curiosa e che appare già molto scientifica.

Columella ama molto la vita agricola che ritiene moralmente più sana di quella di città, come racconta nella sua opera. Secondo lui l'agricoltore deve gestire direttamente la proprio azienda e deve avere un'ottima preparazione sul suo lavoro, basato sullo studio di testi validi. Mostra una particolare sensibilità (rispetto ai suoi tempi) sull'uso di manodopera servile. Secondo lui gli schiavi che lavorano nei campi devono essere trattati con umanità e famigliarità, oltre che consultarli sui lavori agricoli.
Nelle parti dell'opera dedicati alla vinificazione (molto più ristrette dello spazio offerto alla parte dei lavori in vigna) , scopriamo che anche Columella sorvola elegantemente su quanto succede nell'intima oscurità del dolium in fermentazione (il dolium è il vaso in terracotta in cui facevano la vinificazione). Eppure dà molti consigli sensati (alla luce delle nostre conoscenze odierne) su come lavorare per far sì che il tutto vada a buon fine. In particolare insiste sulla necessità di assoluta pulizia della cantina e degli attrezzi di lavoro, soprattutto dei contenitori dove verrà messo il mosto e il vino. Oggi infatti sappiamo che l'igiene è il primo requisito fondamentale per produrre un buon vino, per evitare d'inquinarlo con certi microrganismi responsabili di tanti gravi problemi, dall'acetificazione ai cattivi odori alla torbidità, ecc.
Columella ricorda (come fa anche oggi ogni buon cantiniere) che la preparazione alla vendemmia deve iniziare almeno un mese prima, con l'accurata pulizia di ogni attrezzo. Ricorda anche che il torchio deve essere pulito per bene dopo ogni uso. “La cantina si mondi da ogni sterco, profumandola con buoni odori, così che non sia offesa da odore puzzolente o agro. …” (i testi sono tratti dall'edizione del 1564, tradotta dal latino da Pietro Lauro Modonese).

I dolia (vasi in terracotta in cui avveniva la vinificazione), interrati e no, devono essere puliti e preparati raschiando lo strato interno di pece dell'anno precedente, dopo averlo ammorbidito col calore, e poi accuratamente impeciati di nuovo.
I consigli che seguono riguardano soprattutto indicazioni di “condimenti” da aggiungere al vino (resina, acqua di mare, ecc.) per la conservazione del vino. Ricordiamo che comunque i vini dell'antichità erano ben diversi da quelli odierni. I problemi di vinificazione facevano sì che presentassero gusti che oggi consideriamo difetti. L'uso comune di servirli miscelati con acqua, aromi, spezie, miele e tanto altro serviva appunto a coprire e correggere questi problemi inevitabili.
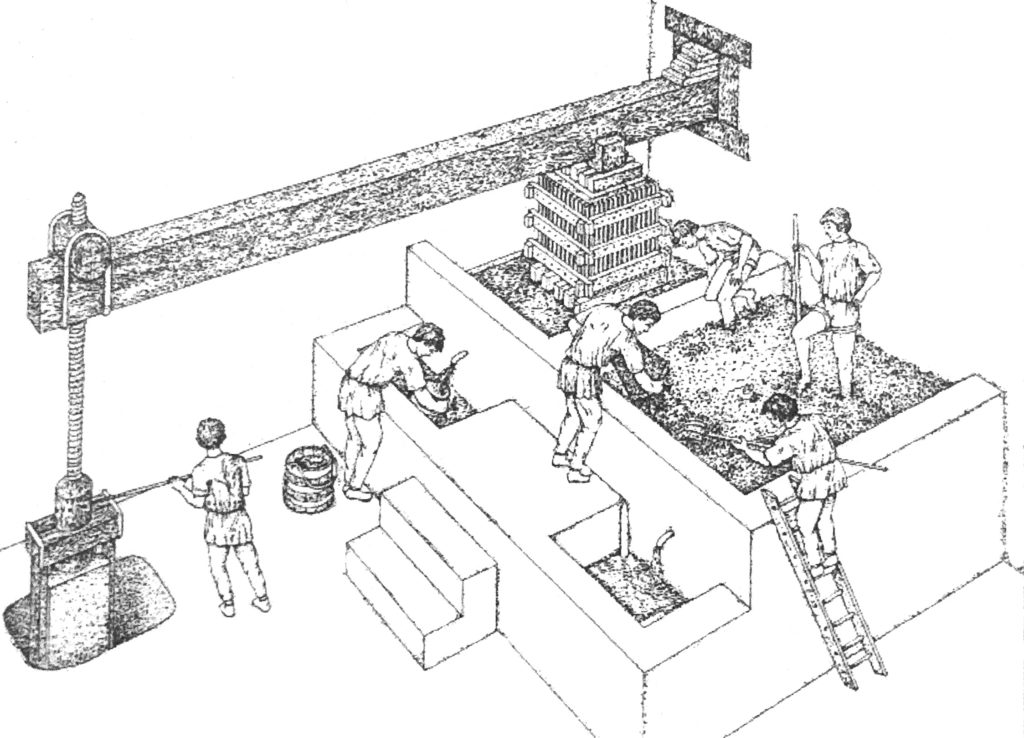



Sappiamo da fonti più letterali che nel periodo antico era cosa comune attirare la buona sorte sulla vendemmia con riti augurali. In particolare venivano celebrati i Vinalia Rustica, il 19 agosto, riti di buon auspicio per la prossima vendemmia (molto simili alle benedizioni delle vigne e dei campi che i nostri preti facevano fino a non molto tempo fa). Cicerone, nel "De Devinatione" cita le "auguratio vineta", pratiche augurali che fa risalire all'augure Atto Navio dell'epoca di Tarquinio Prisco.

Non possiamo fare a meno d'immaginare che anche la delicata fase della fermentazione avesse la sua parte di rituali. Eppure Columella non si spreca molto in questo senso, accennando solo rapidamente al sacrificio dovuto a Libero e a Libera, ai quali vanno consacrati i vasi della vendemmia. Per lui, che da come scrive sembra un agronomo curioso e molto razionale, è più importante che “non ci si scosti mentre che dura la vendemmia dal torcolo o dalla cantina, in modo che si faccia il mosto netto e puro...”.

Se passiamo al Medioevo la situazione non cambia molto. Come già nel tardo impero, non abbiamo più i vasi in terracotta ma nelle cantine predomina il legno. Tuttavia il modo di fare il vino è praticamente lo stesso, a volte anche con tecniche più scadenti, soprattutto nell'Alto Medioevo.
I grandi testi di agronomia medioevale sono soprattutto quelli della cultura araba. Fra l'VIII e il XIV secolo vi è una grande attenzione all'agricoltura: contiamo circa una cinquantina di opere dedicate a questo ambito. Queste opere fioriscono un po' in tutte le terre allora sotto l'influenza araba, in particolare al-Andalus, l'attuale Andalusia, che in quel periodo vive un periodo d'oro. Per la cultura araba dell'epoca l'agricoltura è una professione che richiede un sapere specifico. In alcuni testi andalusi si parla dell'agricoltura come un mestiere (san' a), ma anche come una scienza ('ilm) ed un'arte (fann). Nell'opera di al-Tignārī ("Libro dello splendore del giardino e del diletto della mente") vi è scritto: "chiunque ne abbia l'attitudine ha il dovere di dedicarsi all'apprendimento della scienza di cui ha bisogno per esercitare il proprio mestiere. Coloro che sono privi di tale attitudine, devono invece ricorrere al consiglio dei sapienti per tutto ciò che riguarda le loro colture o i prodotti di altri mestieri" . Sembra scritto per i nostri giorni!

Purtroppo questi testi non ci parlano di vino, in quanto siamo già in epoca musulmana. Dedicano però ampie parti alla coltivazione dell'uva, soprattutto per il consumo fresco o essiccato. Le fonti a cui attingono sono diverse a seconda delle opere: alcune traggono ispirazione da testi romani classici (Plinio e Columella soprattutto), altri dai bizantini oppure della Mesopotamia. Tuttavia sappiamo, da fonti storiche e letterarie, che la produzione dei territori viticoli era continuata anche dopo il passaggio sotto il dominio arabo. Per lo più (ed ufficialmente) era svolta da comunità di altre religioni e una piccola parte per soli fini farmaceutici. In realtà vi era anche una produzione di persone di religione musulmana. L'importante era che non fosse ostentata. Le tecniche di vinificazione ci sono arrivate comunque (più o meno) per altre vie, ma senza troppi particolari che ci diano indizi sul nostro tema di fondo, la fermentazione. Su questo capitolo molto interessante, torneremo a parlare in un prossimo post.
Tornando in Occidente, l'unico testo agrario di una certa rilevanza è il "Ruralium Commodorum Libri XII" del bolognese Pietro De Crescenzi (1305), basato per molte parti sugli scritti latini, Columella in testa. Anche De Crescenzi descrive molto bene le fasi precedenti la vinificazione, come la decisione dell'epoca della vendemmia e l'importanza della pulizia della cantina, e poi di quelle successive (la conservazione). Non accenna alla fermentazione in sé, se non per spiegare come cercare di togliere i difetti dovuti ad alterazioni.

In generale abbonda di consigli empirici, a volte sensati per noi (qualche volta no). Nelle fasi più difficili, come le alterazioni del vino, che sembrano andare oltre la possibile comprensione umana dell'epoca giungendo terribili come eventi fatali ineluttabili, risvegliano in lui echi che sconfinano più nell'aspetto magico e superstizioso. Queste parti ci serviranno come appiglio per affrontare il capitolo delle superstizioni legate alla vinificazione, che erano sicuramente già presenti nel mondo agrario romano e rimarranno per secoli fino quasi ai nostri giorni. Non è che il Medioevo sia stato un periodo più buio, per molti versi, di tanti altri!
Ma perché il vino si altera? Così l'autore lo spiega, in modo un po' oscuro:” Avviene al vino per l'acquosità sua corruttibile nella vite e o nel vaso, che egli si corrompi e si guasti per varie cagioni adoperate in esso per lo strano caldo. Se si cavasse un poco di feccia o di vino che avesse la feccia, si metta nel vaso senza aprirlo, si convertirebbe in muffa. La quale infetta il vino. Oltre a ciò ogni altro vino che vi si ponga si guasta. E se di questo vino se ne mette in un doglio buono e si mischia con altro vino, lo infetta e lo converte nella sua corrotta natura.” Noi sappiamo che le alterazioni vengono dai microrganismi presenti nel vaso vinario, per ossidazioni o, sulle fecce, anche per fenomeni riduttivi. L'autore, ovviamente senza sapere perché , intuisce che è qualcosa che succede all'interno, non viene da fuori, e che la permanenza sulla fecce ha un suo ruolo. Sono importanti anche le sue considerazioni sul fatto di non infettare un buon vino con uno andato a male.

Ancora: “Inoltre, il vin saldo e potente e massimamente dolce e grosso, messo in tempo caldo in vaso non pieno e non chiuso di sopra, svapora il caldo e lo umido del vino, e resta il freddo e il secco che si converte in acetosità”. Lo spunto acetico, che sappiamo derivare soprattutto dall'azione dei batteri acetici, per l'autore è un fenomeno fisico (e vago). Tuttavia intuisce correttamente la pericolosità d'incorrere in tale inconveniente se si lascia un contenitore scolmo e aperto (causando il contatto con l'ossigeno, che sappiamo agevolare lo sviluppo dei batteri acetici), suggerendo le modalità di lavoro migliori.
“Il vino dà la volta (il girato? E' un'alterazione batterica del vino molto frequente nel passato) e si corrompe più facilmente al tramontare delle Pleiadi, nel solstizio d'estate, nel caldo del Cane, quando c'è troppo caldo o troppo gelo, durante le grandi piogge, nei troppi venti, per i terremoti, per i tuoni, quando fioriscono le rose o le vigne”. Praticamente l'alterazione del vino può avvenire ad ogni evento particolare che “turbi” in qualche modo la vinificazione. Alcuni aspetti fra quelli elencati sono sicuramente veri: i cambiamenti repentini di temperatura possono influenzare quanto succede nelle botti. Un po' meno altri eventi.
Questa credenza riguardo al fatto che certi eventi possano turbare la vinificazione si trovano in numerose culture contadine del passato, in diverse parti del mondo (sia per il vino che per la birra). La fantasia popolare ha contribuito alla nascita di una ricca ed ampia casistica, mescolando intuizioni di fatti reali (meglio evitare gli sbalzi di temperature) a fantasie più o meno colorite.  Alla base c'è l'idea che sta avvenendo qualcosa (si vede, si sente!) ma è incomprensibile. L'istinto porta alla reverenza: forse, se non succede nulla di disturbante, tutto può andare bene... Cosa succede, chi agisce? Spiriti, demoni, entità magiche? Qualcosa sta lavorando, non bisogna far rumore, si deve camminare piano, si deve bisbigliare, non bisogna bussare sui tini o sulle botti, non devono esserci rumori forti, correnti d'aria per porte o finestre aperte, ... Ogni territorio ha le sue storie a proposito. La superstizione genera anche avvertimenti terribili per evitare che qualcuno abbia comportamenti inappropriati: se si bussa su un tino o una botte, rendendo così il vino cattivo, il malcapitato rischia di perdere il dito o la mano. Si credeva anche che la cantina dovesse essere tenuta ben chiusa per evitare che spiriti malefici o streghe o gatti neri potessero influenzare negativamente il processo. Tante altre situazioni potevano portare male, come le donne con le mestruazioni, che non dovevano avvicinarsi ai tini. Secondo alcune culture contadine l'andamento della vinificazione diventava anche un segno premonitore dei destini della famiglia. Se andava poco bene erano in arrivo dispiaceri, se c'erano alterazioni gravi si potevano avere anche disgrazie.
Alla base c'è l'idea che sta avvenendo qualcosa (si vede, si sente!) ma è incomprensibile. L'istinto porta alla reverenza: forse, se non succede nulla di disturbante, tutto può andare bene... Cosa succede, chi agisce? Spiriti, demoni, entità magiche? Qualcosa sta lavorando, non bisogna far rumore, si deve camminare piano, si deve bisbigliare, non bisogna bussare sui tini o sulle botti, non devono esserci rumori forti, correnti d'aria per porte o finestre aperte, ... Ogni territorio ha le sue storie a proposito. La superstizione genera anche avvertimenti terribili per evitare che qualcuno abbia comportamenti inappropriati: se si bussa su un tino o una botte, rendendo così il vino cattivo, il malcapitato rischia di perdere il dito o la mano. Si credeva anche che la cantina dovesse essere tenuta ben chiusa per evitare che spiriti malefici o streghe o gatti neri potessero influenzare negativamente il processo. Tante altre situazioni potevano portare male, come le donne con le mestruazioni, che non dovevano avvicinarsi ai tini. Secondo alcune culture contadine l'andamento della vinificazione diventava anche un segno premonitore dei destini della famiglia. Se andava poco bene erano in arrivo dispiaceri, se c'erano alterazioni gravi si potevano avere anche disgrazie.
Ritornando però a de Crescenzi, quali sono i rimedi per le alterazioni del vino? Qui c'è un elenco molto lungo. Alcune pratiche descritte per prevenire i problemi (o risolverli in fasi iniziali) sono adeguate, come le sfecciature o il tenere i vasi ben colmi e chiusi. Quando il danno è fatto (e anche oggi è pressoché impossibile rimediare) l'autore elenca invece interventi un po' più fantasiosi, come intrugli di vario genere da aggiungere al vino, basati su erbe o altro. Di certo questi non cambiavano il destino del vino, come suggerisce l'autore ma, forse, erano più utili per coprire cattivi odori o sapori (nell'epoca medievale, come in quella antica, era d'uso comune la correzione dei vini con spezie, erbe o miele o altro). Si suggerisce anche l'uso di piante dalle virtù magiche, come la vitalba che, se messe alla base o sopra la botte, dovrebbero impedire al vino di alterarsi. Il più curioso è una sorta di rito propiziatorio legato alla sfera religiosa: si deve mettere nel vaso vinario una mela con all'interno un foglietto arrotolato con questa scritta: “GVSTATE ET VIDETE QVONIAM CHRISTVS SVAVIS EST DOMINVS”.
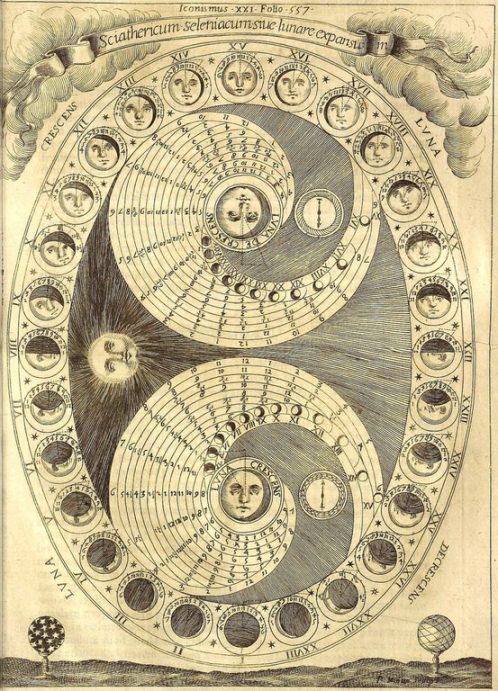
Delle credenze citate da De Crescenzo, la più diffusa, la più affascinante e fra le più dure a morire, è quella che lega il vino alle fasi lunari. Infatti, secondo l'autore, la vendemmia deve essere fatta in fase di luna calante, mentre i travasi con luna crescente, altrimenti il vino si fa aceto. Ad esempio, ben 500 anni dopo ritroviamo le stesse credenze, come denuncia nel suo “Trattato completo di agricoltura” (1855) Gaetano Cantoni : "Secondo alcuni la luna avrebbe pure influenza sulla fermentazione dei concimi, e per conseguenza i letamaj dovrebbero piuttosto essere voltati negli ultimi giorni della luna, perché in quest’epoca si disperderebbe minor quantità di principj utili, e resterebbe ordinati per la fermentazione, favorita dai primi quarti della luna successiva. La stessa cosa accadrebbe ella fermentazione vinosa, sul qual proposito corre il proverbio che il vino fatto in due lune a stento o mai si rischiara". Questo pensiero è rimasto fino quasi ai nostri giorni nella cultura contadina (e non solo).

Queste credenze derivano dal pensiero magico che gli antropologi hanno chiamato “magia simpatica”. Uno dei suoi principi più importanti è quello della similitudine. Si basa su una banale associazione mentale per cui il simile chiama il simile oppure dove qualcosa che simboleggia una data azione ha influenza su di essa. In questa concezione la luna che cresce si lega a tutte quelle azioni o situazioni in cui c'è qualcosa che cresce o deve svilupparsi o muoversi. Invece la luna calante assume un legame con tutto quello che cala, che deve arrestarsi o morire. Quindi tutte le fasi di raccolta agricola che comportano il taglio, la morte della pianta o lo schiacciamento (come per l'uva), devono essere fatte in luna calante. Invece un'azione come il travaso, di movimento, va fatto in luna crescente.
Non c'è comunque necessità di andare troppo lontano nel tempo, queste credenze sono ancora vive oggi. Il pensiero magico è subdolo e potente. A volte non si riesce ad evitare neppure tramite la cultura o secoli di ricerche e scoperte scientifiche. La domanda che sorge spontanea è: come mai queste credenze sono sopravvissute così a lungo?
Dobbiamo pensare, come descritto nel testo medievale, che nella produzione di vino i rituali magici-scaramantici non vengono mai fatti da soli. Sono accompagnati sempre da buone pratiche empiriche che possono portare comunque ad esiti positivi. Qui però l'umanità si divide in due strade. Le persone più dotate di una mente razionale tendono a pensare che sia stato il buon lavoro a portare a buoni risultati e si concentrano su quello. Da questa impostazione mentale nei secoli è nata la scienza. Altre persone invece sono portate a focalizzare la loro attenzione più sul fatto che la magia abbia funzionato. Un altro pensiero ricorrente è quello che ci fa dire "Tanto male non fa"! E così queste credenze si perpetuano nei secoli.
 E con le nostre conoscenze degli ultimi secoli? Sembra assurdo ma per alcuni può essere più facile comprendere e dare un senso alle semplici correlazioni mentali richieste della similitudine magica piuttosto che capire i concetti chimici o fisici alla base di certe buone pratiche di lavoro. E poi, la considerazione più importante di tutte: queste storie ci piacciono!
E con le nostre conoscenze degli ultimi secoli? Sembra assurdo ma per alcuni può essere più facile comprendere e dare un senso alle semplici correlazioni mentali richieste della similitudine magica piuttosto che capire i concetti chimici o fisici alla base di certe buone pratiche di lavoro. E poi, la considerazione più importante di tutte: queste storie ci piacciono!
Sono belle, poetiche, usano immagini e parole evocative, sono favole affascinanti e seducenti. Anche per questo nei secoli hanno conquistato e continuano tutt'oggi, diventando anche potenti armi del marketing moderno.
Finita questa digressione nelle superstizioni che circondavano la vinificazione, arriviamo all'era degli alchimisti. Scopriamo così che qui iniziano a comparire le prime vere e proprie interpretazioni della fermentazione.
La nostra nuova brochure
Ecco il progetto che ho realizzato per la nostra nuova brochure "più estesa".
Le prime pagine riguardano noi, le persone di Guado al Melo


Ecco invece la presentazione del territorio

Presento poi Guado al Melo in generale, dove si trova, le vigne, ecc.

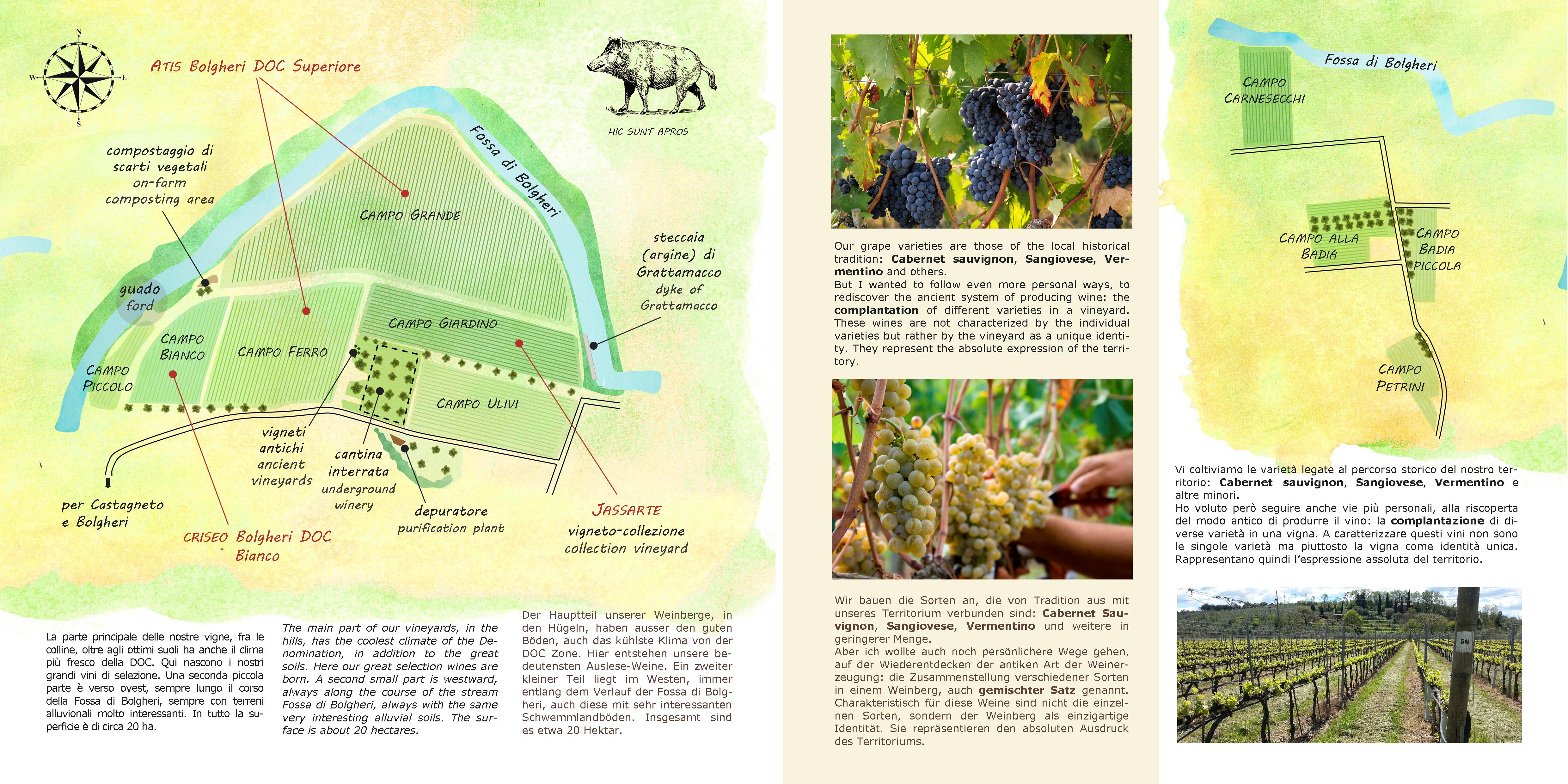
Ecco la parte che racconta il nostro modo di lavorare in vigna


Ecco la cantina di bio-architettura, col nostro progetto culturale sul vino


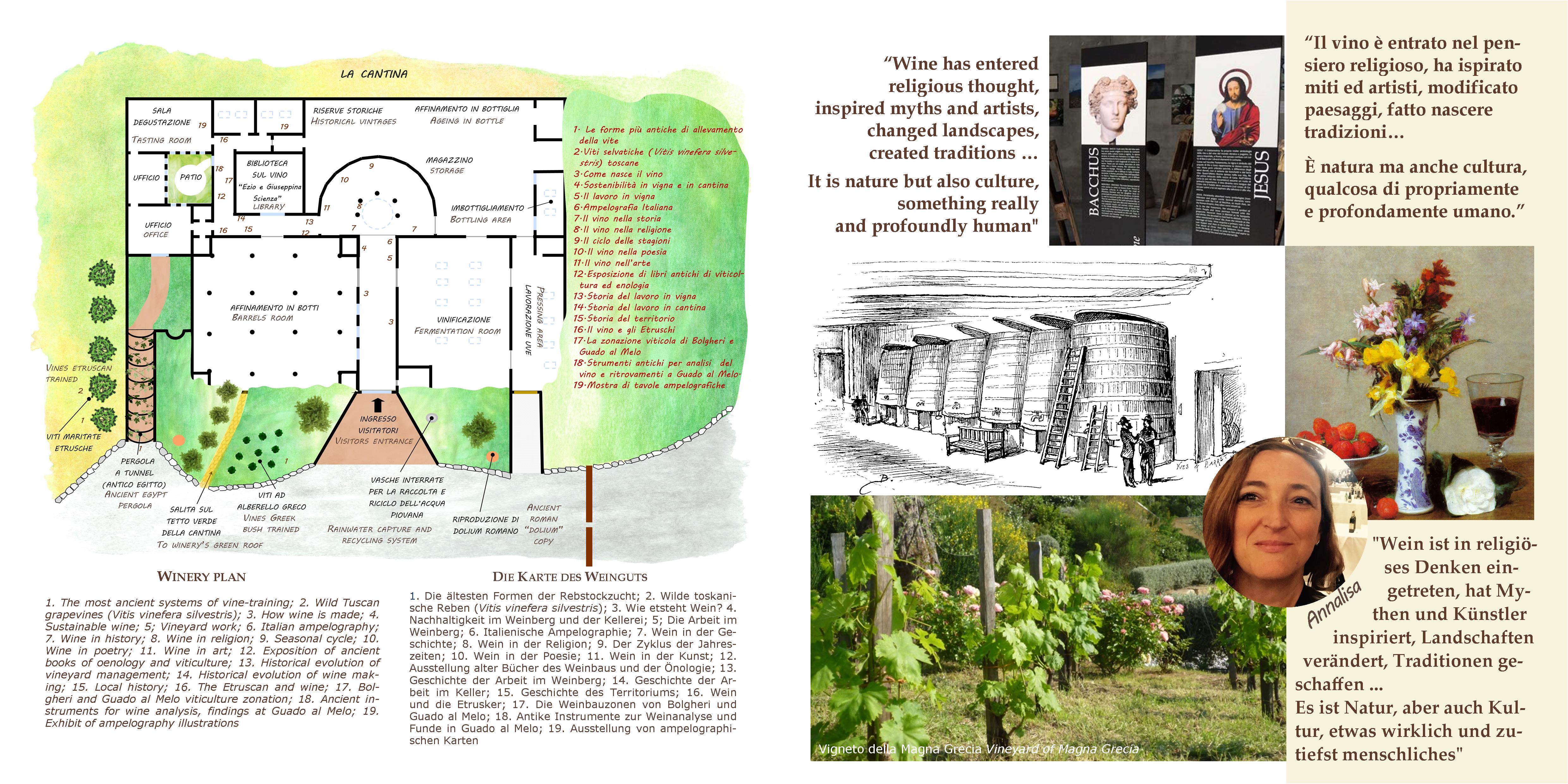
Entrati in cantina, presentiamo qui il nostro modo di lavorare nella vinificazione


Infine, ci sono le schede dei vini


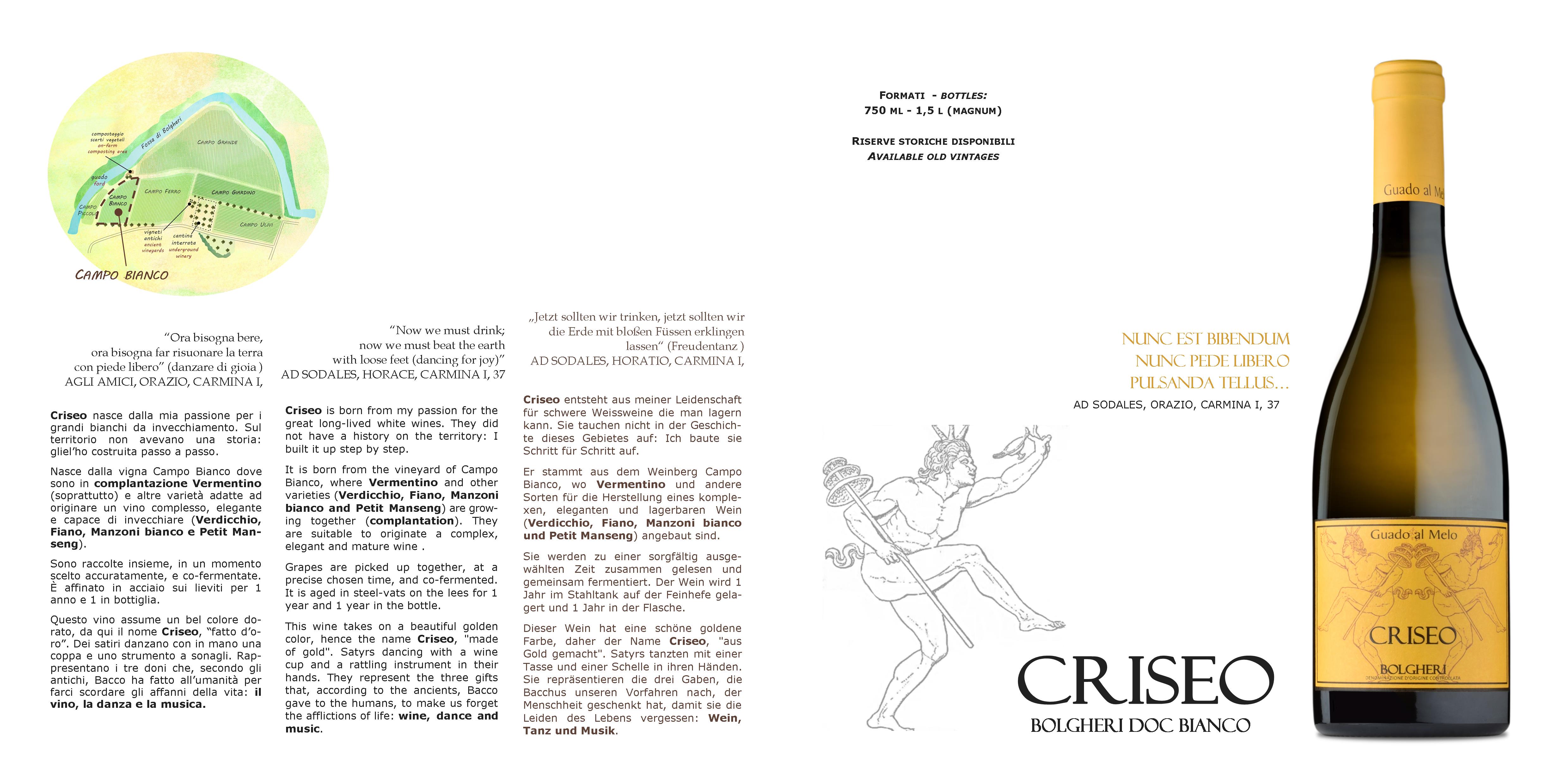



Focus sui lieviti (un argomento da "prendere con le pinze") 2
(continua)
Da dove arriva allora il Saccharomyces?
Le ricerche hanno dimostrato come l’habitat migliore del S. sia la cantina e non la vigna. Si insedia con contaminazioni delle quali è difficile individuare l’origine (può succedere che venga dall’ambiente esterno, da attrezzi, in molti casi da lieviti portati in cantina, ecc.). In una vecchia cantina, dove si fanno vinificazioni ormai da anni, ne diventa un abitante discreto ma ben insediato. Viceversa si sa che nelle cantine nuovissime le fermentazioni stentano sempre un po’.
Cosa succede allora nel corso di una fermentazione spontanea?

Quando ammostiamo l’uva, trasferiamo nel mosto tutti i nostri piccoli ospiti viaggianti. Il trattamento non piace però a tutti, molti soccombono. Rimangono quelli adatti a sopravvivere in queste nuove e difficili condizioni: alta concentrazione zuccherina e (quasi) assenza di ossigeno. Il Saccharomyces è in scarsa rappresentanza e per ora se ne sta abbastanza buono. La fermentazione parte con i non-saccharomyces che si alternano anche rapidamente nella volata. È una sorta di gara per la sopravvivenza: tutti vogliono quel "dannato" zucchero (e altri composti) ma vince e si alterna al comando chi riesce a prevalere in quel momento numericamente, o perché parte in vantaggio o perché è favorito da diverse condizioni chimico-fisiche che via via si succedono (temperatura, pH, acidità, etanolo crescente, ecc.). Intanto il Saccharomyces prende sempre più slancio e, siccome è un po’ più forte, vince gli altri sulla resistenza all’alcool (e ad altro), diventando sempre più la specie dominante. Si è appurato che, dove il Saccharomyces non ce la fa a prevalere sul finale (per diversi motivi), le fermentazioni procedono con difficoltà e si hanno spesso esiti sfavorevoli sulla qualità del vino.
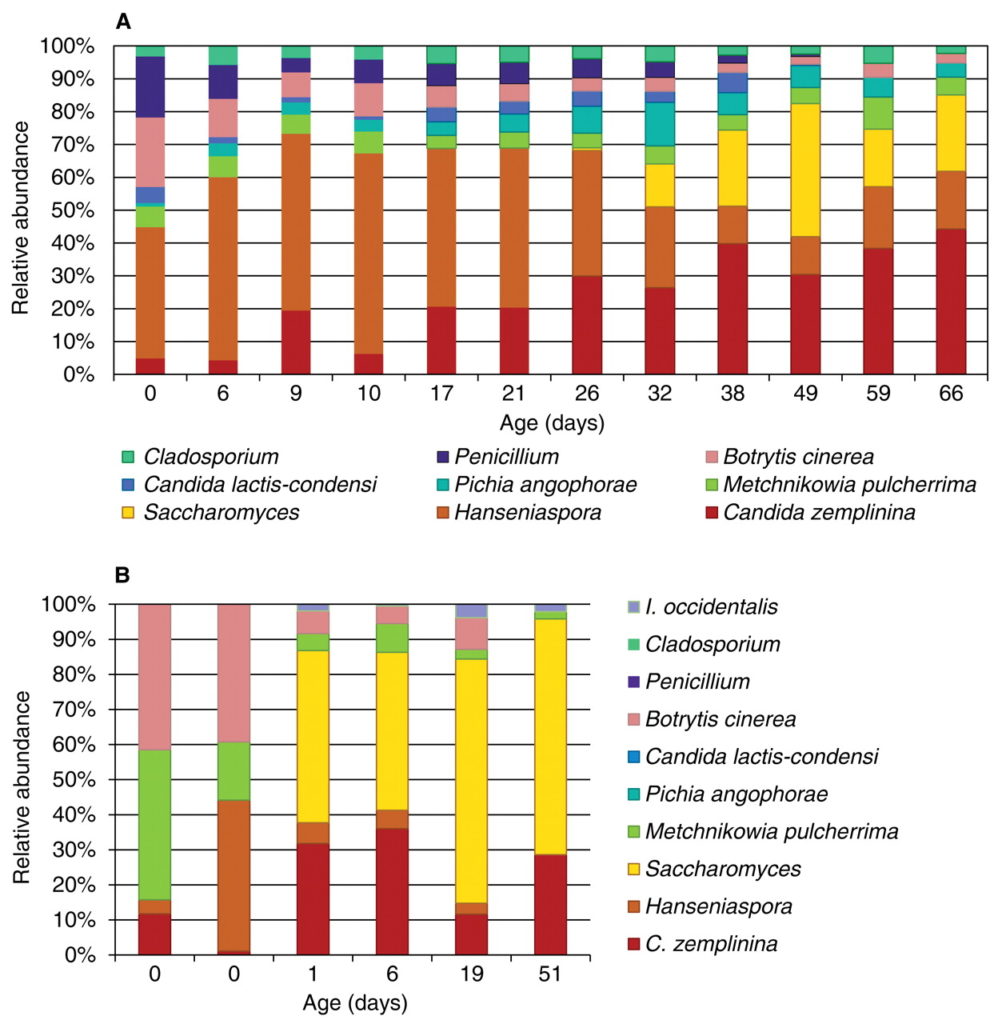
Spero sia chiaro che in tutto ciò entrano in gioco un gran numero di variabili, che cambiano in modo consistente il risultato finale (le caratteristiche del vino). L’enologia non è certo una materia semplice: la conoscenza è fondamentale per non procedere troppo pericolosamente in balia del caso (non sempre benigno). In fondo, siamo o no professionisti-artigiani del nostro lavoro? Entrano in gioco, positivamente o negativamente, lo stato sanitario delle uve, la disponibilità di nutrienti azotati, la pulizia di attrezzature ed ambiente, le temperature, il contatto più o meno spinto con l’ossigeno, ecc., oltre che (naturalmente) l’aggiunta eventuale di solforosa e l’inoculo col Saccharomyces (atti che cambiano le carte in tavola). Tutti questi fattori influiscono selezionando le varie specie e i ceppi che si alternano nel mosto a condurre la fermentazione.

Sappiamo però chi è che conduce il gioco?
No, è veramente difficile seguire passo a passo l’alternarsi nella vasca. Il produttore sa gestire attentamente la fermentazione con opportuni e calibrati interventi quando questa stenta ad andare avanti, se inizia a sentire certe puzzette sgradevoli, ecc. Non può però sapere con certezza chi conduce il gioco che, come già detto, fra l’altro può anche variare ogni anno. Si è dimostrato anche (in cantine dove sono condotte solo fermentazioni spontanee) che i microrganismi coinvolti cambiano anche passando dalle prime fermentazioni a quelle successive. Nelle prime fermentazioni dell’annata al principio partono i non-saccharomyces, mentre il S. interviene più tardi. Andando avanti con la vendemmia però, quando è ben forte in cantina, il Saccharomyces può diventare predominante subito nelle fasi iniziali.

E il lievito aggiunto? È il diavolo?
Per qualcuno è lo slogan del momento: il lievito indigeno (o no) sembra poter rapidamente designare i vini come migliori (o meno). Tuttavia è come concentrarsi solo sulla punta di un iceberg e non pensare all’enorme massa che sta sotto l’acqua. Per fare un grande vino artigianale di territorio la fermentazione è sicuramente fondamentale ma ci vuole tantissimo prima (in vigna soprattutto) e tanto dopo. Ad esempio, se ho un’uva non equilibrata, perché viene da vigneti che crescono in modo un po’ stentato, posso fare anche fermentazioni spontanee ma otterrò comunque vini poco espressivi. Questo perché nelle uve mancano i “mattoncini” fondamentali che i lieviti dovrebbero usare per fare un grande vino, ma non li trovano!
Aggiungere lievito può essere utile in certe situazioni difficili, senza inficiare in modo significativo le caratteristiche territoriali del vino. La ricerca ha dimostrato che l’inoculo non necessariamente impedisce l’attività iniziale dei non-saccharomyces che arrivano dalla vigna, soprattutto se l’aggiunta viene, ad esempio, un po’ ritardata.
Sicuramente si sa che è molto meglio la diversità delle specie e dei ceppi che l’uniformità. Sicuramente per produrre vino di territorio è meglio evitare tutti quei ceppi selezioni che introducono nel vino particolari caratteristiche, alterando quelle territoriali. Il meglio è aiutarsi, quando serve, con l’inoculo dei ceppi selezionati dalla propria cantina che, qualunque sia la loro provenienza, comunque sono diventati parti integranti del nostro “terroir”. Sicuramente si sa che ogni vino, anche nella stessa cantina, ha la sua storia e le sue necessità, non sempre uniformabili, in tutti i sensi!
Questo intervento è molto generico e divulgativo. Quello che mi preme è far capire l’enorme complessità che entra in gioco in questo processo e che rende tanto affascinante quanto complicato il nostro lavoro. Capirete così anche perché, di norma, il vignaiolo durante la vendemmia dorma con difficoltà, pensando incessantemente a quanto succede nelle vasche. È un piccolo mondo ma vi succedono tante cose!
Se volete scoprire l'incredibile storia di come si è scoperto il ruolo dei microrganismi nella fermentazione potete leggere anche qui, qui, qui e qui.
Focus sui lieviti (un argomento da "prendere con le pinze") 1
Se ne parla tanto oggi, a volte anche a sproposito, trascurando forse gli altri (mille e più) parametri fondamentali per produrre un ottimo vino di territorio. Purtroppo, quando un argomento diventa terreno del marketing più spinto, diventa difficile parlarne con serenità. Purtroppo non si sprecano anche le bufale, a volte così belle e poetiche da far enorme presa nell’immaginario collettivo.
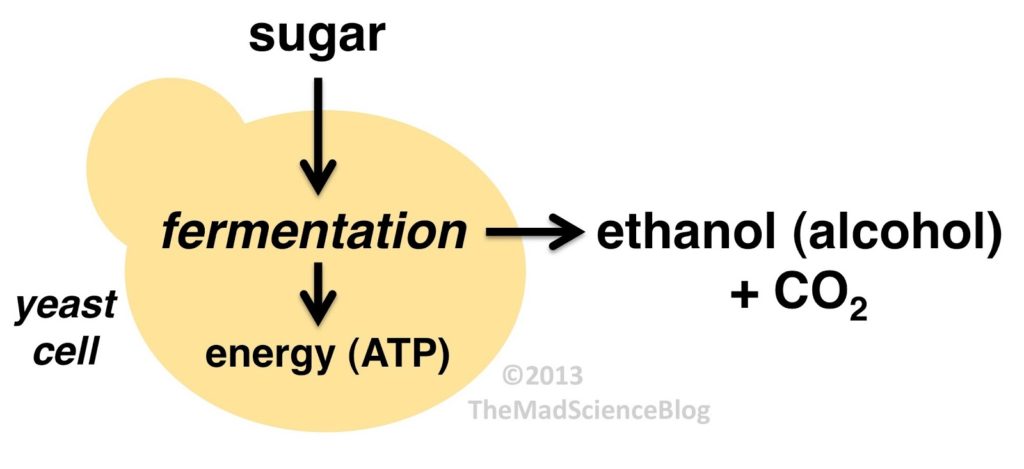
Eppure il lievito non è “nato ieri” ma accompagna l’uomo da almeno 10.000 anni in tante trasformazioni alimentari, anche se l’uso è stato inconsapevole per millenni (vedete qui e qui). Solo nella seconda metà dell’Ottocento Pasteur dimostrò il ruolo dei microrganismi nelle fermentazioni e anche nelle alterazioni del vino (qui e qui). Da allora è iniziato il cammino, ancora in corso, di comprendere questa affascinante e complicata trasformazione.

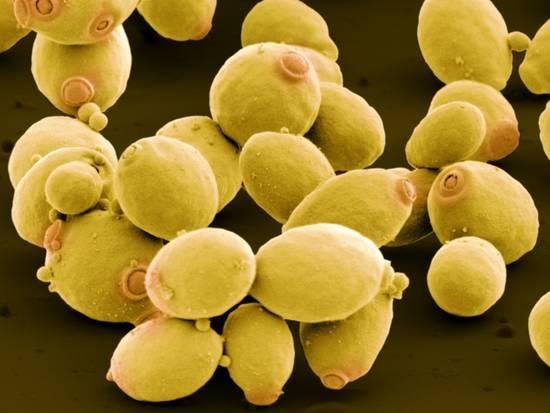
Ci sono ancora tante cose da scoprire e capire. Eppure non siamo più all’epoca in cui la fermentazione era un processo misterioso intorno al quale nascevano anche tante superstizioni, riti scaramantici ed interpretazioni magiche (alcuni dure a morire anche ai nostri giorni). Sappiamo che la fermentazione alcolica è condotta soprattutto dai lieviti del genere Saccharomyces, come il famoso S. cerevisae o il S. bayanus, che a loro volta possono essere rappresentati da diversi ceppi. Questi sono anche i lieviti più adatti a sopportare l’accumulo di etanolo che si crea dalla trasformazione degli zuccheri. Infatti sono gli unici a rimanere in vita e a condurre il processo fino al termine. Questo fatto li rende (quasi) indispensabili.
Non sono però i soli: nel mosto –vino c’è una ricca biodiversità di lieviti e batteri che intervengono più o meno positivamente.
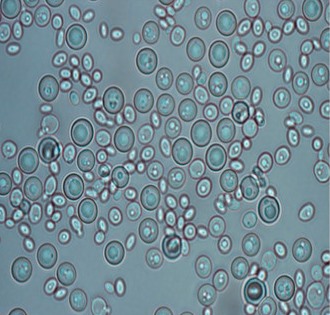
Per fare qualche nome, possiamo ricordare la Candida pulcherrima (bellissima!), i generi Pichia, Cryptococcus, Rhodotorula, Kloeckera… Sono in genere più sensibili all’alcool, per cui molti non riescono a sopravvivere se non nelle fasi iniziali. Eppure sono importanti: è stato dimostrato che questi non-saccharomyces influiscono molto sulle caratteristiche aromatiche del vino, sia positivamente che (a volte) negativamente. Se ben gestiti, donano al vino note uniche, contribuendo in modo significativo alla complessità e personalità del prodotto. Se mal gestiti, possono portare a puzze, acidità volatile eccessiva, ecc. , a far nasce vini veramente poco gradevoli.
Da dove vengono i lieviti?
 I lieviti, come tanti microrganismi utili o dannosi, si trovano un po’ ovunque in natura. Sono stati fatti diversi studi per cercare di capire questo punto, al di là di tanti “simpatici” voli di fantasia cari al marketing. Le ricerche degli ultimi 10 anni hanno dimostrato che molti microorganismi sono presenti sull’uva. La loro quantità e diversità dipende molto da come si è gestito il vigneto, dalla temperatura e dallo stato di sanità dei frutti. Si è visto anche che questo mix di microorganismi cambia con l’annata, è caratteristico del micro-territorio (la vigna) e la varietà di vite. Per questi motivi è stato incluso nel cosiddetto terroir viticolo.
I lieviti, come tanti microrganismi utili o dannosi, si trovano un po’ ovunque in natura. Sono stati fatti diversi studi per cercare di capire questo punto, al di là di tanti “simpatici” voli di fantasia cari al marketing. Le ricerche degli ultimi 10 anni hanno dimostrato che molti microorganismi sono presenti sull’uva. La loro quantità e diversità dipende molto da come si è gestito il vigneto, dalla temperatura e dallo stato di sanità dei frutti. Si è visto anche che questo mix di microorganismi cambia con l’annata, è caratteristico del micro-territorio (la vigna) e la varietà di vite. Per questi motivi è stato incluso nel cosiddetto terroir viticolo.
Non è facile però stabilire le quantità e qualità in singole prove empiriche. Si è visto infatti che i campionamenti cambiano molto, pur nella stessa vigna, se fatti in un modo o nell’altro. Solo confrontando un numero elevatissimo di studi diversi è possibile trarre delle conclusioni più generali. (Questa si chiama RICERCA, fatta per bene).
Sulla superficie di un acino perfettamente integro ci sono pochissime sostanze nutritive per cui qui si trovano pochi microorganismi, quelli un po’ pionieri, capaci di sopravvivere in questa situazione limitante. Molti di questi non sono i microrganismi che conducono la fermentazione alcolica perché per vivere dipendono dall’ossigeno. La fermentazione alcolica invece è una reazione che avviene in assenza di questo gas (si dice “in anaerobiosi”).
La maggior parte dei microorganismi che interessano la fermentazione si trovano soprattutto su acini danneggiati (per i più diversi motivi). Infatti solo con la fessurazione della buccia possono trovare quei composti nutritivi essenziali per la loro sopravvivenza e l’ambiente adatto per loro.
Qui serve però un distinguo: parafrasando i latini dobbiamo dire che “in minimo stat virtus”. È vero che l’uva più danneggiata ha un biodiversità e carica microbica maggiore, ma questo non significa che sia la condizione migliore per la vinificazione, attenzione! In un’uva molto sana (la migliore da vinificare) c’è comunque una piccola percentuale di acini con micro-fessurazioni da portare una quantità più che sufficiente di microrganismi in cantina. L’uva poco sana è sempre negativa, sia per le proprie caratteristiche non ottimali che per una carica microbica fortemente alterante.
Comunque le ricerche hanno dimostrato che questa piccola folla che ci portiamo in cantina nei cesti d’uva è composta soprattutto dai fermentatori delle prime fasi. Clamorosamente è pochissimo rappresentato quello che diventerà il protagonista quasi assoluto quando il “gioco” si farà duro: il Saccharomyces!
Da dove arriva allora?
(prosegue)
Di vini che non ci saranno.
 Come abbiamo già anticipato, i nostri Rossi più importanti, Atis e Jassarte 2014 non ci saranno. Sarebbero dovuti uscire al commercio nei prossimi mesi, con la presentazione a Vinitaly.
Come abbiamo già anticipato, i nostri Rossi più importanti, Atis e Jassarte 2014 non ci saranno. Sarebbero dovuti uscire al commercio nei prossimi mesi, con la presentazione a Vinitaly.
Da noi il 2014 è stata una vendemmia molto difficile. Fortunatamente ce ne sono pochissime in questa meravigliosa Bolgheri, ma a volte capitano.
Cos’è un’annate difficile? È un annata in cui gli eventi climatici contrari si sommano a tal punto da non permettere l’originarsi del Particolare, di far nascere quei vini di selezione dove lo “Spirito del Luogo” si manifesta in tutta la sua magnificenza. Il 2014 è stata una di queste.
È stato un anno in cui la nostra bella estate non si è praticamente vista, sostituita da una cappa grigia d’umidità quasi continua, finita con una vendemmia sotto la pioggia. Il meglio delle uve, che abbiamo curato e selezionato con lavoro certosino in vigna, ha meritato di far nascere buoni vini di grande finezza, i nostri Rossi base, ma non le Selezioni.
 Il vino per me è assolutamente di territorio, che significa mettersi al servizio di esso, agevolare una trasformazione che ti sorprende sempre. Un grande vino di territorio è qualcosa che non puoi comprendere fino in fondo neppure quando è nato, perché non smette di mutare e trasformarsi nel tempo che passa.
Il vino per me è assolutamente di territorio, che significa mettersi al servizio di esso, agevolare una trasformazione che ti sorprende sempre. Un grande vino di territorio è qualcosa che non puoi comprendere fino in fondo neppure quando è nato, perché non smette di mutare e trasformarsi nel tempo che passa.
Il vino, naturalmente, non nasce solo in vigna ma anche in cantina. L’assoluta cura del nostro lavoro e delle scelte fatte, nell’uno e altro ambito, sono fondamentali. Un conto però è la cura che porta ad esaltare le qualità, un conto è stravolgerle.
Annate così difficili, per i grandi Rossi di Selezione, non le “salveresti” comunque intervenendo in cantina. Le stiri, le giri e le rigiri, puoi renderle tecnicamente perfette, ma non puoi tirare fuori quel qualcosa di più e di meglio (“quell’anima”) che nelle uve semplicemente non c’è. Non è questione di saperlo fare o meno.
Secondo me, avere una grande capacità tecnica nel fare vino non significa intervenire ad ogni costo, ma riuscire piuttosto a capire quando è meglio fermarsi. Ho troppo rispetto per Atis e Jassarte per maltrattarli in questo modo.
 Fare questa scelta non è mai facile per un’azienda di vignaioli. Noi viviamo di questo lavoro, sentiamo la responsabilità nei confronti dei nostri figli, dei nostri collaboratori e delle loro famiglie. In questo periodo di vuoto c’è chi si scorderà dei nostri grandi rossi, che li sostituirà con altro. Pazienza, sono convinto che si recupererà.
Fare questa scelta non è mai facile per un’azienda di vignaioli. Noi viviamo di questo lavoro, sentiamo la responsabilità nei confronti dei nostri figli, dei nostri collaboratori e delle loro famiglie. In questo periodo di vuoto c’è chi si scorderà dei nostri grandi rossi, che li sostituirà con altro. Pazienza, sono convinto che si recupererà.
In attesa di Atis e Jassarte della grande annata 2015, godiamoci ora le ultime bottiglie dell’ottimo 2013 e le altre storiche.
Michele Scienza
WineNews sul Mercato FIVI di Piacenza
Ecco un video sulla Mostra Mercato dei Vignaioli Indipendenti FIVI di Piacenza 2017.
Parla anche Michele Scienza, dal minuto 4.58
http://www.winenews.tv/index.php?wnv=8238